|
La vita è piena di sorprese
|

 Mi chiamo Ada, ho 60 anni, fisico abbastanza asciutto, capelli ricci di colore castano brizzolati di bianco, grandi occhi scuri. Mi chiamo Ada, ho 60 anni, fisico abbastanza asciutto, capelli ricci di colore castano brizzolati di bianco, grandi occhi scuri.
Attraverso via Genova e respiro con affanno l'aria di Torino, il capoluogo in cui sono nata e vissuta.
Mi guardo intorno intimorita, schiacciata da una paura fissa che non mi abbandona più.
Non ce la faccio a continuare! Vorrei gridare a chi mi passa vicino.
Non riesco a togliermi di dosso il freddo che, dopo un'inaspettata telefonata, mi ha invaso dalla testa fino ai piedi.
Il cuore continua a battere come un tamburo e dinnanzi mi scorrono immagini sconvolgenti.
Una fitta insistente sta per trapanarmi il cervello e mi offusca la vista. Mi sento schiacciata da un peso insostenibile di ansie e domande pressanti mi lasciano senza fiato.
Non mi rincuorano la temperatura abbastanza mite e il sorriso degli anziani che vagano sotto il braccio delle badanti.
Cani di piccola taglia che seguono trotterellando i loro padroni, infagottati in cappotti spessi e quadrettati, mi sbarrano il passaggio. Ogni tanto si fermano ad annusare le foglie secche abbandonate sui marciapiedi, sulle piazzette e non vogliono proseguire.
Un'amarezza troppo grande mi opprime e anche Torino, costretta a lasciare la divisa di importante centro industriale, mi sembra un po' sofferente.
La gente riempie le strade. Nell'incrociarla sento parlare di crisi economica, prezzi delle case, figli da crescere e bollette da pagare. Sarà l'influenza del Natale ormai vicino, ma tutti sembrano sereni, pronti a godere le ultime giornate del 2014.
Vorrei avere i loro problemi al posto della gran voglia di piangere che mi cresce dentro.
In contrasto al mio pessimo umore dai vetri delle pasticcerie e delle caffetterie avanza il luccichìo degli alberi coperti di palline colorate e di variopinti pacchi dalle mille sorprese.
Non sono più sicura di aver fatto bene a uscire. Ho paura, è come se mi trovassi per la prima volta da sola in città.
Non è il frastuono delle macchine, delle biciclette, dei tram a rendermi nervosa, ma il terrore che il telefonino si rimetta a suonare.
Adagiato nello scomparto laterale della borsetta, lo osservo con la stessa ansia con cui controllerei una bomba pronta a scoppiare da un momento all'altro.
Se, all'improvviso, si facesse di nuovo sentire e una voce, femminile o maschile, dicesse pronto, dovrei parlare con la signora...la mia vita potrebbe cambiare completamente e niente sarebbe più come prima.
Un tempo lo dimenticavo nel tinello, attaccato alla ricarica o tra i cuscini del sofà del salotto. Ora lo porto sempre con me come un compagno inseparabile e, nello stesso tempo, temibile.
Sono diventata come la mia amica d'infanzia che, con due figli all'estero, lo tiene di continuo nella taschina dei pantaloni.
Avanzo a passettini, ansimando e, a tratti, mi sembra di cadere.
Mi dirigo verso l'ospedale Molinette che è davanti a casa mia, ma il bisogno di ingerire subito qualcosa di caldo mi costringe a fermarmi nel bar che hanno appena aperto.
Entro in una saletta non molto grande, piena di persone che parlano fitto fitto, sottovoce e la proprietaria, dal fare cordiale, subito si avvicina per servirmi. E' bassa, robusta, sfoggia una casacchina rossa bordata di bianco che le conferisce un'aria sbarazzina, quasi infantile.
Le guance paffute e il sorriso smagliante sono in sintonia con il sobrio ambiente che la circonda.
Un grande specchio dalla cornice argentata riflette una capiente credenza laccata di bianco con impiallacciatura in mogano, lucide sedie trasparenti di attuale design e uno scintillante lampadario con decine di bracci flessibili in cromo.
Un filo dorato, tempestato di lampadine a intermittenza, circonda il banco di forma ovale a effetto metallo e le chiare mensole sistemate con buon gusto sulle pareti tappezzate di stampe di buona fattura.
Tra le tante una raffigura una singolare pianta della città di Torino, dal sapore antico, di un marroncino sbiadito, in netto contrasto con la modernità del luogo.
La grande porta si apre di continuo e il mio sguardo inquieto si concentra sui nuovi venuti, quasi tutti medici e di bell'aspetto.
Nelle condizioni in cui mi trovo non ho alcuna intenzione di prestare attenzione ai loro discorsi.
Fortunatamente solo qualcuno parla di malattie e di cure, i più si limitano a semplici battute sul tempo e sull'economia.
Sono frettolosi e subito lasciano il posto ai colleghi, individui attempati dai cui eleganti cappotti fuoriescono pantaloni di ottimo tessuto.
I più giovani in abbigliamento casual, nell'attesa di essere serviti, non alzano neppure lo sguardo e fanno scorrere sotto le dita lunghe e sottili lo schermo dei loro iPhone di ultima generazione.
Uno dai capelli bruni, arruffati alla Lucio Battisti, di colpo, mi fa tornare in testa l'immagine di un mio compagno di tram, appassionato di medicina che da anni non vedo più e con cui ho diviso indimenticabili momenti di gioventù.
Non so se sia riuscito a indossare il camice bianco, ma ancora ricordo quanto l'abbia sognato.
Il parlare con lui o vedere un film insieme mi farebbe sicuramente bene!
I particolari intorno mi distolgono da quel ricordo.
Poiché non lavoro più, non rimango attaccata al bancone vicino agli studenti impazienti, ma mi siedo al tavolino. Ordino un caffè e mi butto su La Stampa, infilata in un'asticella di legno per facilitarne la lettura.
La setaccio da cima a fondo con la stessa avidità dell'uomo che, a due passi da me, sta divorando un panino traboccante di prosciutto e di formaggio.
Per un quarto d'ora non alzo gli occhi dal quotidiano e mi soffermo pure sulla cronaca cittadina. Da un po' di giorni la zona in cui abito è alla ribalta per le rapine negli alloggi. Con la tensione che ho addosso anche gli argomenti che prima mi coinvolgevano appaiono incredibilmente estranei.
Non ho voglia di commentarli con la gentile anziana che, accanto a me, ha intenzione di iniziare una conversazione.
Mi volto solo per sorridere alla piccola che, caramella in bocca, si sta accomodando sulle ginocchia della mamma in attesa della cioccolata calda.
Per brevi istanti ritorno ai momenti felici della mia famiglia.
Un galletto in legno comprato in Valle d'Aosta durante una gita con i miei dalla cresta di un rosso vivo, alta, fiera, si stampa nella memoria.
Per tanti anni aveva guadagnato la postazione centrale del tavolo del salotto, adagiato su un centrino di pizzo!
Una tenerezza profonda mi stringe il cuore, ma, di colpo, un discorso rubato nei giorni di Natale di circa mezzo secolo fa tra le fessure della porta a soffietto della cucina, non mi fa rimpiangere la mia infanzia.
“Mi hai stufato con questa lamentela! Lavoro tutta la settimana e se poi esco con i miei amici qualche volta, cosa c'è di male?” diceva mio padre con il suo solito fare pacato da persona per bene.
“Non sono amici, sono donne...” replicava la mamma con un filo di voce, quasi per nascondere alle sue stesse orecchie la dura verità.
Io, di scatto, mi ero fermata tra le due librerie per nascondermi e, improvvisamente, una vampata di rossore mi assalì il viso.
La mamma, credendomi in camera, aveva proseguito:
“Non puoi spendere il tuo dispendio così! Ada sta crescendo e i soldi devono servire per lei...”.
Mio padre non aggiunse altro, uscì e un'angoscia opprimente avvolse le pareti, i mobili e il caro soprammobile scaraventato sul pavimento.
La bella cresta si frantumò in tante schegge e il becco schizzò sotto il sofà. Lui non lo raccolse, chiuse di schianto la porta dietro di sé e per me niente fu più come prima.
In quel preciso istante entrambi perdemmo la nostra identità: papà non era più il mio principe azzurro e io non sarei mai più stata la sua principessa!
Non lo aspettai più con ansia che tornasse dal lavoro, non pensai più ai suoi turni di notte nella lontana officina dove, come sosteneva, la produzione non veniva mai interrotta.
Andai a dormire piangendo e non chiesi alcuna spiegazione. Tutto mi fu tristemente chiaro e lasciai che una grande amarezza mi scavasse solchi profondi dentro l'anima. In essi, come nel letto di un fiume, giorno dopo giorno, si depositarono dubbi, insicurezze e grandi vuoti.
L'indomani mattina non domandai nulla neanche del galletto e del grigio vassoio di peltro che lo sostituiva...
Quattro anni dopo, sedicenne, quando una domenica pomeriggio la mamma, in presenza delle mie compagne di scuola, mi rimproverò per essere rientrata tardi dopo il cinema, replicai con rabbia e crudeltà:
Non farmi prediche, pensa piuttosto a chi hai sposato!
Non rispose. Davanti a me adolescente si rivestì della severa compostezza che mantenne per tutta la sua vita. Non si lamentò mai né con i suoi parenti né con le sue amiche, ma quando qualcuno con ingenuità o sarcasmo le faceva notare che aveva avuto la fortuna di avere accanto un uomo estremamente gentile, lei con garbo rispondeva:
“Avete ragione, sa amare tanto!”.
Apriva i suoi grandi occhi luccicanti e quasi sempre ricorreva al fazzoletto per arginare l'insorgenza del raffreddore...
La dignità della famiglia doveva risultare salva davanti a tutti!
Da sempre ho cercato di chiudere definitivamente in un cassetto questi dettagli ma proprio ora ritornano più vivi che mai.
Il tintinnio di un cucchiaino caduto a terra mi distoglie dai miei pensieri e l'arrivo di due conoscenti mi costringe a ritornare alla realtà.
Prima di quella telefonata mi sarei fermata volentieri a parlare con loro, adesso voglio solamente barricarmi nella mia solitudine.
Per questo come se qualcuno mi stesse aspettando, pago il conto ed esco.
Giuseppina Valla
Biblioteca
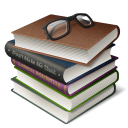
|
Acquista

|
Preferenze

|
Contatto

|
|
