|
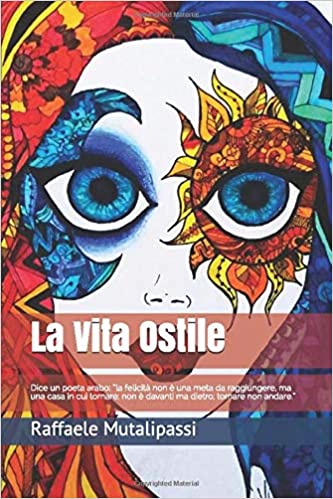  Le origini
Le origini
Mia madre dice che la sera in cui venni al mondo mio padre arrivò da Salerno con una macchina carica di ogni ben di Dio e che quasi tutto il paese fece festa fino a notte fonda. Era venerdì 7 di settembre del 1951.
A quel tempo i figli si facevano in casa con l'aiuto della levatrice e del medico condotto: appena nato cominciai a piangere disperatamente e non la smisi fino a quando non mi fecero ciucciare una - pupatella - (un pezzetto di stoffa di lino con dentro dello zucchero, il tutto imbevuto nella camomilla) e mi fecero assaggiare del cioccolato e del cocomero. Evidentemente volevo festeggiare anch'io.
Quella casa fu acquistata e ristrutturata da mio padre e si trova lungo l'unica strada di accesso al mio paese: Vatolla, una frazione del comune di Perdifumo. Il Cilento, che occupa la parte più meridionale della provincia di Salerno, allora era incontaminato e selvaggio. Il paese era abitato da non più di mille anime divise tra quattro o cinque gruppi familiari.
Durante la buona stagione dalla parte opposta dell'ingresso della casa, dal balcone o attraverso le finestre, si possono scorgere montagne, colline e scoscesi declivi dove nel tempo sono stati ricavati orti e piantagioni che poi si gettano nel mare di Acciaroli e Pioppi: considerato da molti il più bel mare d'Italia.
Pioppi, in particolare, è considerata la capitale mondiale della dieta mediterranea giacché è proprio qui che lo scienziato americano Ancel Keys portò avanti i suoi studi sulla gastronomia locale ottenendo dall'Unesco, nel 2010, il riconoscimento di Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.
Vatolla e Perdifumo. Sullo sfondo il mare di Agropoli.
Vatolla è il paese dove visse ed elaborò le sue teorie filosofiche Giambattista Vico. Un piccolo paese per un grande pensatore, tutto raccolto attorno al castello De Vargas Machucca dove il marchese Domenico Rocca chiese al Vico di svolgere attività di precettore per i figli. La casa dove sono nato si trova a circa cento metri dal castello.
Come vuole la tradizione della nostra terra mi fu imposto il nome di Raffaele dal mio nonno paterno. Mia madre questo non l'ha mai accettato e per dispetto mi ha sempre chiamato Lello. Mio nonno Raffaele, detto Don Lele, nacque nel 1874 e mori nel 1962. Me lo ricordo seduto su una panchina vicino al castello De Vargas con il suo bastone e i suoi grandi baffi bianchi. Mi scrutava con severità e mai mi salutava, non ricordo mai di aver ascoltato la sua voce o di aver ricevuto un suo sorriso.
Aveva fatto il contadino tutta la vita lavorando la terra ereditata dalla propria famiglia. Coltivava frutta, ortaggi e cereali e produceva vino e olio che poi andava vendendo soprattutto nei mercati dei paesi vicini. Durante l'epoca fascista vinse la battaglia del grano nella provincia di Salerno anche perché mia nonna gli aveva dato dodici figli di cui dieci sopravvissuti alle insidie di quei tempi e due che morirono appena nati.
Antonia, questo era il nome di mia nonna che tutti chiamavano Antonietta, aveva sedici anni meno di mio nonno essendo nata nel 1890. Era una donna molto attiva, simpatica e buona: era il motore sempre acceso della comunità familiare. Piccolina aveva sempre un sorriso e qualcosa da donare a tutti. Piena di quella saggezza contadina che si è ormai perduta.
Mio padre prima della guerra
Famosa era la sua - cascetedda - (cassetta) dove riponeva qualsiasi cosa: dai soldi, al mangiare. Ogni volta che tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta la mia famiglia, come consuetudine delle genti del Sud, andava a passare le vacanze di agosto per ritrovarsi con i parenti tutti insieme al paese, mi regalava qualcosa di soldi che poi mi veniva regolarmente sequestrato da mio padre e qualcosa da mangiare: mi ricordo le alici fritte, che buone! Quelle, le alici, mio padre me le lasciava, non gli interessavano.
Sempre ho pensato che quella - cascetedda - che sicuro doveva esistere ma che non vidi mai, dovesse essere molto grande se è vero, come era vero, che lei elargiva i suoi regali a me come a tutti gli altri suoi nipoti, una ventina in tutto.
Durante l'ultima di quelle vacanze di agosto, credo fosse il 1962, vidi per l'ultima volta mio nonno che di lì a poco sarebbe deceduto e mia nonna che non avrei mai più rivisto e che poi mori nel 1980.
Mio padre, Dionigi, era il secondogenito di dieci fratelli, sei maschi e quattro femmine. Classe 1912, fisicamente assomigliava moltissimo a sua madre, era piccolo con un sorriso accattivante. In quanto al carattere era completamente differente, opposto direi. Sicuramente di carattere aveva preso da suo padre.
Aveva frequentato la terza elementare che per l'epoca non era niente male e poi fu inviato in una grande e famosa sartoria di Napoli ad apprendere il mestiere del sarto. Al termine del corso triennale quando fu indetto il concorso di taglio e cucito tra tutti i partecipanti al corso gli fu conferita la forbice d'oro come migliore degli allievi. Ma evidentemente per lui, dotato di un certo spirito di iniziativa, quella del sarto era una vita che gli andava stretta.
Quando sono nato aveva trentanove anni. Era arrivato al matrimonio avendo già vissuto più della metà di quella che sarebbe stata l'intera sua vita. Era uno di quelli che come si dice si era fatto da solo. Dal carattere scontroso e irascibile aveva quasi tutti i difetti che una donna non vorrebbe mai vedere nel suo uomo: sciupafemmine, fumatore incallito, bevitore, anche se io non l'ho visto mai ubriaco, giocatore di carte.
Ma il difetto più grande che aveva era l'avarizia. Sintomatico in questo senso era il suo rapporto con le sigarette. Era capace di fumarne quaranta al giorno però dovuto all'avarizia non comprava, come sarebbe stato logico, due o almeno un pacchetto di sigarette alla volta ma le comprava sfuse. Mi faceva fare non so quanti viaggi al giorno dal tabaccaio.
Non so chi fosse che me lo disse ma lui si fumava anche le - ossa - delle sigarette. Effettivamente aveva ragione, non so come facesse però riusciva quasi a terminare per intero le nazionali senza filtro che fumava. Delle cicche non rimaneva quasi niente forse due o tre millimetri prima che venissero gettate via. Avrei potuto riconoscere una cicca di mio padre fra mille.
Fu durante uno di questi viaggi che di ritorno dal tabaccaio, in compagnia di un mio amichetto, per la prima volta in vita mia accesi una sigaretta. Chissà, dovevo avere sette o otto anni.
Lui aveva già vissuto delle relazioni amorose importanti prima del matrimonio con mia madre: sembra che io e mio fratello non siamo stati i soli suoi discendenti ma abbiamo una sorella maggiore nata da una precedente relazione con una signora sposata del paese. Secondo le stesse dicerie un'altra ragazza per colpa sua si sarebbe fatta suora. Questo non mi sorprende: lui con il suo carattere era capace di calpestare tutto e tutti.
Il fatto è che lui, oltre a tutti quei difetti, era anche ambizioso e si voleva superare uscendo dalla noia e dall'abbandono della vita del piccolo paese. Iniziò a lavorare aprendo una sua sartoria però subito comprese che quella non poteva essere la strada per evadere dal paese e fare i soldi.
Nella sua sartoria aveva tre ragazzi che l'aiutavano a cucire. Lui come maestro solamente tagliava e impostava le cose poi i ragazzi si incaricavano di terminare il lavoro. Per cui contemporaneamente aprì anche una drogheria dove cominciò a vendere i prodotti agricoli che produceva suo padre.
Una volta sposato vendette la sartoria e la drogheria di Vatolla e ne comprò un'altra a Salerno, al Vicolo del Pesce, dove in quella zona c'erano altri paesani dei suoi che avevano aperto altre attività commerciali similari. La sera della mia nascita quando lui arrivò con la sua macchina affittata piena di leccornie per festeggiare, era appunto da lì che proveniva.
Dato che gli affari alla drogheria di Vicolo del Pesce cominciarono a girare abbastanza bene, mio padre cominciò a salire nella considerazione dei paesani che di lì a poco lo avrebbero soprannominato - il martelluccio d'oro - .
Come di consueto, accanto all'apprezzamento di molti si manifestarono anche le invidie e le avversioni di altri. Però a lui non interessava, andava dritto per la sua strada.
Dato il successo che stava avendo con la drogheria di Salerno, un altro commerciante, Don Fonso che aveva anche lui una drogheria a Santo Mango, il paese di mia madre, gli chiese di entrare in società per aprire una drogheria più grande a Salerno dove Don Fonso voleva sistemare il suo unico figlio Giorgino, poco più che un ragazzo.
L'occasione fu data dal fatto che una delle più grandi e tradizionali pizzicherie di Salerno, quella di Via Tasso, fu messa in vendita dagli antichi proprietari che volevano ritirarsi da quella attività.
Insieme ai prodotti agricoli mio padre comprava anche altri prodotti lavorati come formaggi e salumi e li trasportava e li rivendeva non solo nella sua pizzicheria ma anche nei paesi limitrofi e a Salerno. Non lo so con certezza, però penso che lui, in realtà, facesse contrabbando di quei prodotti, specialmente subito dopo la seconda guerra mondiale.
Durante quello stesso periodo non disdegnava cambiare i dollari delle molte rimesse degli emigrati italiani dagli Stati Uniti che molte famiglie ricevevano: lui pagava quei dollari in lire a queste famiglie ad un cambio molto basso per poi rivendere quegli stessi dollari a Napoli al cambio ufficiale molto più vantaggioso.
Lui la guerra l'aveva scansata grazie ai favoritismi di gente di potere che aveva corrotto soprattutto elargendo regali di quei prodotti alimentari che in quell'epoca cominciavano a scarseggiare e che per questo erano molto apprezzati. Fece per circa un mese il furiere di fanteria a Cava dei Tirreni andando e venendo da Vatolla fino a quando a forza di prosciutti e formaggi si fece congedare.
In tutti i casi il prezzo pagato dalla sua famiglia sull'altare delle vicende della grande guerra non fu certo trascurabile.
Il primo dei fratelli Angelo fece il servizio militare in Italia. Il terzo fratello Antonio nell'ottobre del 1942 faceva parte della mitica Divisione Ariete, partecipò allo scontro di El Alamein tra le truppe degli alleati che sconfissero le forze dell'Asse: sì, proprio quella, la battaglia che tutti gli italiani sono fieri di aver perduto. Dopodiché per mio zio Antonio seguirono quattro anni di prigionia in Somalia prima del suo rientro al paese.
Il quarto fratello Arturo fu dichiarato disperso durante la campagna italiana di Russia. Molti anni dopo dal ministero degli interni fu comunicato che i resti di mio zio Arturo erano stati rinvenuti in una fossa comune in una località sulle sponde del fiume Don. Nel 2017 il comune di Perdifumo con una cerimonia pubblica ha dedicato una strada ad Arturo Mutalipassi.
Quando i due si sposarono nel 1950 mio padre aveva vent'anni più di mia madre: lui trentotto e lei diciotto. Era stato un matrimonio combinato. Mia madre era appena uscita dal collegio delle monache di Vallo della Lucania dove sua madre e suo fratello maggiore l'avevano rinchiusa subito dopo la morte di suo padre, mio nonno. Era una ragazza molto sensuale: più alta di mio padre, tipo mediterraneo con capelli lunghi corvini, labbra e bocca pronunciate e un corpo prorompente tipo Sofia Loren di cui è quasi coetanea.
Contatti tra le due famiglie ce n'erano già stati. Mio nonno Raffaele allo stesso modo che negli altri paesini limitrofi andava a vendere i suoi prodotti anche a Santo Mango, distante quattro chilometri da Vatolla, il paese dove viveva la famiglia di mia madre e di cui era fornitore esclusivo e diretto. Però galeotto fu un cugino di mio padre che voleva fargli conoscere una cugina di mia madre che si chiamava Clara che, diceva, era adatta a lui. Quando i due cugini si recarono a Santo Mango per incontrarla mio padre accanto a Clara notò sua cugina, mia madre, che era poco più che diciassettenne.
Fu un colpo di fulmine. Mio padre probabilmente si invaghì della ragazza dalla prima volta che la vide e senza indugi mandò emissari a parlare con Donna Fonsina per chiedere la mano di mia madre. Il padre di mia madre era già morto. Dopodiché, mio padre, un giorno, si presentò a casa di Donna Fonsina con tutta la sua famiglia, padre e madre, e tutti i suoi fratelli ognuno dei quali portava alla famiglia della sposa gioielli e altri doni. Mio padre naturalmente portò in dono l'anello di nozze, un diamante. Seduta stante si fissarono così la data delle nozze e gli altri accordi di circostanza.
Per lui, a parte il fatto di possedere - sottolineo la parola possedere - una moglie giovane e bella, quel matrimonio rappresentava un altro passo verso la scalata sociale dato che mia madre tra l'altro apparteneva a una delle famiglie più in vista di Santo Mango.
La famiglia di mia madre era costituita dal padre Francesco, detto Don Ciccio classe 1877, da sua madre Alfonsina classe 1895, detta Donna Fonsina e da quattro fratelli: il primogenito Manlio classe 1915 e le altre sorelle Gilda 1918, Ines 1920 e mia madre Maria nata nel 1932.
Quando Maria nacque Don Ciccio aveva cinquantacinque anni e Donna Fonsina trentasette mentre l'ultima delle sorelle, Ines, già aveva compiuto i dodici anni. Maria era la figlia che era venuta al mondo senza essere voluta, era stato uno scherzo del destino, se così si può dire. Per questo Maria crebbe in un ambiente non particolarmente adatto a lei. A parte la rilevante differenza di età che incideva negativamente nei rapporti interpersonali con gli altri membri della famiglia, lei non si sentì mai accettata, in particolare da sua madre. Per tutta la vita mia madre ha odiato mia nonna accusandola di egoismo e di preoccuparsi soprattutto delle vicende del figlio primogenito Manlio.
In questo contesto la piccola Maria crebbe forgiando un carattere ribelle tanto che nel paese la soprannominarono - la terribile - . Alle elementari per lei le punizioni erano all'ordine del giorno. Bisogna ricordare che a quell'epoca, anni Trenta del secolo scorso, le punizioni inflitte dai maestri ai bambini erano atroci: questi venivano costretti per ore ad inginocchiarsi su uno strato di gran turco con i polsi legati dietro la schiena.
1936 Santo Mango: mia madre.
Gli unici che le mostravano attenzione erano suo padre e sua nonna Pizza, la madre di Don Ciccio, che viveva in un'ala separata nella stessa casa. In effetti nonna Pizza era andata a vivere insieme al figlio Francesco da quando quest'ultimo aveva deciso di ritornare a Santo Mango di rientro dagli Stati Uniti dove era emigrato e aveva lavorato per molto tempo insieme agli altri suoi fratelli. Pizza diceva che tutti gli altri fratelli che erano rimasti in America si potevano aiutare gli uni con gli altri e quindi lei doveva aiutare a Ciccio suo che era da solo nelle grinfie della nuora. Per questo Pizza odiava Fonsina e sistematicamente gli faceva mille dispetti. Fonsina però ha sempre sopportato in silenzio questa situazione senza mai una reazione od una lamentela verso Don Ciccio.
Nonna Pizza da ragazza era bellissima. All'età di sedici anni era stata rapita e poi portata all'altare, con un matrimonio riparatore, da suo marito Peppe de' Jontili. Il soprannome de' Jontili era sintomatico del fatto che Peppe, anche lui, era un uomo bellissimo con occhi chiari e capelli ricci e biondi. Pizza e Peppe de' Jontili ebbero in tutto otto figli, quattro maschi e quattro femmine. Francesco, mio nonno, era il terzo dei fratelli maschi.
Peppe de' Jontili era un mercante di maiali e per questo con le sue bestie girava per tutti i mercati del Cilento. A quell'epoca il mercato più importante era quello che si teneva mensilmente a Mercato Cilento che dista circa 6 chilometri da Santo Mango dove risiedeva la famiglia di Peppe e Pizza.
La vigilia di un giorno di mercato che si sarebbe dovuto tenere a Mercato Cilento, Peppe de' Jontili incaricò il suo primogenito Mosé di andare a portargli dei maiali che dovevano essere venduti al mercato. Lui, il padre, lo avrebbe raggiunto il giorno successivo con altri maiali. Mosé però non giunse mai a destinazione. Durante il tragitto per andare a Mercato Cilento, in compagnia di alcuni suoi amici, si ubriacò e fu derubato di tutte le sue bestie. Quando Mosé tornò a casa da sua madre e le raccontò l'accaduto, Pizza diede al figlio dei soldi e gli disse di scappare a Napoli prima che tornasse il padre e di imbarcarsi per andarsene in America perché se suo padre lo avesse avuto fra le sue mani lo avrebbe ammazzato come un maiale.
Quando, probabilmente intorno al 1890, Mosè prese uno di quei famosi bastimenti che partivano dal porto di Napoli non avrebbe mai immaginato che di lì a pochi anni tutta la famiglia, compresa sua madre, si sarebbero trasferiti negli Stati Uniti, a New York.
Mosè faceva il barbiere e dopo anni di sacrifici era riuscito ad aprire un salone tutto suo. Gli affari gli andavano così bene che chiamò, uno alla volta, tutti gli altri fratelli maschi a lavorare con lui ai quali, a cascata, fecero seguito anche le sorelle. Naturalmente Pizza non poteva lasciare i suoi figli da soli e così anche lei cominciò a viaggiare fra Santo Mango e New York.
New York: la barberia Feola con i quattro fratelli. Mio nonno è il terzo da sinistra.
Tutti i fratelli si fecero cittadini americani meno che Francesco. Nel mezzo del cammin della sua vita decise di far ritorno al paesello a godersela e magari, pensò, a prendersi una qualche rivincita sociale a scapito di quei paesani che avevano da sempre considerato la sua una famiglia di morti di fame.
Don Ciccio quindi fece ritorno al suo paese da ricco come si diceva allora. Sembra avesse con lui più di cinquecentomila lire. Si comprò una delle case più grandi e belle del paese, aprì una barberia che usava più che altro per giocare a carte e bere vino con i suoi compari e si mise alla ricerca di una moglie.
Da considerare che a quel tempo, all'inizio della prima guerra mondiale c'era tanta, ma tanta, fame in giro, soprattutto in un piccolo centro del meridione d'Italia. Per dare un'idea dell'agiatezza della futura famiglia di mia madre, a Santo Mango si diceva che - a casa del barbiere si mangia carne per uova e patate per pane - mentre la dieta della gente comune era basicamente costituita da - pane a vescuotto - (biscotti di pane duro: pane che dopo la cottura veniva lasciato per uno o due giorni in forno ad indurire) castagne e fichi secchi.
Comunque la candidata moglie avrebbe dovuto, possibilmente, appartenere alla meglio borghesia del paese. Ovviamente come era prassi dell'epoca a questa ricerca parteciparono tutte le ruffiane del paese fino a che questa potenziale moglie non fu individuata nella primogenita del proprietario della più grande drogheria di Santo Mango.
Sembrava tutto organizzato però non si erano fatti i conti con Don Giuseppe il quale fu irremovibile nel non cedere una delle sue figlie a quel - morto di fame del barbiere - . Don Ciccio, che non era da meno in quanto a orgoglio, promise a sé stesso che avrebbe preso in moglie nessun'altra se non una delle quattro figlie di Don Giuseppe.
Non appena deceduto il capostipite, la famiglia di Don Giuseppe cadde in disgrazia e quindi si crearono le condizioni affinché una delle sorelle fosse data in moglie a Don Ciccio. La scelta però ricadde su Alfonsina, la minore delle sorelle, e non Giacinta la primogenita.
Alfonsina aveva diciotto anni meno di Ciccio ed era una ragazza cagionevole di salute. Forse questa fu la principale ragione per cui la sua famiglia aveva acconsentito a concederla in sposa a mio nonno. Sembra fosse anemica e per questo i dottori le avevano consigliato di mangiare carne, uova e bere vino.
Mia madre ha sempre sostenuto che questo non corrispondeva al vero e che mia nonna fingeva di stare male. Il suo malessere, tuttora dice, era solo puro egoismo. Io a mia nonna me la ricordo durante una delle mie vacanze di agosto alla fine degli anni Cinquanta che mangiavo ciliegie insieme a lei: io le mangiavo una ad una e lei se le trangugiava a mazzetti, ossi compresi. Abbastanza robusta sembrava un'indiana della tribù dei Sioux con l'attaccatura dei capelli bassa, i capelli neri corvini, occhi piccoli e labbra molto grandi. Nonna Fonsina era molto acculturata, leggeva in continuazione ed era molto religiosa. La gente del paese si rivolgeva a lei per farsi scrivere o leggere lettere ed altri documenti.
Nonna Pizza aveva già lasciato questo mondo da quattro anni quando, nel 1946, mio nonno improvvisamente, nel giro di un mese, morì. Mia madre aveva quattordici anni. Per lei fu un trauma tremendo. Si sentì ancora più sola ed estranea in quella casa.
In quel momento nella casa paterna vivevano sua madre, Donna Fonsina e suo fratello Manlio che si era sposato con sua moglie Lina. Tra la nascita della prima figlia della coppia, Alfonsina che nacque nel 1941, e gli altri tre figli, mio zio Manlio ebbe anche il tempo di partecipare alla guerra in Grecia dove rimase prigioniero per un paio d'anni.
Intanto la prima delle sorelle Gilda già si era sposata nel 1935, a diciassette anni, ed aveva avuto nel frattempo già tre figli, il primo dei quali si chiamava Tonino che nacque nel 1936. Tonino e mia madre erano quasi coetanei e perciò diventarono compagni di giochi e fino a quando la famiglia di mia zia Gilda rimase a Santo Mango lei, mia madre, passava più tempo da sua sorella che in casa propria.
L'altra sorella Ines si era sposata agli inizi degli anni Quaranta e si era trasferita a Colleferro, in provincia di Roma, dove suo marito lavorava alla Bombrini Parodi. Successivamente quando la grande guerra era già scoppiata anche il marito di zia Gilda, Don Peppo, entrò a lavorare alla Bomprini Parodi e per questo tutta la famiglia si trasferì a Valmontone, vicino Colleferro.
Dopo la morte di suo padre il risentimento di mia madre verso mia nonna, se possibile, aumentò ancor di più. Per cui quando sua madre decise di rinchiuderla al collegio delle monache di Vallo della Lucania per lei fu quasi una liberazione.
Quando ne uscì, tre anni più tardi, era già una donna che faceva girare la testa a tutti gli uomini. Aveva molti pretendenti e tra questi, data la sua condizione economica, fu scelto mio padre così come aveva deciso per lei, per liberarsene, sua madre.
Questo matrimonio assurdo non solo segnò l'esistenza di mia madre ma anche le esistenze di mio padre, la mia e di mio fratello. Mia madre si è sempre chiesta: - perché se mi dovevano far sposare mi hanno imposto quel vecchio? - . Si riferiva a mio padre naturalmente.
C'era un rifiuto assoluto nei confronti di mio padre. Mia madre dice che mia nonna le impose mio padre per dispetto. Mia nonna fu irremovibile. Diceva che anche lei si era sposata a Don Ciccio che aveva diciotto anni più di lei e che, forse anche per questo, a lei gli era andata bene col suo matrimonio.
In effetti tutto Santo Mango era contrario a quel matrimonio. Mia madre racconta che mio zio Manlio si era dichiarato contrario. Addirittura mia zia Gilda si rifiutò di presenziare al matrimonio. Anche se nessuno mai si azzardò a fare dei commenti diretti molti in paese tentarono di evitare questo assurdo matrimonio. Molti anni dopo ho avuto sentore che ci fu addirittura un tentativo di organizzare la fuga di mia madre, tentativo evidentemente andato a vuoto.
Si racconta che il giorno del matrimonio tutto il paese fosse come in lutto. Nessuno dei santomanghesi partecipò alla cerimonia. Mentre presenti in massa erano gli invitati dalla parte di mio padre arrivati in massa con diversi pullman da Vatolla. In effetti non esistono fotografie dell'evento: i fotografi di Santo Mango si rifiutarono di fare i consueti servizi fotografici. Di quel matrimonio infatti non è rimasta nessuna traccia fotografica.
1950 Santo Mango: i miei genitori poco prima del matrimonio.
Gli anni '50, l'infanzia
Dopo alcune settimane dal matrimonio la famigliola si trasferì definitivamente a Salerno. Mio padre prese una stanza con bagno e uso di cucina in subaffitto presso la signora Anastasia che era vedova ed aveva una grande casa dove ci vivevano altre due giovani coppie.
Lui continuava indaffarato nella gestione della drogheria di Vicolo del Pesce e mia madre cominciò ad andare alla bottega ad imparare il mestiere. Approfittando della sua avvenenza, mio padre mise mia madre dietro al bancone a contatto diretto con i clienti. La mossa fu quanto mai azzeccata.
Lei apprese rapidamente tanto che il negozio aumentò significativamente i clienti e le vendite. Tutti volevano farsi servire da - Maria la cilentana - . Lei ha sempre avuto una predisposizione naturale per stare a contatto con la gente, ha sempre amato lavorare e ha sempre lavorato instancabilmente tutta la vita.
Io nel frattempo rimanevo in casa accudito dalla signora Anastasia e passavo molto tempo con l'altra inquilina della casa la signora Antonietta. Mia madre dice che l'avevo conquistata e voleva sempre tenermi con sé anche perché non poteva avere figli. Fu l'unica vera conquista femminile della mia vita. Io realmente di quel periodo non ricordo nulla. Solo ricordo che avevo degli incubi: un gallo gigantesco che mi pizzicava in testa. Retaggio della paura che avevo avuto quando, ancora andavo carponi, fui davvero pizzicato in testa da un gallo. Forse il fatto di essere mezzo scemo si deve a questo.
1952 Salerno: io in automobile sul lungo mare di Salerno.
Quando mio padre vendette la drogheria di Vicolo del Pesce e insieme al suo nuovo socio Don Fonso comprò la molto più grande drogheria di Via Tasso, in questa bottega, a parte mio padre, lavoravano il figlio di Don Fonso, Giorgino, un banchista, mia madre e un giovane ragioniere.
Mio padre allora affittò anche un bellissimo appartamento al terzo piano sul lungo mare dove vivevamo noi e Don Fonso con sua moglie e suo figlio. Il lungo mare di Salerno è qualcosa di veramente incantevole tanto che c'è tuttora il detto che se - Salerno avesse o puerto Napoli fusse muerto - . Quando mi lasciai a camminare mia madre cominciò a portarmi con sé al negozio.
Spesso scappavo dalla pizzicheria, attraversavo la strada per andare in una macelleria dove la moglie del macellaio mi aspettava per darmi la - ciccia - . Evidentemente, già da infante, avevo quello spirito di avventura che poi ha contraddistinto tutta la mia vita.
Con la miseria che c'era in giro a quell'epoca era consuetudine segnare, come si diceva allora. Cioè la gente entrava, faceva la sua spesa, il negoziante annotava l'ammontare della spesa in un quaderno e poi si facevano i conti quando il cliente poteva pagare, usualmente a fine mese o quando ne aveva la possibilità. Nel negozio di mio padre era il ragioniere che, oltre a tutte le altre mansioni amministrative, teneva in ordine i conti e conservava il quaderno dei debiti dei clienti.
Una mattina il ragioniere si rivolse a mia madre rivelandole che lui la sera riponeva questo quaderno nel cassetto della sua scrivania e che però la mattina ritrovava il quaderno non come lo aveva lasciato la sera precedente e, cosa più grave, c'era qualcuno che addirittura manipolava i conti. In particolare si poteva notare come le cifre che indicavano i debiti dei clienti venivano modificate ponendo davanti o alla fine del monte dovuto un altro numero di modo che i debiti dei clienti venissero aumentati. Dopo una rapida indagine mia madre e il ragioniere si resero conto che era mio padre l'autore di quelle manipolazioni.
Mio padre aveva comprato un camioncino OM di seconda mano, tipo lupetto o leoncino non si sa, e continuava a commerciare tra Vatolla e Salerno. Partiva con il camion vuoto e tornava la notte con il camion pieno. Secondo me faceva il contrabbando di quei prodotti. Infatti una notte non tornò. Il giorno successivo fece avvisare mia madre dalla questura istruendola di contattare non so quale colonnello della finanza per aiutarlo a farlo uscire fuori da lì, dove l'avevano fermato e sequestrato con il camion e l'autista. Evidentemente l'avevano beccato col camion pieno di derrate alimentari senza documenti di viaggio. All'epoca gli agenti del dazio erano molto efficienti.
Don Fonso, che era già molto anziano e malandato, cominciò a rendersi conto dei metodi di mio padre e quindi gli chiese di sciogliere la società per cui mio padre dovette vendere, a mio nonno Raffaele, la casa di Vatolla, in cui io ero nato, per pagare le quote del suo socio. Ben presto però mio padre dovette constatare che portare avanti la bottega da solo non era possibile. Non ce la faceva economicamente né fisicamente. Per di più, come era facilmente prevedibile, l'incompatibilità di carattere tra lui e mia madre si era venuta accentuando con i loro continui litigi.
Fu in questo frangente che, nell'ottobre del 1954, Salerno assieme a tutta la costa amalfitana fu colpita dall'alluvione. Le devastazioni furono immense con frane, voragini, ponti crollati, strade e ferrovie distrutte in più punti. Più di 300 furono le vittime, 250 i feriti e 5000 i senza tetto. Per vittime, dopo il Vajont, è stata la più grande tragedia italiana, dimenticata, dovuta al dissesto idrogeologico.
Nella strada davanti alla bottega si aprì una voragine provocata dall'erosione delle acque che scorrevano come fiumi dirette verso il mare. Quelle acque trascinarono a mare uomini, animali, vetture e tutto quello che incontravano sulla propria via. Tra tutto quello fu trascinato a mare anche il camioncino OM di mio padre che non fu mai più ritrovato.
In questa situazione mio padre non poté fare più nulla per salvarsi e così dovette chiudere baracca e burattini. Nel frattempo mia madre già si era confidata della situazione matrimoniale con l'unica persona con la quale poteva confidarsi cioè sua sorella Gilda la quale le suggerì di lasciare mio padre ed andare a vivere con me a Valmontone, insieme a lei.
Quando mio padre ebbe sentore di questo mi prese e mi portò da una delle sue sorelle, mia zia Venerina, che viveva a Vietri sul Mare, vicino Salerno. Mia madre però non si perse d'animo, si recò a casa di mia zia Venerina mi riprese tra le sue braccia e con un pullman insieme raggiungemmo a Valmontone mia zia Gilda.
Mia madre, una ragazza di ventidue anni, era praticamente sola e poteva contare soltanto sul sostegno, più che altro morale, della sorella Gilda che peraltro non se la passava tanto bene avendo i suoi grattacapi. All'epoca mia zia Gilda già aveva avuto cinque dei suoi sei figli, e il marito, mio zio Peppo, lavorava solo saltuariamente come falegname essendo stato licenziato, subito dopo la guerra, dalla Bomprini Parodi di Colleferro.
Non era facile a quel tempo rompere i vincoli di un matrimonio civile e religioso, per cui per mio padre non fu difficile imporre i suoi diritti di marito abbandonato. Dopo aver chiuso la drogheria di Salerno subito seguì mia madre a Valmontone dove affittò una casa e aprì una nuova drogheria e così riuscì nel suo intento di ricostituire l'unità famigliare.
Alla fine del 1954 quando la famigliola arrivò, Valmontone era un paese profondamente ferito dai bombardamenti degli anglo-americani e dalle distruzioni lasciate dai nazisti. Le macerie erano ovunque. La gente provinciale e arretrata si dedicava sostanzialmente all'agricoltura.
La prima volta che mia madre mi portò all'asilo dalle monache scappai scavalcando un cancello di ferro e tornai a casa che me l'ero fatta sotto. Non fu facile convincermi ad andare all'asilo.
Nel settembre del 1955 nacque mio fratello Massimo. Quando a mia madre gli si ruppero le acque c'ero solo io in casa con lei. Mi ordinò di andare a chiamare mia zia Gilda la quale avvisò la levatrice. Quando la levatrice arrivò il parto era già in atto. In un paio d'ore mio fratello nacque alla presenza della levatrice, di mia zia Gilda e me. Il dottore arrivò solo a cose già avvenute.
In realtà il vero nome di mio fratello era Mario. Il fatto è che mia madre voleva chiamarlo Massimo ma mio padre quando andò a registrarlo all'anagrafe gli antepose il nome di Mario così come si chiamava il più piccolo dei suoi fratelli.
Mio fratello stava sempre malato e piangeva in continuazione. Sentivo mia madre sempre preoccupata che si lamentava per questo. Un giorno quando mio fratello stava nella sua culla, piangendo come al suo solito, mia madre mi trovò con un coltello fra le mani. - Che ci fai tu con quello in mano - , mi chiese. - Lo ammazziamo mamma così non piange più - , le risposi. Qualche volta ho crudelmente pensato che se mi avesse lasciato fare la vita sarebbe stata molto più agevole per lei.
Quando mio fratello si ammalava per mia madre la preoccupazione era doppia. La taccagneria di mio padre era così radicale che non c'era verso di fargli chiamare il dottore e comprare le medicine. Mia madre doveva fare tutto di nascosto facendosi anche prestare i soldi necessari da terze persone.
Grande apprensione in tutti destò l'incidente che ebbe mio fratello quando aveva tre anni. Uscendo dalla nostra bottega fu investito da un motorino che trasportava una bombola del gas. Fu colpito alla fronte dalla base d'appoggio della bombola. Il taglio fu così profondo e lungo che provocò una cicatrice che se l'è portata appresso per tutta la sua breve vita.
Un'altra occasione di grande apprensione fu quando mia madre, non ricordo per quale ragione, aveva regalato a mio fratello cinquanta lire. Io come al solito tentai di togliergliele in tutte le maniere, anche con la forza. Però mio fratello piuttosto che cedere alle mie insistenze preferì inghiottirle. Fu portato in ospedale dove dopo un paio di giorni con il sollievo di tutti, infermieri e medici inclusi, riuscì a defecarle.
Nel settembre del 1957 arrivò finalmente il mio primo giorno di scuola. Mia madre mi fece fare due bellissimi - zinalini - (grembiuli) azzurri completi di un fiocco bianco grandissimo, gli stessi che mi accompagnarono per i successivi cinque anni delle elementari. La sola cosa che ad ogni nuovo inizio d'anno mia madre faceva era di cambiare il numero romano, dal I al V, sul braccio sinistro. In vita mia non mi sono mai più sentito così elegante. All'inizio di ogni anno scolastico mi portava dal fotografo nella piazza principale del paese per la foto di rito e poi a scuola dove mi assegnarono alla prima classe A con il maestro Ciancio.
Un maestro molto autoritario, aveva una bacchetta che noi chiamavamo - lecca sapone - di color nero, lucido, di sezione quadrata rinforzata in ottone ai quattro spigoli. Un dolore tremendo quando distribuiva le sue bacchettate con equa imparzialità sulle mani di chi sgarrava. Tuttora quando allungo la mano destra in avanti con il palmo in su mi viene il riflesso condizionato di ritirarla indietro immediatamente.
Grazie anche ai regali che mio padre elargiva a Ciancio in coincidenza delle feste di Natale e Pasqua, io durante le elementari me la sono cavata abbastanza bene. Mi ricordo di una volta che gli dovetti consegnare un boccione di vermut Martini da due litri che non ce la facevo neanche a portare. Sì perché mio padre all'esterno della famiglia era cosi, si trasformava, appariva amabile e generoso.
Andare a scuola all'epoca era molto impegnativo ma c'erano anche molte piacevoli attività. Mi ricordo con nostalgia le recite che si facevano sotto le festività di fine anno. Una volta per la recita di Natale mi assegnarono il ruolo di babbo natale perché trovarono la mia risata la più squillante della scuola.
Per Pasqua a Valmontone c'era la tradizione della rappresentazione della Via Crucis con le quattordici stazioni nella quale i partecipanti vestivano in costumi storici, con cavalli e tutti gli altri accessori d'epoca. Noi bambini partecipavamo attivamente ai preparativi. A Carnevale io mi vestivo da Zorro e le sere si andava bussando alle porte delle case a chiedere dolci: io andavo pazzo per le castagnole ripiene di crema.
A parte i litigi continui dei miei in quel periodo tutto mi sembrava andasse bene. La bottega di - Maria la commerciante - e del - bassotto - , come la gente soprannominò mio padre, aveva cominciato a lavorare ed era conosciuta in tutto il paese. Nel giro di tre o quattro anni cambiammo due volte casa e un paio di volte il locale della bottega, ogni volta più grandi di prima.
Naturalmente mio padre continuava ad applicare i suoi metodi. Una volta per la riffa di Pasqua mia madre come primo premio aveva messo in palio un uovo di cioccolato gigante, bellissimo. Il sorteggio determinò però che nessuno vincesse per cui l'uovo rimase a noi che ce lo portammo a casa. Quando dopo la Pasqua il rappresentante della Ferrero passò dalla bottega per chiedere di essere pagato mio padre gli disse che l'uovo era stato vinto da un cliente e che non vedeva perché lui gli doveva pagare l'uovo. Al che il rappresentante gli mostrò il contratto che aveva firmato mia madre e lui candidamente gli disse che mia madre era morta e che lui non ne sapeva niente di quel contratto.
1958 Valmontone: il grande uovo di Pasqua di cioccolato tra me e mio fratello.
A casa mia non ce la passavamo male. Quando ancora in paese i televisori si contavano sulle dita di una mano, mio padre ne noleggiò uno che dietro aveva una cassetta dove si dovevano inserire cento lire, una - piotta - come si diceva a Roma. Con le cento lire l'apparecchio funzionava per un'ora dopodiché si spegneva automaticamente e per riaccenderla si dovevano inserire altre cento lire e così via facendo. Alla fine del mese passava un incaricato che svuotava la cassetta, contava le monete e le metteva a conto fino a quando non si fosse raggiunto il costo d'acquisto e l'apparecchio così diventava di proprietà dell'usuario.
Ricordo come fosse ora le trasmissioni di Lascia o Raddoppia, Perry Mason, Abbe Lane, Tognazzi e Vianello. La sera i nostri vicini di casa si portavano la sedia, si accomodavano nel salotto e quando non c'era più posto dentro rimanevano in piedi fuori dalla porta. Tutti insieme appassionatamente si seguivano i vari programmi. Molte volte, proprio sul più bello, il televisore si spegneva e con urla di disapprovazione dei presenti mio padre quasi si vedeva costretto a inserire un'altra - piotta - . Ma mio padre era un osso duro ed il più delle volte non era affatto disposto ad aderire alle richieste dei presenti.
La domenica pomeriggio con un paio di miei amichetti ci si sintonizzava con la radio per seguire le partite del campionato di calcio. Memorabili erano le radiocronache di Nicolò Carosio. Erano i tempi di Sivori e Charles nella Juve, Giacomino Losi e Ghiggia nella Roma e - raggio di luna - Selmonson nella Lazio.
Io tutti i pomeriggi accendevo quella stessa televisione con la speranza che fosse rimasto un refuso di tempo dalle cento lire della sera precedente. Speravo di vedere - La TV dei Ragazzi - . In particolare un cartone animato che raccontava le storie di un indiano di cui mi ero letteralmente innamorato. Era un piccolo indiano che andava sempre a caccia munito del suo arco, si chiamava Penna Bianca.
Fu in una di queste occasioni che vidi il primo programma sportivo della mia vita che si chiamava - Telesport - dove si faceva il resoconto del disastro di Belfast del 1958, uno dei peggiori esiti per le qualificazioni ai mondiali del calcio italiano. Fuori dalla fase finale che si sarebbe giocata in quello stesso anno in Svezia. Un disastro eguagliato solo di recente, nel novembre del 2017, con la sconfitta dell'Italia, guarda caso, con la stessa Svezia.
La nazionale italiana degli oriundi stava nel girone con il Portogallo e l'Irlanda del Nord. Nell'ultima partita decisiva, dentro o fuori, sarebbe bastato il pareggio, ma su quel campo fradicio di acqua e fango finì malamente: doppio vantaggio irlandese, il gol della vana speranza dell'1-2 che determinò il risultato finale. Addio Mondiali.
Quel mondiale di calcio lo avrebbe poi vinto il Brasile che batté la Svezia in finale per cinque a due con doppietta di Pelé, soprannominato O Rey, che per le sue straordinarie imprese sportive è considerato da molti il più forte calciatore di tutti i tempi.
Come allenatore quel Brasile aveva in panchina Vicente Italo Feola di origini cilentane e quindi, mi piace pensare, parente di mia madre che porta lo stesso cognome. Più esattamente i suoi genitori erano cilentani di Castellabate che, come tantissimi altri loro conterranei, all'inizio del Novecento emigrarono in Brasile in cerca di fortuna e dove appunto a San Paolo, nel 1909, nacque Vicente Italo. Ebbe una discreta carriera da calciatore ed una più grande carriera da allenatore avendo vinto due campionati carioca con il San Paolo, il mondiale del 1958 e partecipato, sempre come allenatore della - Seleção - , all'altro mondiale del 1966 in Inghilterra.
A parte la scuola passavo le mie giornate giocando a pallone però nessuno aveva un vero pallone. Allora si prendeva un collant vecchio da donna per riempirlo di carta di giornali e poi legarlo con degli elastici. Incredibile ma quei palloni così fatti rimbalzavano davvero.
Quando era estate si iniziava a giocare la mattina e si finiva a notte fonda. Ogni tanto rientravo nella bottega per prendermi un formaggino di cioccolato e nocciole della Ferrero. Credo non fosse ancora uscita la Nutella. Alla fine della giornata ne facevo fuori cinque o sei. Un giorno ritornando a casa tutto zozzo e sudato mi attaccai alla prima bottiglia che mi capitò sottomano senza rendermi conto che conteneva varechina. Per la prima volta finii in ospedale dove mi salvarono facendomi una lavanda gastrica.
Altri giochi che andavano per la maggiore erano le palline di vetro: si scavavano delle piste tortuose in terra e con una schicchera, colpo del pollice o del dito medio sulla pallina, vinceva chi arrivava primo al traguardo. Si giocava a - ruba bandiera - o a - tre monta la luna - . Ma il gioco più bello era senz'altro la - nizza - . Dal manico di legno di una scopa di saggina venivano ricavati due pezzi di bastone, uno di circa 20 cm, denominato - nizza - , e l'altro più lungo a mo' di mazza. Le due estremità della - nizza - venivano lavorate a forma di ogiva. Questa veniva adagiata al suolo da dove doveva essere colpita con la mazza ad una delle due estremità. La - nizza - così colpita si alzava dal suolo immediatamente ruotando molto velocemente attorno al proprio asse come l'elica di elicottero. Quindi con la mazza si doveva colpire con tutta la forza possibile. Chi riusciva a mandare più lontano la - nizza - vinceva il gioco.
Altre volte con mio cugino Mario, figlio di Gilda, che era più grande di me, organizzavamo spedizioni come quella di scalare il - casarino - , un pendio molto ripido alle spalle di Palazzo Doria nel centro di Valmontone, o andare a fare gli speleologi dentro alcune grotte piene d'acqua che avevamo scoperto e di cui solo noi conoscevamo l'esistenza. Altre volte si andava in campagna dal cognato di mio cugino Franco, anch'egli figlio di Gilda, ad aiutarlo a cogliere le barbabietole dalla terra. La mia passione era però cogliere le nocchie dagli alberi di nocciole.
I miei non potevano darmi tanta attenzione e perciò crebbi libero come un selvaggio anche se mia madre poi mi dava un sacco di botte perché stavo sempre in giro, non ubbidivo e ne combinavo sempre una più del diavolo. Ricordo che d'estate andavo in giro completamente scalzo. Lei sempre mi chiamava - Lellooooo - - Lellooooo - e io mi nascondevo. Però poi, quando tornavo a casa, me le dava di santa ragione con tutto quello che gli passava sottomano. La cosa più dolorosa era un battitappeto di plastica rosa che lei usava per ripulirmi ben bene.
Una volta un mio amichetto cominciò a chiamarmi - a bassotto - chiaramente riferendosi al soprannome di mio padre. Io ero furioso con lui anche perché mi scappava dalle mani e non riuscivo ad acchiapparlo. Però quando riuscii ad afferrarlo lo misi sotto di me con le spalle a terra e con una pietra quasi gli sfracellai la testa. Dopo un po' il padre venne alla nostra bottega con fare minaccioso cercandomi perché voleva darmi una lezione. Al che mio padre gli disse che se ne doveva andare.
Io ero nascosto sotto al bancone. L'uomo insistette, mio padre senza dire nulla gli lanciò un coltello, di quelli corti che servono per aprire le forme di parmigiano. Il coltello colpì l'uomo giusto in petto, grazie a Dio dalla parte del manico.
Vedendo la mala parata e conscio delle botte che avrei ricevuto, subito dopo che l'uomo se ne fu andato, presi la mia bicicletta, taglia diciotto pollici da bambino, e me ne andai da mia zia Ines che viveva con la sua famiglia a Colleferro. Cioè mi feci circa dieci chilometri sulla Casilina, una delle strade consolari di Roma sin da allora molto trafficata. Quando mia zia mi vide arrivare gli pigliò un colpo. Chiamò mia madre e mi mise su un pullman delle linee - Zeppieri - con la bicicletta raccomandando all'autista di farmi scendere a Valmontone dove mia madre mi avrebbe aspettato all'apposita fermata. Nonostante fossi terrorizzato dalle botte che dovevo ricevere quella volta mia madre non mi toccò. Non dovevo avere più di sette o otto anni e già da allora dimostravo la grande temerarietà che poi ha caratterizzato tutta la mia vita.
Altre volte, specialmente d'estate, a dispetto delle punizioni che poi ricevevo, scappavo la sera da una finestrella della cucina e passavo tutta la notte fuori. Solo quando i miei genitori, il giorno successivo, uscivano di casa per andare ad aprire la bottega, ritornavo a casa passando dalla stessa finestrella.
Come sempre durante il periodo a ridosso di Pasqua mia madre riceveva da parte delle sue clienti ordini di torte che poi preparava la sera a casa. Immancabilmente mi chiedeva di aiutarla, sapeva che questo mi piaceva. Tra gli ingredienti più importanti che lei utilizzava c'erano i liquori come lo Strega, la menta, i vari vermut e l'alchermes di colore rosso che lei appositamente preparava. Tutte quelle bottiglie colorate le teneva in bella mostra dentro una credenza-vetrina. Probabilmente abbagliato dai variopinti colori e inebriato dai profumi di quei liquori una notte mi misi in testa di assaggiarli tutti, uno dopo l'altro.
Quando fu la mattina riuscii a malapena ad alzarmi ed andare alla bottega dai miei genitori. Ma appena giunto lì andai al bagno e stramazzai al suolo. Erano i giorni di Pasqua e la bottega era stracolma di gente. Quando mia madre mi vide lungo, steso sul pavimento, si spaventò a morte, mi misero su una macchina e mi accompagnarono all'ospedale. Poco dopo i dottori si resero conto delle mie vere condizioni e dissero a mia madre che ero ubriaco. Mia madre mi lasciò solo lì in ospedale e ritornò alla bottega. Dopo una lavanda gastrica i medici mi dimisero e mi affidarono a mia zia Gilda che mi tenne con sé per qualche giorno.
Pero non solo vagabondavo. A scuola andavo abbastanza bene. Stazionavo sempre tra i migliori. Quando in terza elementare cominciarono a farci studiare musica, io mi appassionai a tal punto che lasciai di impegnarmi nelle altre materie per dedicarmi a quello. Mia madre, visto questo mio interesse, mi iscrisse alla scuola di musica serale che aveva aperto il maestro della banda musicale di Valmontone.
Dopo tutte le lezioni teoriche, solfeggi compresi, il maestro Cannone mi comunicò che ero pronto per iniziare a suonare uno strumento. Data la mia struttura fisica lui considerava che lo strumento più adatto a me era il clarinetto. Ma anche quella volta la taccagneria di mio padre fu uno scoglio insormontabile. Non ci fu verso di intenerirlo a comprare un semplice clarinetto e così dovetti abbandonare i miei sogni da musicista.
La forte delusione fu però stemperata dal fatto che all'epoca si stava facendo strada in me il sogno di diventare un calciatore. Quando giocavo a pallone ero come in trance agonistica e mi dimenticavo di tutte le mie pene. Nelle partitelle con i miei compagni ero senz'altro il migliore. Ero veloce, resistente, altruista, con coraggio e fantasia. Mi sentivo protagonista e realizzato. Il contrario di quello che succedeva nella mia vita di tutti i giorni dove mi sentivo con molti complessi di inferiorità dovuti soprattutto alla mia situazione famigliare.
Alla fine degli anni Cinquanta, inizio anni Sessanta, questa situazione precipitò ancor più in basso. Eravamo nell'estate del 1960 quando, per quella che poi sarebbe stata l'ultima volta, la famiglia si recò in vacanza al paese di origine. Una sera che si stava tutti insieme a cena a casa di mia nonna Fonsina, insieme alla famiglia di mio zio Manlio, a Santo Mango, scoppiò una violenta lite tra i miei genitori. I due vennero alle mani. Mia madre approfittando di trovarsi praticamente a casa sua, ad un certo punto, prese uno spazzolone per lavare i pavimenti e lo ruppe in testa a mio padre provocandogli una ferita lacero-contusa alla fronte la cui cicatrice gli sarebbe rimasta visibile per tutta la vita. A quel punto mio padre che perdeva molto sangue prese un asciugamano, se lo arrotolò in testa come fanno gli indiani sic e se ne andò a piedi, in piena notte, a Vatolla dai suoi parenti.
La classe III A del maestro Ciancio. Io sono il primo in alto a destra sulla finestra.
Io, mia madre e mio fratello restammo a Santo Mango e mio padre fece ritorno da solo in treno a Valmontone. Anche in quella occasione mio padre non si smentì. Quando tornammo a casa venimmo a sapere di come lui avesse denunciato le Ferrovie dello Stato asserendo che era stato ferito da un bagaglio che gli era caduto in testa dentro lo scompartimento mentre faceva ritorno in treno da Napoli a Roma. Come prova aveva portato il certificato medico della ferita che gli aveva procurato mia madre. Non ho mai saputo se questo suo intento di estorcere denaro alle FS italiane avesse poi avuto successo o meno.
Comunque quella violenta litigata, capisco solo ora dopo tanto tempo, fu il punto di non ritorno per la nostra unità famigliare. Da allora in poi le cose per tutti noi non sarebbero state più le stesse.
Mia madre colse quell'occasione, unica a suo modo di dire, per manifestare nel modo più plateale e feroce la sua rabbia contro mio padre e tutti gli altri artefici del suo assurdo matrimonio.
1959 Tivoli - Villa D'Este: mio padre, mio fratello ed io.
Raffaele Mutalipassi
|
