
 I - La morte di Dante (Mercoledì, 9 Novembre 1870). I - La morte di Dante (Mercoledì, 9 Novembre 1870).
Sono le due di notte. La bella villetta agiata di Via Broccaindosso numero civico 20, Bologna. Gli ampi saloni aristocraticamente arredati vuoti, la notte alta e tremenda, fuori infuria il temporale.
Tuoni, lampi, pioggia come se la terra non ne avesse mai vista e assetata la reclamasse, tirandola giù da gonfi e plumbei nembi. Lampi e tuoni di furore.
Battesimo d'acqua celeste con annegamento del battezzando.
Nella casa abitano J e sua moglie Elvira con le loro due bambine Beatrice e Laura, undici e sette anni. E Dante, l'ultimogenito. Morto, nel suo lettino, nella sua cameretta camerona secondo gli usi dei bimbi agiati del tempo. Morto a quattro anni, di sfortuna, quando magari tanti più piccoli manco ci arrivavano a quattro anni. Ma ciò non è di consolazione alcuna per J e la moglie, neanche la buona salute delle due sorelline maggiori. Morto. Dante è morto. Di versamento al cervello, o che, non si sa, non si capisce. Già non si capisce mai nulla di fronte alla morte, di fronte poi ad una morte improvvisa, imprevista, squassata da brevi febbri fredde e violente, tifoidee, batteriche! Nulla si sa del come la morte si è portata via il piccolo Dante. Elvira sconvolta e sconsolata abbandonata sul corpicino a piangerlo gli bagna di calde lacrime di mamma il petto. Le bimbe di là, badate dalla servitù. Non è il momento adesso, no. Il padre, J, vestito di tutto punto, statua di gesso attonito, lì dritto, pietra non più uomo, tra le mani una locomotiva carillon, un piccolo giocattolo francese dono di zio Carlo che tanto avevano ascoltato gli ultimi tempi lui e Dante, che pensavano assieme di fare un lungo viaggio lontano, in treno, nei pomeriggi della malattia breve, brevissima, che non si capisce se tale brevità sia stata dono del Cielo o dolore nel dolore. J, muto, forzando la chiave al contrario, pensa a tutt'altro. Pensa a non pensare. No, non pensa. Quando il fondo del cervello si fa grigio di cenere e muto, nel silenzio, nella mancanza di pensiero. Quando la speranza di non essere è l'unica che consola o che almeno fa soffrire meno. Non essere, per non soffrire. Ma è solo un pensiero illogico, come lo è tutta la situazione. Nasce un bambino, destinato ad ereditare da te vita e sapienza, muore un bambino, tu rimani di sasso, sconfitto al gioco della Vita. Un lampo violento squassa la stanza, senza tuono. I volti cinerei degli astanti illuminati a giorno, un attimo. Zio Carlo, maschera di lutto, alto appoggiato allo stipite della porta, nella stanza con l'anima ma fuori col corpo, rispettoso dell'intimità di quella famiglia, pur intimo anche lui, zio Carlo. Dolore composto, ma pienamente partecipe, non assente.
Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
che la diritta via era smarrita
Mormora J, convinto di starlo solo pensando, inascoltato da tutti, maledicendo i trentacinque anni compiuti che ha, non pochi certamente, ma neanche troppi al punto di disperare e abbandonare la lotta. La lotta della Vita. Si nasce per lottare. Arriva il tuono. Suo padre Michele era un lottatore, dai modi impulsivi e imprevedibili, lottava come un cane pazzo. Aveva di che lottare. E pure perse un figlio, anche lui perse un figlio Dante, tredici anni prima, povero Dante suicida, Dante si chiamava anch'egli, quel fratello di J. J ricorda come quella morte di Dante fu per il padre Michele motivo di scoramento assai, scoramento esistenziale totale che in capo a un anno se lo portò nella tomba, sotto la terra fredda, dentro la terra negra. Privo di motivi per lottare. Il dolore che si prova in morte di un figlio. Il dolore più grande del mondo perché contro natura, perché non attinente all'ordine naturale delle cose. Perché contraddice il nasci/vivi/muori sequenziale generazionale che ci portiamo codificato nelle cellule del corpo sin dal concepimento, inciso a fuoco nel nostro firmware genetico.
“J..” - fa Carlo a bassa voce. È vicino, vuole essere ancora più vicino ai Carducci. È addolorato per Dante, ma non può permettersi il lusso del dolore, se soffre non può aiutare. Vuole essere loro vicino, sostenendoli e sostentandoli per come può.
“J..” - replica dopo secondi o minuti di risposte non date, niente affatto certo di essere stato udito.
“J..” - niente, J non ci sente in questo Mercoledì maledetto. J non ci sente dalle orecchie, non vuole sentire cosa gli frulla in mente, non vuole più sentire le nevrosi del cuore che come un cavallo imbizzarrito galoppa e scalcia, anelando solo ad una vasta prateria, un altopiano su cui correre, un lago presso cui dissetarsi.
Carlo Lorenzini, quarantaquattro anni a fine mese, sta lì dietro. Muto anch'egli. Ma c'è.
Dante.
Dante è morto.
II - Albana e Sangiovese (Giovedì, 24 Novembre 1870)
J si trova all'osteria della Serafina, a Bertinoro, in Romagna, sua seconda patria, affinità elettiva. Una visita breve, solo qualche giorno per non pensare a nulla, con Carlo. Serata scapigliata di letture di poeti giovani, senza pedigree. Al centro del locale un leggìo, tre cretini vestiti come Caligola scagliano filippiche luddiste in versi malfermi contro le macchine che riempiono le fabbriche e tolgono lavoro agli uomini. Carlo apre la terza bottiglia di Albana, dorato ma tannico, strutturato ma morbido, fresco, un vino bianco - albus per gli antichi romani - romagnolo e appassionato, come il toscano J, che lo trova leggero, e lo fa scendere facile.
“J, ascoltami. Sono cose ben scritte in certi tomi.”
“Carlo, tu mi parli di stregoni e incantesimi.”
“Come il Cristo parlava di risorgere dalla morte.”
“Tu bestemmi.”
“Siamo tutti bestemmiatori, per il solo fatto di ardire a costruire la nostra personale felicità in un mondo dove le macchine imperano, e i governanti ti vogliono schiavo e morto ancora prima di nascere.”
“Parli come il mio babbo.”
“Grande uomo Michele. Fosse qua mi darebbe ragione.”
Sorriso affettuoso ma amaro di J, giovane uomo adulto ma sempre schiacciato dalle figure troppo grandi che lo circondano azzurrine ed evanescenti come fantasmi di Forza. Il padre Michele, la nonna Lucia, la mamma Ildegonda, il fratello Dante.
“Ascolta J, guarda qua.” - rovista nelle tasche interne del gilet.
“Aspetta, tocca a un nuovo poeta.” - J indica il leggìo al centro.
“Ma è un ragazzo!” - si meraviglia Carlo all'ingresso di quel figurino magro, avvolto in una giacca troppo grande che gli cade male da tutte le parti, camicia macchiata e occhi blu slavati, improbabili radi baffetti da pseudo adulto, i capelli sparati in aria come un nido di rondini centrato da una schioppettata.
“I ragazzi hanno l'energia, i vecchi l'esperienza. Io niente di ambo le cose.” - salomonico J, giù un bicchiere di Albana, un morso di piadina.
“Dai, dai.. Ascoltiamolo, sì..” - intanto Carlo tutto preso rovista carte e cartucce e tira fuori nastri papiri fettucce un pezzettino di pergamena persino, quattro bottoni spaiati, monete false, una col buco quadrato nel centro, e tre torsoli di pera di chissà di quanto tempo addietro.
De féroces oiseaux perchés sur leur pâture
Détruisaient avec rage un pendu déjà mûr,
Chacun plantant, comme un outil, son bec impur
Dans tous les coins saignants de cette pourriture
Les yeux étaient deux trous, et du ventre effondré
Les intestin pesants lui coulaient sur les cuisses,
Et ses bourreaux, gorgés de hideuses délices,
L'avaient à coups de bec absolument châtré [1]
“Solito Grand Guignol d'oltralpe..” - a J non piacciono queste rimacce, sangue violenza e carnacce avariate, decadenti veramente, troppo lontane dall'estetica perfetta del suo amato mondo classico.
“Baudelaire, il francese.” - Carlo preso da quanto sta facendo dispiega sul tavolo mappe e mappette.
“Pure sifilitico, pensa te..”
“Sai a quanti cirrotici finisce che conferiscono premi a fine carriera, ed altisonanti, in gloria e denaro?” - cinico Carlo, concentrato su altro.
“Ho letto in traduzione, conosco.” - J giustifica il suo disentusiasmo.
“Io il francese lo leggo in originale.”
“E fai bene. Diversamente, si perde tutto, o la gran parte. La poesia va letta in originale. La prosa, tradotta, pure pure..”
[1] Tratto da “Un voyage a Cythère”, opera CXVI di “Le fleurs du mal” di C. Baudelaire, 1857. I versi sono liberamente traducibili come
Dei feroci uccelli appollaiati sulla loro pastura
Distrutto con rabbia un impiccato già morto
Ciascuno piantando, come un attrezzo, il suo becco impuro
In ogni angolo sanguinante di quel marcire
Gli occhi erano due buchi e dal ventre sfondato
Gli intestini pesanti colavano lungo le cosce
E quei boia, pieni di orribili delizie,
L'avevano completamente castrato a colpi di becco
Dal pubblico uno scapigliato a torso nudo lancia un bicchiere vuoto contro il poetino giovane, il quale schiva agile con noncuranza, schiaffeggiandosi con la mano l'avambraccio alla maniera italiana.
“Piace.” - osserva J.
“Piace sì, sennò pieno glielo tiravano.” - arriva un altro vassoio di piadine, ma Carlo lo manda via che non c'è più posto sul tavolo unto, ingombro delle sue carabattole e pergamenucce. Anche giocattolini di legno e ferro, un pesciolone grande che premi la pinna e apre la bocca e barche, cavallini, come le sorpresine Kinder di metallo cento anni prima della loro invenzione.
Il poetino continua, stavolta la poesia è sua.
J'ai vu fermenter les marais énormes, nasses
Où pourrit dans les joncs tout un Léviathan!
Des écroulements d'eaux au milieu des bonaces,
Et des lointains vers les gouffres cataractant! [2]
“Giobbe 40, 25-26. Puoi tu prendere il Leviatano all'amo e con corda fermarne le fauci, infilare un giunco nelle narici e bucare con fiocina l'osso del mento?” - J la Bibbia la legge, poi il rapporto con la Chiesa di Roma è un'altra cosa.
“Esegeta, ascoltami un attimo.” - Carlo adesso è pronto per la sua disamina all'amico. J si risolve ad ascoltarlo, pazienza per quei versi giovani che pure hanno un ché di folle ed energico dentro, nel cuore inevitabile l'accostamento del sedicenne al futuro talento che il suo piccolo Dante certamente avrebbe sviluppato, se solo fosse potuto crescere.
“Sono tutto orecchi.” - senza staccare gli occhi dal poetino.
“E occhi, J. Mi occorrono anche gli occhi. O credi che tutte queste bagatelle siano per me?” - indicando la variopinta mercanzia che ingombra il tavolo.
J sbuffa, si gira, si mette comodo, urta per sbaglio col gomito un breviario d'obliata sapienza di Carlo che cade portandosi appresso uno scatolo pieno di soldatini di metallo. Carlo raccoglie lesto, ed inizia.
“Il Dio dei Cristiani ha concesso solo a suo figlio di riemergere dalla morte.” - Carlo va giù diretto.
“Questo lo sanno tutti.”
[2] Tratto da “Le bateau ivre” di A. Rimbaud, 1871. Non appare impossibile che, prima di darlo alle stampe, l'autore abbia voluto provare la sua opera in vari “Live” oltreconfine, tra cui Bertinoro. I versi sono liberamente traducibili come
Ho visto fermentare enormi paludi, nasse
Dove marcisce tra i giunchi un Leviatano intero!
Dei crolli di acqua in mezzo alle bonacce,
e lontananze che precipitavano negli abissi!
“Ma ci sono culti, sistemi di pensiero, saperi alternativi per cui la resurrezione non è solo prerogativa divina..” - direttissimo, con tutta l'attenzione di J - “..ma manifestazione concreta di più alte energie, cosmiche, ancestrali. Le puoi chiamare Amore, o non chiamarle affatto, esse di per loro non hanno un nome, fatto sta che Esse Sono. Ontologicamente Sono. E possono essere imbrigliate.”
“Carlo, sei vago al punto tale che io non posso risponderti che ‘sì'.”
“Difatti non mi aspetto un ‘no'. Tutto sta nel capire come muovere l'energia lungo i canali, cosa toccare, cosa attivare. E da un Talento ne avrai dieci indietro.”
“Mi tiri in ballo i Talenti adesso?”
“Ricambio Giobbe.”
J si rovescia in gola un bicchiere d'Albana, ancora fresco. Non fa mica in tempo a scaldarsi in questa serata. J tace.
“Beh?” - fa Carlo.
“Perbacco.” - atono J, più deluso che incuriosito.
“Non essere scettico. Non ti conto balzanerie. Principio immenso, Materia e spirito, Ragione e senso! O non è più così?”
Carlo leva in alto il bicchiere.
“È così, è così, sorbole se non lo è!” - J leva in alto un altro bicchiere di Albana, vuotandolo d'un colpo e rispondendo al brindisi con la sua chitarronata a quinari sdruccioli.
Mentre ne' calici
Il vin scintilla
Sí come l'anima
Ne la pupilla
Salute, o Satana
O ribellione
O forza vindice
De la ragione! [3]
“Allora noi dobbiamo fare nostra quella Magia, ed utilizzarla per riportare Dante in vita.”
J sbianca in volto. Albana, ancora. Bottiglia vuota. Fa un gesto alla ragazza, Albana finito, arriva Sangiovese. Amarognolo dopo l'Albana, secco e tannico, complessivamente armonico, d'un bel rosso rubino sfumato violaceo, sa pure di viola in effetti. Carlo vuota il primo bicchiere di quel rosso sangue romagnolo.
“Oggi compio quarantaquattro anni, J, e sul mio genetliaco ti giuro che le cose si hanno a fare come te le sto descrivendo.”
Carlo deve essere pazzo. J glielo dice.
“Sei pazzo, Carlo. Tu bestemmi nuovamente.”
“Nuovamente ti ripeto che siamo tutti bestemmiatori. In primis per la penna, in secundis per questioni di donne ed armi, et in finis perché noi riusciremo in ciò che i Poteri Forti non vogliono che si sappia, cioè che l'Uomo è in realtà arbitro della sua Vita, al punto tale da poter svellere la Morte per lungo tempo, più e più volte, altro che i centoventi miseri anni che ci promettono!” - lo sguardo di Carlo brilla adesso dell'algida luce della folle progettualità, la stessa che consentì al Re di Itaca ed alla sua tarda ma arguta e scaltra compagnia di arrivare a intravedere la montagna del Purgatorio.
“Ti ascolto.” - J non può credere con la mente all'amico. Gli crede però col cuore.
“Vi è, al centro degli Abruzzi, il grande Lago di Celano.”
J salta sulla sedia come se sotto di questa avesse detonato un cartoccio di polvere pirica, tutta preso da quella geografia lontana.
“Niente di meno! Gli Abruzzi! La terra di Sulmona! Mihi patria est!” - riemergono prepotenti i ricordi mai sopiti, ancora forti, di Ovidio, delle passioni letterarie giovanili.
“Gli Abruzzi, precisamente. Sul lago di Celano al tempo dell'imperatore Claudio si tenevano le naumachie. Nessuno sa cosa si nasconda sotto la sua superficie adesso. Ma, qualunque cosa sia, è magica.”
“Ma tu come lo sai?”
“Amici.” - stende le dita della mano, piegando il pollice a proteggere l'anulare richiuso, unico dito piegato.
[3] Tratto dall'inno “A Satana” di Carducci, 1863
“Suona incredibile.”
“Sì, suona incredibile. Per questo non lo fanno suonare affatto. Tuttavia, or è un quarto di secolo, ebbi la ventura grazie a questi miei amici potenti di accedere all'Index librorum prohibitorum [4], e soprattutto ai volumi in esso indicati, e potei studiare la questione, per la qual cosa te la assicuro come vera.”
“Ma non avevi manco vent'anni!” - J conta rapido con le dita.
“E già mi interessavo a come svellere il velo di Maya che è su tutte le cose. Da uno a sette strati, a seconda.”
“Carlo, sei tu dunque una specie di stregone?”
“Non parlare come un cattolichino qualunque, J. Sono uno che vuole vedere le cose, sono un Osservatore. Ma quando posso pratico.”
“Restituire la vita ai defunti.” - J fissa il tavolo, le carte, le mappe. Sì, quelli sono gli Abruzzi, e quelli sono cavallini di metallo, e c'è il lago, terzo per estensione nell'Italia appena unita, ed un vasto altopiano, e la patria d'Ovidio, e la locomotiva di un trenino. C'è tutto!
[4] Sin dal 1559 papa Paolo IV diede mandato alla Congregazione dell'Indice, organismo della Curia Romana oggi soppresso, di compilare e tenere aggiornato un catalogo dei libri proibiti dalla Chiesa cattolica. L'elenco sarà tenuto aggiornato fino alla metà del XX secolo
“Restituire la vita ai defunti.” - fa J perso. Carlo annuisce serio, in silenzio. J tace. Carlo prosegue.
“Già. Magari persino donarla ad oggetti inanimati.” - ora è Carlo a brindare.
“Animare le cose. Un tavolo che parla, una sedia che balla, una scopa che spazza da sola?”
“Eh, magari!”
“Sì, magari un servitore di legno, sì da avere un efficiente e discreto factotum per spicciare magagne grandi e piccole.”
“Eh, perché no? Hai visto mai che fosse una buona idea.” - osserva Carlo, prendendo nota con lapis su piccolo notes, e prosegue.
“Ma adesso pensiamo a noi. Il poetino ha quasi finito, meglio se andiamo via prima del finale che qui è capace che finisce a sediate, come tutte le serate scapigliate.”
“Una scazzottata me la faccio volentieri, è tanto tempo che mordo il freno.”
“Attento a quello che chiedi, J, perché potresti ottenerlo!” - ride insatanito Carlo - “Io ti farò sfrenare attraverso un lungo viaggio, ascolta a me. Il treno ci porterà a Castellammare Adriatico, ed i bei versi e la saggezza di Ovidio, grande tra coloro di ascendenza abruzzese, ci faranno da guida.” - Ovidio imitato nei secoli a seguire da tanti, troppi, persino da William Shakespeare, che già scrisse di Puck e pozioni, piante e leviatani.
“Ma gli Abruzzi si trovano nel Regno di Napoli! Come faremo per la lingua?”
“Ma scus combà, ji parl francios e inglos, te per che nn me su mbarat nu pouc d'abruzzeis?” - Carlo sfoggia il suo decente abruzzese, a sfumatura napoletana impreziosita da un poco di pugliese, pazienza per la C appena aspirata alla toscana..
“In effetti è una lingua a parte.. L'Italia l'abbiamo unita, mo voglio ridere..”
“A Castellammare Adriatico, dicevo, acquisteremo armi ed equipaggiamento. Da lì partiremo a cavallo per Campo Imperiale, in cerca della Magara.”
“La Magara? Ma sei tu lo stregone!”
“Io non sono che un ex volontario del reggimento sabaudo dei Cavalleggeri di Novara, ma si parla di una dozzina d'anni fa. La Magara invece ci preparerà il Feticcio.”
“Poffare!?” - J sgrana tanto d'occhi.
“Sissignore, un orrido feticcio sulla cui Natura non indagheremo, con il quale evocheremo la Magia del Lago di Celano, la quale esaudirà il tuo desiderio, amico mio.”
J fa gli occhi a stella, come nei manga.
“Ma solo uno, ricorda.”
“Non ne ho che uno.” - Dante, piccolo figlio mio, torna da babbo tuo.
“Lo so.” - zio Carlo ti aiuta, J.
“Partiamo domani!”
“Nossignore, ogni cosa a suo tempo. Devo studiare bene i dettagli, e ci occorre bel tempo, ora è quasi Dicembre e abbiamo di fronte solo il Santo Natale, mentre la nostra impresa non sarà vegliata dal Buon Gesù né dalla Dolce Madonnina sua mamma. Saranno oscene divinità ctonie, dal nome dimenticato, a guidare i nostri cavalli.”
J ha un brivido.
“Lasceremo a casa i crocefissi.”
“Non ne no in casa, né indosso.”
“E paura ne hai? Indosso, o nel cuore?” - chiede Carlo.
“Mai avuta, mai ne avrò.”
“Bravo, questo è parlare.” - pacca sulla spalla - “Andiamo via adesso, prima delle sediate. Ragazza!”
Carlo chiama a gran voce la cameriera, spiccia il conto senza troppa precisione, abbondando nella mancia per fare cifra tonda e risparmiare tempo.
Il poetino francese termina la sua esibizione.
Si je désire une eau d'Europe, c'est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de Mai
Mario Molfese
Biblioteca
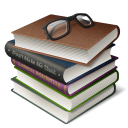
|
Acquista

|
Preferenze

|
Contatto

|
|
