
 Poche ore prima, a casa, avevo salutato mia moglie con un'ansia anomala, che lei avvertì. Poche ore prima, a casa, avevo salutato mia moglie con un'ansia anomala, che lei avvertì.
Me ne resi conto perché, per la prima volta da che ero inviato per il mio giornale, Jane mi chiese se correvo dei pericoli. Se, in altre parole, questa volta fosse davvero come andare in guerra anch'io.
Balbettai che no, che diceva mai? Fui un pessimo attore. Perché, dovendo seguire la guerra (che per inciso osteggiavo da sempre dalle pagine del mio giornale) proprio da Baghdad, un po' era vero che ci stessi andando anch'io come un soldato, ma in realtà soprattutto perché ci stavo andando con la mia amante Cecil, una giovane fotoreporter a caccia di fama e di scoop con la quale avevo una relazione da tre mesi: lei, minacciando di rivelare la nostra liaison a Jane, mi aveva di fatto costretto a convincere il mio capo, nonché mio amico Jack, a portarla con me. Questo mi rendeva veramente inquieto: sarei riuscito a mantenere segreta la sua esistenza fino al nostro rientro in patria, quando finalmente l'avrei lasciata al suo destino di arrampicatrice e avrei ripreso in mano la mia vita?
Mi tormentai con questa domanda per tutto il tempo del volo. Che durò nove ore e ci portò nel cuore della notte in una base militare in Kuwait, dove, data l'ora ci ospitarono provvisoriamente.
Io fui sistemato in una piccola stanza vicino alle camerate. Cecil nell'infermeria.
Si svegliò all'alba quasi contemporaneamente a me anche un giovane soldato con il quale avevamo volato; lo incontrai in una stanza dove entrambi ci eravamo recati alla ricerca, inutile, di una tazza di caffè; vidi che era pallido e le sue gambe tremanti, come se fossero spezzate da una grande fatica.
Gliene chiesi la ragione. Dapprima il ragazzo farfugliò qualcosa sul fuso orario, infine mi confidò che da qualche tempo non riusciva a stare sdraiato. A volte si addormentava normalmente, ma poco dopo si sentiva soffocare e si svegliava sudato tra sensazioni confuse come in un sogno, sensazioni che apparivano spaventose, cariche di oscure minacce com'erano. Allora lui doveva alzarsi e camminare, ma gli riusciva difficile perché era aggredito da tremori e debolezza nelle gambe.
Mi chiese se questo, secondo me, fosse sintomo di qualche malattia.
Gli risposi, no ragazzo, è solo una sana paura la tua. La paura della guerra, la paura di morire.
Avevo colto nel segno, il ragazzo arrossì. Mi pregò di non rivelare a nessuno il suo segreto e mi confidò di avere vent'anni e di essere addetto a uno dei mezzi blindati gommati dotati di piccolo mortaio destinati a essere disposti lungo tutto il confine orientale; si trattava di mezzi di notevole autonomia e grande potenza di fuoco. Una versione aggiornata dell'Hummer H1 e, in alcuni casi come il suo, anche predisposta a effettuare individuazioni e mappature terrestri in coordinazione con i ricognitori aerei. “Insomma, mi hanno mandato quaggiù a scovare e uccidere persone che neppure conosco, anche civili”, concluse sottovoce. Rimanemmo a parlare ancora un po'. Sapeva che ero un giornalista, mi chiese cosa pensassi della guerra e del mio lavoro; simpatizzammo.
Lui era il caporale Bill Collins.
Un brusio confuso proveniente dalla sua camerata ci annunciò che adesso anche tutti gli altri erano svegli. Un attimo dopo il brusio divenne un frastuono di voci eccitate e di passi veloci.
La colazione fu servita in un grande stanzone, quindi Cecil ed io fummo accompagnati all'albergo dei giornalisti, un hotel inaspettatamente opulento che sorgeva a un paio di miglia da lì.
Forse volevano dare a noi della stampa, e quindi all'opinione pubblica, l'idea che la guerra di Bush sarebbe stata una guerra lampo e indolore, anche se pochi si illudevano che ciò fosse vero.
Giunse la fine di febbraio, si rincorrevano pressanti le voci di uno scoppio imminente della guerra, per cui decidemmo di trasferirci a Baghdad, in un altro grande albergo, il Palestine, un edificio di diciassette piani color sabbia, con centinaia di camere dotate di balconcino con vista sulla sponda occidentale del Tigri (dove sorgeva anche il grande complesso residenziale di Saddam Hussein), che sarebbe diventato famoso come il quartier generale della stampa internazionale accorsa a seguire la Seconda Guerra del Golfo, ma che al momento, era famoso più che altro per il percepibile degrado che dodici anni di embargo avevano inflitto ai suoi fasti di un tempo, lasciandone intravedere solo deboli reminiscenze.
Quando giungemmo, gli addetti alla reception erano assediati da decine di giornalisti in cerca di una camera. I facchini ci passavano davanti in un clima di caos, spingendo tra la folla verso i malmessi ascensori dell'albergo carrelli stracarichi di computer, valigie e bottigliette d'acqua. Cecil ed io alla fine riuscimmo a farci assegnare due camere al 14° piano, con buona pace dell'inefficienza degli ascensori.
Negli ex bei divani del Palestine, che da anni non vedevano più un simile viavai, bivaccava dunque una disparata umanità: oltre a noi giornalisti, c'erano agenti dei servizi di sicurezza, venditori ambulanti in cerca di clienti, e interpreti che masticavano qualche parola di inglese e che per pochi dinari si offrivano come tuttofare, perfino setacciare la città a caccia di sigarette.
Sembrava l'assalto di un enorme gruppo di turisti fai-da-te alle prese con imprevisti di ogni genere, invece erano i preparativi alla guerra, a come raccontarla al meglio, per cui tutti noi ci stavamo organizzando per localizzare generatori, telefoni d'emergenza, le postazioni migliori e tutto ciò che sarebbe servito per lavorare al meglio. Davamo l'impressione che avessimo in testa solo la nostra prossima storia da raccontare e che quello fosse l'unico nostro problema, questo ci aiutava invece a ignorare, o a far finta di ignorare, la paura che ci albergava dentro. Era come se le infinite questioni di ordine pratico non dessero spazio a inquietudini e angosce. Ma nascosta dentro ognuno di noi c'era salda la consapevolezza che le bombe non fanno distinzione tra giornalisti e non giornalisti, iracheni e stranieri, militari e civili.
Nei giorni successivi andai a farmi un'idea diretta della situazione e scoprii una città del tutto diversa da come la immaginavo. Tra l'altro scoprii che le piccole e grandi battaglie quotidiane di sopravvivenza che ogni cittadino doveva affrontare a Baghdad tra caccia alle provviste e preparativi alla guerra, sembravano ugualmente lasciare poco spazio alla paura.
La gente si preparava dedicandosi a qualunque cosa tranne che al pensiero delle bombe.
Esattamente come noi. Scoprii, tra ostentazioni d'indifferenza e moti di nostalgia per una ricchezza ormai scomparsa, perfino piccoli angoli di paradiso perduto che mi davano ogni volta nuove rivelazioni sulla grande umanità e la tenacia d'un popolo condotto in pochi anni dal benessere alla miseria da un dittatore scellerato e da una politica internazionale più scellerata ancora.
Soprattutto le periferie portavano segni profondi della miseria in cui il paese era ridotto, e quasi come una metafora dell'abisso che c'era tra il vertice e la base di quella nazione, molto evidente, di notte, era anche il contrasto tra il buio di quei quartieri e lo splendore del complesso residenziale del rais sfarzosamente illuminato a giorno da una doppia fila di lampioni dalla luce color arancio.
0Giunse il 20 di marzo del 2003. Saddam Hussein rifiutò per l'ennesima volta l'esilio e, come tutti, restò in attesa dello scadere dell'ultimatum. Alle quattro del mattino di quel giorno, col primo raid americano sull'Iraq, la guerra cominciò ufficialmente.
La coalizione disponeva di 300mila uomini, più alcune migliaia di membri della milizia curda e peshmerga, e un numero imprecisato di mercenari di varie nazionalità. Avrebbe usato trentamila bombe e ventimila missili Patriot ad alta precisione, totalizzando un numero mai specificato e certamente altissimo di vittime da una parte e dall'altra.
L'esercito iracheno poteva contare invece su 400mila uomini, ma male in arnese anche a causa delle sanzioni che avevano impedito l'importazione dei necessari pezzi di ricambio. Più 60mila Sunniti, altrettanti Mahdi e vari gruppi di miliziani.
L'avanzata della coalizione fu rapidissima, tanto che già alla fine del primo giorno di guerra, i Marines avevano occupato il porto di Umm-Qasr, tutti i giacimenti petroliferi al sud dell'Iraq ed erano giunti presso Basra. Una tempesta di sabbia aiutò gli iracheni a resistere alcuni giorni in più nei pressi di Hilla e Karbala, tuttavia il 9 aprile, gli americani entrarono a Baghdad, il 10 i Curdi entrarono a Kirkuk e il 15 cadde, poco dopo Mosul, anche Tikrit, la città natale di Saddam Hussein.
Noi giornalisti cominciammo il nostro lavoro. Fu uno strano modo di seguire il conflitto, non da un fronte, in condizioni disagiate e pericolose, con in testa l'idea romantica del corrispondente di guerra che c'eravamo fatti fin da ragazzi leggendo Hemingway. Noi eravamo alloggiati invece in un normale albergo, circondati da computer e stampanti, dotati di cellulari satellitari, e seguivamo gli attacchi in televisione grazie agli operatori della CNN che arrivavano sempre e ovunque con un tempismo di rara ed encomiabile efficacia. Non fosse stato per il rombo maestoso delle bombe che giungeva fin dentro le nostre camere, avremmo potuto pensare di essere quasi a casa. Avrei voluto dire a mia moglie che c'eravamo sbagliati. Certo i fasti del Palestine di alcuni anni prima erano tramontati, il comfort e la sua celebre cucina non c'erano più, ma non si poteva dire che fossimo in trincea, piuttosto ci radunavamo in una specie di grande sala stampa allestita nella hall e da lì seguivamo le operazioni. Ecco tutto.
Però qualcuno usciva a “consumare le suole in strada”, come diciamo noi in gergo, e scortato da soldati e interpreti andava a intervistare la gente comune, a filmare i luoghi caldi, i quartieri degli attacchi e le macerie provocate dalle bombe, i civili che si disperavano sui corpi dei propri morti, e i bambini impauriti e troppo spesso colpiti, senza attendere i filmati ufficiali perfetti e lucidati della CNN da rielaborare per il fondo del rispettivo giornale, o per andare in video all'edizione serale del telegiornale. Finché la capitale fu presa, i simboli del potere di Saddam distrutti, e restava solo da scovarlo a Tikrit, dentro un buco non più grande di un tombino del gas, processarlo velocemente, e impiccarlo sulla pubblica piazza. Cosa che sarebbe avvenuta però solo a dicembre.
Salvo dunque che il rais per adesso era sfuggito alla cattura, tutto il resto sembrava andare come aveva previsto Bush: soluzione rapida del problema. Il paese già liberato. Ma non era così.
Intanto c'era stato l'attacco diretto proprio al nostro albergo, l'8 aprile, durante il quale, grazie al fuoco amico erano morti un cameraman ucraino della Reuters e un operatore spagnolo di Telecinco ed erano rimasti feriti altri due giornalisti. Io mi trovavo a pochi metri da loro, stavo raggiungendo la mia camera quando fu colpito il nostro piano. Ero un sopravvissuto.
Fu quell'atto insensato contro i giornalisti che cominciavano a vedere troppo, a raccontare troppo, giravano, parlavano con la gente, avevano interpreti, sibilavano contro le armi di distruzione di massa che non si trovavano da nessuna parte, e non si accontentavano delle notizie preconfezionate targate CNN, che decisi di sottrarmi alla scorciatoia dell'articolo preconfezionato e di andare a consumare anch'io le suole in strada contravvenendo alle precise direttive di Jack, il quale, solo per proteggermi nella delicata situazione personale in cui mi trovavo adesso, questa volta mi voleva invece più inquadrato nel sistema di quanto fossi abituato ad essere.
Jack, amico mio quanto di Jane, aveva tentato in tutti i modi di farmi tornare in me, di farmi lasciare Cecil e di salvare il mio matrimonio.
Quando seppe del ricatto cedette e la lasciò partire con me solo perché gli promisi che avrei chiuso con lei al mio ritorno, e che non avremmo mai lasciato il Palestine. Mi accontentò illudendosi come tutti che la guerra sarebbe finita presto e con essa anche la mia passeggera follia.
Conoscendomi però non si stupì quando gli annunciai che non sarei rimasto fermo al Palestine e che cominciavo a essere stanco di quella hall d'albergo che somigliava tanto alla piazza di un mercato mediorientale in cui con la smania d'arrivare primi sul pezzo, si potevano comprare notizie fresche (e buoni scatti) a 200 dollari l'una contrattandole come dei comuni mercanti di tappeti.
“Lo sai, io non sono un cinico”, gli dissi una mattina di fine aprile al telefono, “Il cinico non può fare questo lavoro, non è adatto al mestiere di corrispondente di guerra, perché questo mestiere, per come la vedo io, è prima di tutto una missione; presuppone comprensione per la miseria umana, esige simpatia ed empatia per la gente e anche calore umano. La guerra ai nostri giorni scoppia sempre nei paesi molto poveri, ecco perché prima che di giornali e tivvù, bisogna preoccuparsi della povertà e della miseria della gente, di coloro che non possiedono nulla, soprattutto voce per farsi sentire dal resto del mondo, e hanno solo noi a cui aggrapparsi perché il mondo conosca i loro problemi e le vere ragioni che portano le bombe a cadere sulle loro teste innocenti.
Per raccontare la guerra degli altri, occorre capire la dignità degli altri. Occorre conservare la capacità di stupirsi e di essere impressionati da ciò che accade al prossimo e bisogna restare immuni dall'indifferenza. Senza le storie della gente, senza il loro sudore e la loro paura di morire tanto vale non mettersi affatto in viaggio, meglio restarsene a casa ad aspettare l'esito finale...”.
Rassegnato, Jack disse, “Non è me che devi convincere Neil...ma come fai con Cecil?”.
“Non ti preoccupare di lei, saprò spaventarla abbastanza da scaricarla qui”, gli risposi ostentando una sicurezza di riuscirci che in realtà non avevo. Infatti, per evitare di dovergli dare troppe spiegazioni, subito dopo spensi il cellulare e andai a cercare Cecil.
In quei primi giorni di guerra l'avevo molto trascurata, ce l'avevo con lei per il modo con cui mi aveva irretito e manipolato per farsi lanciare da me nel gran mondo della carta stampata; per evitare ritorsioni e proteggere Jane, non avevo ancora troncato con lei, ma preferii avere meno contatti possibili e purtroppo decisi anche che doveva arrangiarsi da sé se voleva trovarsi un buon servizio.
Quando mi risolsi a lasciare l'albergo e avventurarmi fra le bombe, le mine, i missili che ci volavano sopra, le parlai illudendomi che alla fine sarebbe stata lei stessa a lasciarmi e a tornarsene in patria, spaventata dai pericoli che le avrei prospettato. Eravamo usciti a parlare nel giardino dell'albergo. Mi ci condusse lei stessa, non ricordo con quale scusa.
Quando finii di parlarle, esclamò “Era ora”, e aggiunse, “Naturalmente vengo con te, forse te ne sei dimenticato, ma io sono ancora il tuo fotografo e di sicuro non ti lascerò andare là fuori da solo”. Insomma mi ero illuso. Ma ancora in cuor mio pensavo che ai primi reali pericoli se ne sarebbe andata via. Stavamo per rientrare, fuori il caldo si faceva sentire e noi eravamo troppo viziati per rinunciare oltre all'aria condizionata. Ma proprio allora notai un tizio sbracciarsi dall'altro lato della strada e Cecil rispondere al suo saluto con un sorriso di cui non capii subito la ragione.
Era difficile dare un'età a quell'uomo, forse trent'anni, indossava panni tutto un colore con la sua pelle polverosa, ci stava dicendo qualcosa in inglese; gli chiesi se voleva parlare con noi.
Yes! Yes! Gridò quello. Gli feci cenno di avvicinarsi e mentre lo faceva, notai che aveva un bel viso orientale color caffellatte, una sottile barba che lo delimitava da orecchio a orecchio, la fronte alta e la bocca sottile, il collo usciva diritto e deciso dal camicione che indossava sopra calzoni morbidi; le spalle erano scese, ma lui sembrava forte e con mani da uomo che capisce di armi e di corpi di donna, infatti stava guardando Cecil in un modo che non mi piaceva, con due occhi scuri appena fessurati. Che poco dopo si spostarono su di me come due canne di pistola.
Il sudore gli correva lungo il mento, sembrava che gli stesse scavando la pelle formando torrentelli dietro le orecchie, agli angoli della bocca e lungo le tempie.
Ci raggiunse, disse il suo nome, Al Sahdir, e spiegò senza attendere di conoscere i nostri, di essere un interprete e una guida. “Serve bravo interprete a giornalisti americani?”.
Guardai incredulo Cecil che già rispondeva di sì. Io gli spiegai che effettivamente intendevamo lasciare l'albergo per andare a seguire la guerra nei posti dove si combatteva, tra la gente, e che dunque un interprete ci serviva, ma, aggiunsi, se il nostro interprete doveva essere lui, doveva darmi delle credenziali e un piano di viaggio attraverso l'Iraq, non potevo accettare di seguirlo al buio. Cecil mi interruppe e mi spiegò che a questo aveva già pensato lei: aveva lavorato molto in quei giorni (“anche per te che non so dove diavolo eri finito”), e adesso eravamo vicini al grande scoop, ovvero un'intervista al più pericoloso e noto trafficante di tutto l'Iraq. Uno scoop che naturalmente avremmo firmato insieme io e lei, sottolineò, sul giornale più prestigioso d'America.
Al Sahdir si aggirava da giorni nella hall dell'albergo offrendo servigi e informazioni ai giornalisti. L'aveva avvicinata lui, e lei gli aveva offerto una bella somma di denaro se gli avesse procurato una notizia da prima pagina. Al Sahdir le confidò di conoscere un certo trafficante d'arte che era entrato nell'abitazione di un ispettore locale per rubare oggetti e quadri, e invece aveva trovato, nascosto in una statuetta, un documento che dimostrava l'inesistenza su suolo iracheno di quelle famose armi di distruzione di massa di Saddam che erano state il casus belli di questa guerra.
Lui poteva farci avere quel documento, raddoppiando però il compenso che lei gli aveva offerto.
Quella storia non avrebbe retto neanche per un copione da film di terz'ordine, ma Cecil, astuta quanto bastava per irretire me, ma del tutto inesperta su cosa fosse il mestiere di corrispondente di guerra, ci era cascata, presa com'era anche qui a coltivare irresponsabilmente la sua ambizione.
Aveva messo in scena d'accordo con Al Sahdir la farsa del falso incontro casuale nel giardino del Palestine, convinta da lui che quello fosse il posto più sicuro per parlare dei dettagli dell'operazione al riparo dalle orecchie indiscrete dei nostri agguerriti colleghi, e così aveva portato entrambi dentro una situazione assurda e piena di pericoli.
Ebbi il tempo di spiegarle che non è affidandosi a uno sconosciuto senza uno straccio di credenziali, né avventurandosi in un paese in guerra senza una scorta militare, e soprattutto senza informare almeno me e Jack di quanto stesse facendo, che si fanno gli scoop.
Non potei fare nulla però per rimediare al suo errore perché proprio mentre tentavo di trascinarla dentro l'albergo, due uomini sbucarono da dietro le siepi del giardino e raggiunsero Al Sahdir; ci colpirono alla testa e mentre eravamo incoscienti ci caricarono su una jeep e ci condussero in una grotta in mezzo al nulla parecchie miglia fuori Baghdad. Quando rinvenni ero in terra, legato.
Guardai Cecil seduta vicino a me spaventatissima e visibilmente dispiaciuta di aver commesso un errore imperdonabile. E apparentemente irreparabile.
Tutto ebbe inizio tre mesi prima, quando mi lasciai sedurre da questa incantevole sirena.
Mentre attraversavo il guado più insidioso della vita, il tempo della piena maturità, quello che spenge le ondate delle passioni accese, che le fa scivolare via per sempre e alle quali cercavo invece di restare aggrappato, finii per accettare d'incontrarmi con lei dopo un lungo scambio di e-mail.
Lei mi scrive che è bella e fuori dal comune. Mi fa promesse lusinghiere. Mi fa persino percepire, come se mi trovassi nella stanza accanto, attraverso una sottile parete, i suoni lievi ed evocativi che produce mentre si spoglia, il suono di tacchi che cadono a terra mentre si sfila i jeans aderenti, lo strappo appena percettibile dei ganci del reggiseno che si toglie lentamente. Mi seduce con ironica astuzia, giocando. Mi sento adolescente e ho il presagio che la gioventù, con lei, sarebbe tornata ad abitare con me. Infine la incontro: la sirena è veramente bella e fuori dal comune e ancora più giovane di quel che pensavo, mi fa ridere e mi fa sentire bene. Benissimo.
Chi sono io? Un uomo di successo felicemente sposato con il suo primo amore, una compagna di liceo. Jane ed io siamo da sempre la coppia da invidiare. Siamo belli, benestanti, e abbiamo due figli stupendi. Ci svegliamo col bacio lieve del buon giorno e ci avviamo alla nostra felice routine ignorando che fuori il cielo non per tutti è blu.
Quando non parto per lavoro, accompagno io i nostri bambini a scuola, prima di andare al giornale dove lavoro. E' Jane che di solito lo fa, e poi a sua volta raggiunge l'ufficio; lei è dirigente di una grande società di spedizioni situata non lontano da casa nostra.
La sera ci ritroviamo e parliamo fra di noi; nel fine settimana ci sono gli amici, le partite a carte, le mostre, il teatro, il barbecue in giardino. Due stipendi ottimi, un rispettabile conto in banca, l'auto nuova e un cottage al lago. Idilliaco. Una vita da manuale, la mia. Perfetta.
Anche troppo perfetta, ma certo non ci si può lamentare di una vita così.
E io infatti non mi lamento.
Finché sul monitor del mio computer appare il messaggio di un sito mai visto prima.
Vuoi provare emozioni che credevi perdute? Vuoi conoscere persone straordinarie?
Vieni a visitarci qui...
Comprendo subito che si tratta della solita trappola informatica e penso che possa caderci anche mia figlia, curiosa navigatrice adolescente; per questo le raccomando di non arrischiarsi su siti sconosciuti e semmai di chiedere consiglio a me, e lei mi dà ascolto, perché lei ha capito benissimo cosa si fa e cosa non si fa sulla rete. Lei è brava, saggia, prudente. Ma io no, solo che ancora non lo so, anzi, siccome sono adulto, io sì, io eccome posso avventurarmi su certe strade, non ho mica tredici anni. So bene cosa faccio.
Ne sono talmente convinto che decido - soltanto una volta per gioco ovviamente - di entrarci in quel sito, la cui pubblicità mi appare e seduce ormai da giorni, e di rispondere al provocante messaggio di questa tale Cecil che si descrive brillante, bella, giovane, libera e in cerca di una persona non comune, come lei. E usa una frase che mi suona irresistibilmente invitante: se pensi che la tua vita sia già perfetta così com'è, sei la persona che cerco. Sembra scritta proprio a me. So di avere una vita perfetta, sono fortunato io, eppure da qualche tempo qualcosa mi turba, mi sono accorto che spesso mi attraversa un inspiegabile senso di insoddisfazione. Naturalmente ho sempre allontanato da me quelle brevi avvisaglie di smarrimento. E poi quei messaggi.
Mi inducono a domandarmi cosa mi stia succedendo.
E cosa, se non che sono giunto al fatidico traguardo dell'età di mezzo e le mie certezze cominciano a vacillare? Non mi sto perdendo troppe cose? Mentre la pelle si segna, i chili si accumulano e sono costretto a reprimere le emozioni e i desideri, non sto lasciando andare qualche occasione?
In fondo ho sposato la prima donna che ho incontrato, lavoro da vent'anni nello stesso posto, faccio sempre le stesse cose... Non mi rendo conto che è proprio questa la mia fortuna, e la metto in discussione. E poi ecco, per caso (ma esiste veramente il caso?), mi giunge quello strano messaggio che sembra pensato apposta per me, come se questa sconosciuta volesse offrirmi le risposte che cerco. Ma cosa ne sa lei della perfezione della mia vita?
Le scrivo. Sono quello che cerchi, la mia vita è perfetta, davvero. Tu cosa puoi darmi che io non abbia già? Indugio a lungo, poi, clic. Premo invio. Mi pento all'istante ma penso che tanto non risponderà. Sarà di sicuro una burla. Invece risponde. Comunque, prima di leggere cosa mi ha scritto, ho già deciso che finisce lì, qualunque cosa sia, io non risponderò. Invece rispondo.
Andiamo avanti un paio di settimane. Settimane in cui torno a sentirmi come quando inventavo scuse per i miei genitori. Solo che adesso le scuse le devo inventare per mia moglie che non capisce questa novità e si chiede cosa ci faccio da un po' tutta la sera davanti al computer invece di parlare con lei e con i miei figli. Invento scuse su scuse.
Sto già tradendo Jane, ma ovviamente non riesco ad ammetterlo. La mia coscienza è convinta che, dal momento che non si tradisce virtualmente, io non stia facendo niente di male e il mio sia solo un passatempo innocente. Innocente per niente.
Significa che ormai sono dentro la rete di Cecil, ma sono convinto di stare conducendo io il gioco. Lo sono anche quando accetto il fatidico incontro di persona. E metto la mia vita nelle sue mani.
In realtà ero già fin dal primo messaggio nelle sue mani. Mani giovani, sensuali, con dita affusolate e unghie lunghe, curate, dipinte di rosso; mani che sanno andare nei posti giusti, sanno fare le cose giuste (anche tra i meandri dell'informatica), ma non so ancora con quali conseguenze.
Quello che so invece è che lei mi resuscita. La mia vita perfetta mi sembra adesso la vita di un morto. Cecil mi ha travolto e ormai non posso più fare a meno di lei.
Ho imparato a mentire benissimo, temo solo che la sirena mi chieda di lasciare tutto e di fuggire via insieme. Ma per fortuna non lo fa. Non so bene perché, ma la mia vita da morto non la voglio lasciare. Ci sono abituato, affezionato. Anzi, ne ho bisogno come dell'aria che respiro, ma, per quanto assurdo, sembra che non ne sia sempre cosciente. E così vivo le mie due vite parallele con l'eccitazione di un ragazzino alla sua prima tempesta ormonale.
E' stato impossibile sfuggire al fascino di questa ragazza che poteva sembrare al principio fredda e cerebrale e che invece era un miscuglio indescrivibile di controllo e spontaneità.
Cecil aveva gli occhi orientaleggianti, scuri, intelligenti, occhi che restavano calmi, indifferenti, annoiati mentre le parlavo, ma a un tratto, si accendevano di una luce speciale, cominciavano a scrutarmi con sincero interesse, comunicando che significavo qualcosa per lei. Era incredibilmente seducente quel gioco di tenermi in bilico fra il suo interesse e la sua indifferenza.
I suoi capelli erano scuri, lucidi, corti, sulla fronte però spiccava un ciuffo ramato ardente come una fiamma; usava semplici camicette che indossava su jeans aderenti. Le labbra, carnose, di velluto, si aprivano in un sorriso capace di accendere un desiderio così appassionato da far dimenticare tutto, poi si richiudevano in un broncio intrigante che le dava l'aria sbarazzina di una ragazzina persino più giovane dei suoi ventitré anni.
Dunque, tutto avveniva quando mi stava invadendo l'effimera pace dell'uomo arrivato che si gode il frutto dei suoi sacrifici, la sorda inquietudine della morte è tuttora una lontana minaccia perché non si è ancora diventati esseri duri, bisbetici, inaccessibili tipico dei vecchi, ma nemmeno si è più impegnati a piegare il mondo ai propri voleri con la fiducia e lo slancio tipico dei giovani, e tuttavia si sta abbandonando con qualche rimpianto l'età felice delle novità e dei progetti.
Quando la vidi la prima volta era inverno, nell'aria fredda si percepiva il Natale imminente con le sue speciali atmosfere. Quell'aria e il sorriso con cui mi accolse mi riconciliarono improvvisamente con l'operato del tempo che mi aveva trasformato in un opaco impiegato-marito-padre modello.
Andammo a passeggiare a Central Park. Chiacchieravamo come se ci conoscessimo da sempre, il che un po' era vero, visto che c'eravamo scritti fiumi di parole. Quel giorno il cielo era venato di bianco, il sole basso, debole, ma tiepido, i rumori del traffico giungevano attenuati come suoni di un altro mondo, qualcuno faceva footing, e noi ci scambiavamo il primo di molti baci.
Tornai in ufficio ignaro dei piaceri sorprendenti e delle sofferenze oscure che mi attendevano. Ricordo che mi avvicinai alla finestra del mio ufficio e rimasi a guardare oltre il vetro, senza pensare, senza muovermi, colmo di felicità. Il sole cominciava a scendere, mi sembrò di vedere New York lontana sotto di me per la prima volta. Non mi accorsi del tempo che passava.
Abitavo nel New Jersey, allora, per andare e tornare dall'ufficio prendevo il treno. Dopo l'incontro con Cecil furono molte le volte che lo perdetti. Incluso quella. Ma quella volta, quando la sera rincasai tardissimo, fu difficilissimo simulare normalità con mia moglie.
Tuttavia il terribile istante di smarrimento passò e io ripresi a compiere meccanicamente i soliti gesti e a dire le cose abituali come nulla fosse. Dopo aver dato la buona notte ai bambini, preparavo due drink per noi nello studio, Jane e io toccavamo i calici alla nostra salute avviandoci verso la nostra serata e poi... accidenti un messaggio del gran capo , le dicevo con melliflua falsità, scusami ma devo mettermi al lavoro su un pezzo davvero urgente, quindi le davo un bacio distratto e correvo a scrivere a Cecil. Divenni presto ancora più audace. Devo trattenermi in ufficio, mentivo senza ritegno, lo sai com'è qui al giornale... torno col treno delle dieci, ti amo.
E correvo da Cecil.
Lei abitava in un grazioso open flat al Village, arredato in modo ultra moderno, con opere di coloristi americani ed europei, pochi mobili laccati di linea essenziale e molti cuscini.
Quando andavo lì non mi sentivo in colpa. Non mi facevo domande. Seguivo l'istinto, il mio diritto alla vita. Senza perché. Di solito dopo uno rapido spuntino, facevamo l'amore, poi ce ne stavamo in silenzio abbracciati, per assaporare il compiacimento di quel momento.
Lei mi lasciava abitare la sua casa come fosse la mia, notai che da me non sempre era così, Jane era molto gelosa dei suoi spazi, delle sue cose. Del resto anch'io. Mi piacque molto quel senso di condivisione, la trovai una cosa da giovani. Furono proprio la gioventù, la freschezza, la schiettezza di Cecil a indurmi a considerarla un'anima candida. Ma come tutte le anime candide era un'acqua cheta, nascondeva con astuzia gli artigli sotto il paravento della sua spontanea freschezza.
Mi disse che era fotografa, regista di spot e che aveva lavorato anche per il cinema. Un giorno mi chiese di seguirla sul set di alcuni spot. Doveva girare in un paesino di montagna, e potevamo approfittarne per regalarci qualche giorno di vacanza tutti per noi sulla neve prima che partissi, ora che si avvicinava la guerra e io sicuramente sarei andato inviato in Iraq.
Fu così che diedi il meglio di me come bugiardo a casa e al lavoro, e partimmo.
Ma non fu affatto una vacanza da innamorati. Cecil sfruttò invece quella piccola fuga romantica per convincermi a chiedere al mio capo di portare lei con me in Iraq, come fotoreporter, anziché il mio storico amico e collaboratore David. E minacciò neanche troppo velatamente di far sapere al mio capo e a Jane che non ero affatto andato a Boston in quei giorni come avevo detto a entrambi per coprire la mia fuga romantica con lei. Insomma, mi aveva usato per i suoi fini. Lei in realtà era solo una reporter d'assalto in cerca di fama, voleva trovare lo scoop giusto e raggiungere l'empireo del giornalismo sfruttando la guerra e una firma di un giornale prestigioso come il mio ricorrendo al mezzo peggiore, il ricatto.
Rossana Cilli
Biblioteca
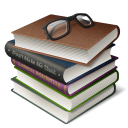
|
Acquista

|
Preferenze

|
Contatto

|
|
