|
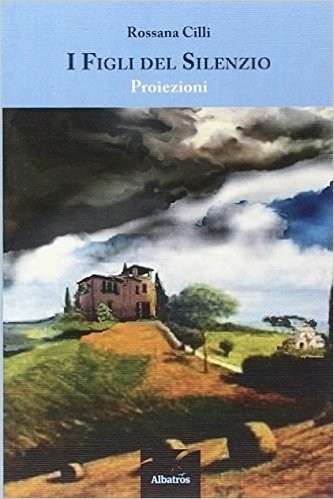  1 – Il caro estinto.
1 – Il caro estinto.
Il cielo, quel gelido mattino di febbraio, era saturo di nuvole rigonfie, d'un cupo color metallico. Sembravano sul punto di esplodere e liberare un terribile carico d'acqua, grandine, neve, o chissà. Veniva da rabbrividire guardando le sue ombre che si addensavano sulla terra e sugli uomini, quello era un cielo che prometteva il peggio. Un tempo senza speranza.
Come don Ferdinando Monforte.
Ferdinando era stato un uomo imponente, altissimo, due spalle pronte a sostenere il mondo, la testa leonina di chioma bianca e ribelle a incorniciare la fronte alta, solcata da tre rughe orizzontali lunghe, perfettamente parallele, chiusa da due ciuffi candidi, marezzati d'argento che quasi occultavano gli occhi ora spenti, ma un tempo guizzanti di brace inquieta; il naso irregolare, troppo grande, venato di viola, piazzato in mezzo a due gote grigie, cascanti, cerule, il collo rivestito di uno strato sottile di cute quasi trasparente, come uno specchio d'acqua arruffato dai capricci del vento, e il mento pronunciato e ora sfrontatamente moltiplicato dalla posizione supina.
Che sarebbe stata la sua per il resto del tempo. Dei tempi.
Perché lui era nel sonno eterno e, tuttavia, ancora temibile.
L'addome, sporgente, fasciato in un panciotto di pregiata lana inglese, appariva meno proteso, contenuto com'era nel rigido abbraccio di un'imponente cassa di rovere tagliata come un sarcofago egizio e impreziosita da quattro pregevoli maniglie. Gli arti, invece, un tempo scattanti e ben torniti, erano divenuti troppo secchi, ma anche a loro il bel vestito scuro di raffinata lana inglese risparmiava l'impietosa esposizione. Così don Ferdinando si presentava al saluto dei convenuti maestoso e autorevole come tutti lo ricordavano prima che la malattia, inesorabile, avesse la meglio su di lui.
Intanto, i fattorini si alternavano alla porta consegnando mazzi e corone di fiori da cui pendevano strisce svolazzanti di moiré viola impresse a caratteri d'oro che il domestico si infilava al braccio come dei cestini di frutta, prima di allinearli addosso a un muro, mentre con la mano libera cercava in tasca qualche spicciolo di mancia. L'aria era satura di quei miasmi pungenti di fiori e acqua ormai putrida, e qualcuno pensava: ecco, è questo l'odore della morte.
Dunque, era un giorno cupo, freddo e pesante, adeguato a un funerale. Scandito dal ruggito lugubre e prolungato del cielo che si mescolava a quel lieve sommesso bisbigliare che culla il dolore con la gentile nenia delle parole di cordoglio.
Dovute? Sentite? I presenti, avviliti quel tanto che bastava, non sembravano provare un particolare dolore. Novantotto anni dopotutto sono una bella età, si saranno detti, allora che c'è da piangere? Questa, in fondo, è una festa per la vita spintasi ben oltre i limiti normali. Eppure qualcuno mormorava: eh però, non fosse stato per la malattia...
Quando giunse il momento di muovere verso la chiesa, una donna allontanò i presenti con parole garbate, poi chiuse le finestre e accostò le tende lasciando la stanza al buio, pregna solo di quell'odore pungente di fiori che raccontava il fatto avvenuto. Il corteo si formò. La gente era tranquilla, in attesa.
Tuttavia zia Carlotta tra tutti appariva davvero inconsolabile, forse perché adesso – malignavano alcuni – le sarebbe toccato andare via da quel bel casale antico subito fuori del centro abitato, fatto di pietre da taglio rosacee, pesanti, posato in mezzo ad una splendida campagna, tra giardini di rose, limoni, tamarindi, e i boschetti di querce e nocciole, dove lei aveva trascorso tutta la sua tranquilla, ma tutt'altro che inoperosa vita di nipote-nubile-dama-di-compagnia di don Ferdinando per lasciarlo ai suoi tre figli. Legittimi, ma assai discutibili eredi.
Loro tre brillavano, infatti, da sempre per assenza, sebbene, naturalmente, fossero accorsi parati a lutto stretto al funerale del padre e recitavano per bene la parte dei bravi figli affranti, malinconicamente seduti stretti uno accanto all'altro al primo banco in chiesa, mesti, silenziosi, protetti da grandi lenti scure, perfette per nascondere occhi asciutti e persi dietro a pensieri lontani. Che tutti però immaginavano.
Fosca voleva vendere subito, dividere e darsi alla bella vita.
Si concentrava su quel pensiero, mentre le labbra simulavano un Padrenostro; Oscar, invece, voleva trasferirsi in villa con tutta la tribù, moglie, figli, nuora, generi e nipoti inclusi, in tutto dodici persone, il che significava però dover mettere le mani sull'intera proprietà; ma a lui delle tenute non importava nulla e contava di lottizzarle e farne un centro residenziale.
Matteo, dal canto suo, rivendicava il suo sacrosanto terzo per farne un atelier, perché si era convinto di essere pittore, anche se una tela da pochi soldi, una volta passata per le sue mani, certamente non valeva più nemmeno quelli. Ma intanto, mentre lui era occupato a riempire tele e tempo, a riempire la pancia ci pensava sua moglie Lucilla, segretaria del notaio. Anche lui presente in chiesa, come tutte le altre autorità del luogo immancabili al funerale dell'illustre defunto. Solo il notaio, in questo caso, attirava però l'attenzione collettiva; tutti lo osservavano, cercando di capire dal modo in cui trattava con gli eredi, come il defunto avesse infine disposto per i suoi beni. Era noto, infatti, che il vecchio patriarca avesse depositato un testamento e che avesse dettato il testo al solo notaio, esigendo che, visto l'evidente conflitto di interessi, non fosse presente la segretaria, cioè sua nuora. Va da sé che lei sarebbe stata poi (inutilmente) torturata dal marito Matteo affinché scoprisse il contenuto della carta; si mormorava che lui, al bieco scopo, l'avesse addirittura spinta nelle braccia del vecchio notaio!
Quei tre figli al don erano arrivati tardi, dalla seconda moglie; la prima era morta ancor giovane, in tragiche circostanze. Dapprima i due maschi, Oscar e Matteo, e per ultima Fosca.
Ma Ferdinando era poi inaspettatamente sopravvissuto anche alla bella donna Susanna, più giovane di lui di quasi vent'anni.
Zia Carlotta, invece, figlia di un fraterno amico di Ferdinando, che era morto fra le sue braccia in America affidandogliela, di anni ne aveva una settantina.
Carlotta era dunque una zia per modo di dire, tanto che i suoi nipoti l'avevano già trasferita mentalmente in una qualche sperduta casa di riposo, cioè un dannato ospizio sotto mentito nome, per prendere subito possesso della villa, dove l'avevano lasciata da sola ad accudire il vecchio padre senza mai dirle neppure un misero grazie.
Ma non c'era solo la villa. C'erano terreni, soldi e molto altro. Un futuro roseo. A parte quel dettaglio del testamento.
Per questo la lussuosa limousine di Ferdinando ancora non muoveva verso la sua ultima dimora, che già Matteo spingeva la moglie verso il notaio.
- Chiedigli se può combinare per le quattro - .
- Di oggi? - .
- Ma è una domanda da farsi? - .
- Tuo padre è ancora... Insomma, che figura ci facciamo? - .
- Insomma? Vuoi arrivare alla sua età, prima di... - .
- Va bene, va bene, ora glielo chiedo - .
Fosca e Oscar, imbalsamati in una specie di contrattura, guardavano il fratello discutere con Lucilla, da lontano. Lei si accostò al notaio, gli parlò in un orecchio, quindi si girò verso Matteo annuendo. La contrattura dei due si sciolse. Ma il sollievo durò poco, perché Lucilla, subito dopo, indicò la zia.
Infine il corteo raggiunse il cimitero. Tirava aria di tempesta, ma non solo in cielo. Che, intanto, manteneva la sua promessa.
Ecco perché alla fine non solo i figli erano impazienti di calare finalmente il defunto nella sua fossa inzuppata, di fuggire via da tutte quelle tombe lucide di pioggia, dalle frustate d'acqua che colpivano implacabili e da quell'inutile lotta contro gli ombrelli rovesciati senza sosta dalle raffiche di vento.
Mentre le cime grondanti dei cipressi, curvate all'ingiù, come per cogliere le loro frettolose parole di cordoglio sembravano ammonirli: Ma dove correte, non lo sapete che toccherà anche a voi? E noi saremo qui, ad aspettarvi. Tutti quanti.
2 – La busta numero uno
Il notaio si aggiustò con calma gli occhiali sulla punta del naso, poi mostrò il sigillo di ceralacca intatto agli astanti seduti (sei in pizzo alle poltroncine allineate davanti a lui, la settima invece in modo molto più rilassato), infine impugnò il tagliacarte e iniziò ad aprire il plico con una tale lentezza da far pensare al gesto studiato e un tantino perfido di chi ha il potere di tenere in pugno gli altri, fosse pure per pochi minuti soltanto.
Fosca, elegantissima, attendeva con finto distacco, mentre una piega di disgusto increspava il suo volto perfetto accorgendosi dell'alone indelebile che il temporale implacabile della mattina aveva osato disegnare attorno alle sue scarpe di vernice lucida.
Fosca era la terza figlia di Ferdinando; come tutti in famiglia era piuttosto alta, statuaria, di carnagione molto chiara che ben contrastava con i bei capelli scuri, aveva un viso ovale di particolare bellezza, soprattutto per via dei grandi occhi neri che parevano creati apposta per abbracciare un campo visivo molto ampio e molto profondo, perché iride e pupilla quasi coincidevano di colore ed erano accentuate da sopraciglia folte, disegnate come un arco allungato e dolce. Le sue labbra erano piccole, carnose. Quando era seria o stava in silenzio, le davano un'aria appena imbronciata, se rideva, però, lasciavano scorgere una doppia fila di denti bianchi, dritti, tranne l'ultimo premolare a destra che era appena inclinato.
In chiunque quello sarebbe stato un difetto, ma nel suo caso era piuttosto una sorta di strabismo di Venere trasferito, perché spezzava la sua perfezione algida, donandole un che di felino.
Il marito Valerio, noto avvocato, ma soprattutto noto come il “principe consorte”, si sforzava di darsi un contegno fingendo interesse per i molti diplomi appesi a una parete, alle spalle del notaio. Anche lui era bello e con Fosca formava una coppia da copertina, ma proprio come una copertina era finta e patinata.
Aveva capelli castani molto scuri, ondulati e lisciati col gel, e la scriminatura a destra. Il volto sempre ben rasato, il naso dritto, le labbra sottili e una piccola cicatrice all'angolo della bocca che gli donava quel fascino da canaglia che tanto era piaciuto a Fosca, insieme al suo portamento eretto, sicuro, da arrivista con pochi scrupoli, quale in effetti era sotto i panni costosi con cui si nobilitava, ma che i suoi occhi chiari, liquidi, invece tradivano, perché guardavano sempre con quell'aria di chi la sa lunga, di chi coglie al volo il punto debole. E colpisce.
Matteo a sua volta faceva finta di essere molto interessato al tempo, scrutava infatti di continuo la finestra alla sua destra.
Matteo era il secondogenito di Ferdinando, bello quasi quanto la sorella, anch'egli di carnagione chiara e capelli scuri, portati un po' lunghi e sapientemente trascurati, perché lui si sentiva artista e non era proprio il caso di essere troppo a posto, come un impiegato qualunque, era l'unico in famiglia ad avere preso gli occhi della madre, cioè verde chiaro. Ma il naso importante e appena storto era proprio quello di don Ferdinando.
Le mani invece no, proprio in nulla ricordavano le mani grandi e robuste, da uomo della terra, del padre, anche se nella realtà neanche il padre avesse mai fatto propriamente il contadino.
A lui il destino aveva riservato mani lunghe, sottili, da pianista. Però la sua presunta arte era la pittura.
Per questo alle giacche preferiva le tipiche mantelle con lo sprone o le eleganti vestaglie da camera lunghe di seta colorata, visto che non lavorava mai e passava le sue giornate a casa a trastullarsi fra colori e pennelli.
A lavorare ci andava, infatti, sua moglie Lucilla. Dal notaio.
Lucilla mostrava un palese disagio, perché era abituata a stare accanto al notaio, e non di fronte, inoltre, sentiva che nessuno credeva ai suoi insuccessi con il suo principale, e questo la metteva ancor più in difficoltà. Come Fosca, non aveva avuto bambini, ma mentre la cognata, non lavorando, aveva tempo di curarsi molto, di frequentare le palestre, e aveva mantenuto anche per questo un fisico asciutto e trofico, lei si era invece appesantita con l'età; manteneva ancora un viso abbastanza fresco, però non era mai stata particolarmente bella. Il viso era un po' irregolare, il naso piccolo ma di forma strana, i capelli crespi e ribelli, una volta castani, ora con la ricrescita evidente di chi si trascura non per mancanza di tempo o di soldi, ma di felicità, come rivelavano i suoi occhi spenti, truccati in fretta e di colore indefinito. Non era particolarmente alta e vicino a Matteo quasi spariva, ma non perché fosse davvero bassa, era lui ad essere altissimo, come tutti in famiglia; insomma non era e non era mai stata una bellezza, però era una gran lavoratrice, un punto di riferimento per uno sfaccendato come il marito che certo non la meritava. Ma se si arrabbiava, erano dolori.
Oscar, seduto in pizzo a una poltrona troppo piccola per la sua mole, ne tormentava i braccioli con quelle sue mani grassocce, sudaticce, dall'incarnato rosaceo che si staccavano da lì solo per afferrare e scartare le caramelle e i cioccolatini che il notaio lasciava a disposizione dei clienti, per tornare subito dopo sugli innocenti braccioli a battere il tempo di una musica inesistente.
Oscar era il più alto dei fratelli, quasi come il padre, ma era il meno bello perché grasso; un po' per colpa di una disfunzione giovanile, un po' perché amava il cibo oltre ogni limite e aveva sempre qualcosa fra i denti da stuzzicare tra un pasto e l'altro.
Nell'insieme era una montagna d'uomo, i capelli li aveva anche lui scuri d'origine, ma ora tutti grigi, li portava corti, sempre ben tagliati; anche gli occhi erano gli stessi di Fosca, ma in lui perdevano di fascino perché infossati in un viso troppo grasso e teso. Sempre ben rasato ed elegante, si intuiva il suo tipo di lavoro dai residui di polvere sulle scarpe. Perché era ingegnere edile e stava spesso nei cantieri, unico neo in quell'uomo altresì ricercato nello scegliere i suoi panni, come se con quelli potesse togliere un po' d'abbondanza a quel che c'era dentro.
Aveva sposato una donna minuta, molto graziosa da giovane, ma di carattere ansioso e nervoso, era Ginevra.
Lei era il suo esatto opposto, magrissima, tutta nervi, il viso triangolare, d'un colorito giallognolo, troppo piccolo per il suo naso importante, sporgente tra due occhi vivaci e ancora belli e segnato sulle guance dai due solchi tipici dell'ulcera nervosa, inevitabile quando si sta sempre dietro a figli, generi, nuore e nipoti, come faceva lei. Ora mostrava un evidente risveglio dei sintomi della sua malattia, per via della snervante attesa.
Carlotta si era invece seduta tranquillamente nella sua comoda poltrona imbottita e appariva molto calma. Era una persona di piacevolissimo aspetto nonostante l'età non più giovanissima.
Da ragazza era stata bella, ma di una bellezza più tranquilla e rassicurante di quella, ad esempio, di Fosca.
Ma non per questo meno corteggiata, anzi. Ma inutilmente.
Mai troppo magra, e neppure grassa, rassicurava forse per il suo aspetto di sana ragazza di campagna.
Da giovane portava lunghi i suoi capelli cenere, morbidissimi; adesso erano corti, ben piegati e tinti di bianco, o argento, o, talvolta, di un curioso violetto; gli occhi nocciola erano grandi, allungati; la chiamavano “occhi da cerbiatta”, ma soprattutto, i suoi, erano occhi buoni, di quelli che quando ti guardano, ti rassicurano, perché la dolcezza della sua persona esteriore era la stessa della sua indole interiore.Ma la sua bontà non le aveva impedito di essere una donna di carattere. Carlotta era forte, saggia e la sua particolarissima storia l'aveva resa anche una donna di polso senza che questo l'avesse snaturata nel carattere mite ma fin troppo riservato. Forse per questo, alla sua età, era ancora una donna di fascino o, più propriamente, di un certo qual carisma.
Il tagliacarte ebbe infine la meglio sulla ceralacca e i sigilli.
Comparvero così sette buste uguali, destinate una a ciascuno dei presenti. Il notaio pregò allora i sette destinatari di leggere le lettere che avrebbero trovato nelle buste appena ricevute a casa propria e in solitudine. Perché questa era la volontà del defunto. Il suo compito – per il momento – finiva lì. Registrò l'avvenuta consegna, appose la data, 16 febbraio 2013, e li congedò.
I sette lasciarono lo studio sbigottiti.
3 – La pazienza di Giobbe
Ci voleva una pazienza certosina a fare quel lavoro, ma poi la soddisfazione era tale che la fatica spariva non appena il film, magicamente, passava sullo schermo in tutto il suo rinnovato splendore, proprio come avviene con una tela preziosa ma ingrigita dal trascorrere dei secoli, riportata all'antica luce da un sapiente restauro. Bisognava esserci tagliati per quel lavoro, però, fatto di pazienza, mestiere, e vista lunga. Una volta gli era capitato di stare addirittura due giorni di fila su un solo fotogramma, molto rovinato dal tempo ma davvero troppo di valore per finire sacrificato, perché esso conteneva la “prima volta” sul grande schermo di una bella e giovanissima Bette Davis, e lui, naturalmente, non si era arreso finché non erano riemersi, dai guasti degli anni, quegli occhi belli e un po' spiritati e la fronte ampia e intelligente della grande attrice, ancora semplice comparsa.
Questa volta però c'era qualcosa che non quadrava.
Versò liquidi su liquidi, spennellò, passò e ripassò solventi, attese l'asciugatura, ricominciò daccapo.
Dentro la pellicola che stava restaurando c'era un fotogramma che proprio non poteva appartenere al film! Al terzo passaggio ne fu certo. Come ci sarà finito qui?
Era una lunga storia e lui certo non la poteva conoscere, ma decise di scoprirlo.
Passò la pellicola alla moviola e fece una cosa inaudita, tagliò via il fotogramma e se lo mise in tasca.
Aggiuntò poi la pellicola con la perizia che solo lui possedeva e si recò nell'edificio accanto, quello degli archivi cinematografici di Cinecittà, e si fece consegnare tutto il materiale che c'era riguardo a quel film del 1932. Non era molto, lo mise in una borsa di pelle e tornò al suo lavoro. Però, adesso, era distratto, guardava spesso in direzione della borsa, poggiata su una sedia accanto a lui e finalmente si arrese al suo richiamo. La prese, ne tolse il fascicolo e iniziò a leggere.
Era un bel mattino di aprile del 1964.
4 – Il lascito.
La moglie di Matteo non si era più presentata al lavoro.
Il contenuto della lettera destinata a lei l'aveva messa in uno stato tale... Nemmeno Matteo però stava meglio.
I coniugi si guardavano e si intendevano senza parlare.
Ma lei alla fine sbottò:
- E secondo te, io col barbagianni ci dovevo pure andare a letto, così lo raggiungevo prima, questo bel risultato! Dimmelo tu adesso dove ce li mettiamo il cavalletto nuovo, i colori nuovi, le tele nuove, le tavolozze nuove, il camice a sbuffo nuovo, l'accidente che ti colga nuovo! - . Così dicendo, Lucilla perdeva il controllo in un crescendo di ira e, prendendo in mano uno a uno gli strumenti che nominava, prima li agitava in aria mostrandoli al marito, e poi li gettava in terra, finché arrivò il turno di un quadro dipinto di fresco che scaraventò contro il divano bianco, stramaledicendo il giorno che il marito s'era messo in testa di essere Raffaello.
- Tutto a quei due là ha lasciato il vecchio, e a te un bel niente. Al figlio artista questo bel pezzo di carta e tanti saluti! Io non riesco a crederci mentre tu te ne stai lì come uno stoccafisso, senza reagire, senza fiatare! - .
- Tesoro, non lo sappiamo cosa ha lasciato ai miei fratelli - .
- È chiaro no? - .
- Non lo è affatto: ho incrociato Fosca poco fa, l'ho salutata, lei mi ha risposto appena, era scura in volto e secondo me è più nervosa di te - .
- Allora è andato tutto a Oscar. Quel porcello. Dai a fare figli, e i figli, nipoti su nipoti. E così, ci hanno fregato! - .
- No, non è così, Oscar mi ha telefonato mentre tu eri fuori. Dapprima faceva l'ironico, voleva farmi i complimenti per l'eredità, figurati, ma poi ha capito che anche noi... - .
- Carlotta! Quella, vaga vaga, molle molle, se l'è lavorato bene bene. E io lo sapevo! Quante volte ti ho detto di farti vivo ogni tanto con il tuo vecchio e tu niente, e invece dagli a impiastrare di qua e a impiastrare di là. E ora guarda come hai ridotto il divano bianco! - .
- Io? - .
In quel momento suonarono alla porta. Era zia Carlotta.
- Salve miei cari, volevo salutarvi. Dunque è toccata a voi. Beh auguri di cuore. Io me ne andrò via presto, non preoccupatevi. Anche se certo mi spiace un po', ero molo affezionata a quella casa. Vorrei davvero che non la vendeste, né la modificaste, è talmente bella così come è... - .
- Ma come, non l'ha lasciata a te? - .
- No, no, pensavo a te Matteo, visto che Fosca e Oscar mi hanno detto che a loro, niente - .
- Insomma, sette stupidi pezzi di carta ci ha lasciato il vecchio, ecco tutto - concluse Lucilla.
- Forse no. A questo punto, ho idea che le lettere siano tutte e sette uguali e che in quelle parole ci sia dell'altro. Solo quando capiremo cosa, sapremo davvero quale eredità ha lasciato lo zio, e a chi - .
“Ma sentila, dell'altro. Ha parlato la solita sapientona!” pensava Lucilla mentre Carlotta terminava la frase. Poi, per fortuna, squillò il telefono. Era il notaio.
- Salve Lucilla, volevo sapere se domani sarà in grado di uscire. Sa, il suo defunto suocero ha lasciato dell'altro da consegnarvi, ma devo avervi tutti qui una settimana esatta dall'apertura della prima busta, cioè domani - .
- Ma certo, signor notaio! Domani ci saremo tutti. Anche la zia che adesso è qui da noi; l'avverto io. Anzi, avverto tutti io - .
- Che vi avevo detto? Ma cosa è successo al vostro divano? - .
Rossana Cilli
|
