
 La mia unica consolazione è la mia passeggiata giornaliera. La mia unica consolazione è la mia passeggiata giornaliera.
Tutte le mattine, prima di pranzo, percorro lo strapiombo di arenarie, fino al faro che si erge solitario in cima al promontorio.
È un faro in muratura, dipinto di bianco, tranne la punta rossa.
A volte ci salgo in cima, e da lassù ammiro l'orizzonte.
Anche durante queste camminate non sono completamente solo.
Sono sempre accompagnato dagli uomini in verde. La Guardia Nacional.
Mi lasciano libero, solo quando salgo sul faro.
Penso siano loro i veri Dittatori.
Non li ho mai sentiti scherzare, né ridere.
Sempre seriosi.
Sempre ligi al dovere.
Mi chiedo se non abbiano subito un qualche tipo di “trattamento”.
Quando sono in cima, finalmente solo, mi chiedo se mio padre non l'abbia fatto apposta.
Se non abbia voluto vendicarsi di mia madre, che si è fatta mettere incinta da un uomo sposato.
Sua moglie credo fosse sterile.
Forse lui non voleva figli, solo un'avventura.
Di una sola notte, magari.
Quando sono lassù, mi sento spaiato.
Sento di essere come l'idrogeno.
Una sola particella subatomica.
Posso respirare.
Guardo la linea infinita, eppure appena percettibile dell'orizzonte.
Avverto il mischiarsi dei colori, il loro fondersi.
Ammiro il quadro cangiare nelle sue varie sfumature.
Mi sembra, a volte, tutto un sogno.
Eppure non lo è.
È tutto dannatamente reale, e io sono il cattivo.
Con il suo monopolio.
***
Solitamente il malvagio delle fiabe è cattivo per il suo comportamento, o per una concezione comune impostaci dalla società vigente. Eppure guardatemi, suvvia, non ho la faccia da cattivo. Col mio sorriso ammagliante da venditore. La mia uniforme lustra, e la mia bella mogliettina tutta perfetta. Così perfetta da sembrare una star di Hollywood.
A proposito di Hollywood, rammento ancora la prima volta che giunsi a Los Angeles.
Arrivammo in aereo.
Era una giornata afosa.
Una di quelle che ti secca la gola.
Ricordo la gente vestita con short e infradito.
Gli occhiali da sole, e i cappelli a tesa larga.
Il soffitto bianco dell'aeroscalo, leggermente ricurvo.
Le tante luci, e il mio smarrimento.
Il mio paese era più piccolo dell'intero aeroporto.
Speravo di tornarci un giorno.
Non so neanche se esista ancora.
Se qualcuno è sopravvissuto alle radiazioni.
La famosa scritta non la vidi, comunque, quel giorno. Passò parecchio tempo, in realtà.
Boston
Le giornate scorrono lente sotto i miei occhi.
Sembrano come tanti fogli da scrivere, ma che non si riempiono mai.
Penso ai tempi passati, in cui non avvertivo il peso del mondo gravarmi sulle spalle; in cui l'unica preoccupazione era lasciare il tetto materno.
Rimembro ancora l'ansia del giorno prima della partenza per Boston.
Avrei alloggiato all'interno del campus di Harvard, a Cambridge.
Per la prima volta sarei andato a vivere da solo.
Ricordo le continue raccomandazioni di mia madre.
Rammento l'elettricità che provammo nell'abbracciarci.
I suoi occhi lucidi.
Riappare davanti ai miei occhi la mia valigia malmessa.
I vestiti piegati bene.
Le mutande in abbondanza.
Lo spazzolino.
Il pettine di legno.
C'era tanta speranza in quell'involucro spelacchiato.
Quando giunsi a Boston, notai subito le differenze rispetto Los Angeles.
Il clima era diverso innanzitutto.
Non c'era quel continuo caldo afoso, e l'aria era più pura. C'era molto più verde.
Ed erano diverse anche le case. Pure i tetti erano differenti.
Era molto più utilizzato il mattone rosso, sembrava quasi di essere piombati in Inghilterra.
Erano scomparsi i colori chiari di Los Angeles, quasi latini.
Inoltre, in inverno, vidi la neve.
Soffice e morbida, così diversa da ogni cosa che avessi mai visto prima d'ora.
E come se non bastasse, la città di Boston era intrisa nella storia d'America.
Qui era nata la Rivoluzione Americana.
Molti patrioti erano nati o vissuti qui.
Conservava ancora alcuni edifici del XVIII secolo come: l'Old State House, la casa di Paul Revere e la Old North Church.
Tutto era tremendamente differente, la stessa Harward era diversa.
Sembrava di essere in una città nella città.
Accanto vi era il MIT con la sua modernità, e noi ancora con le nostre tradizioni.
Ovunque si respirava prestigio. Molte menti eccezionali avevano calcato i miei stessi edifici, i miei stessi corridori, e perché no, la mia stessa camera.
La stanza che mi fu assegnata era spartana. Aveva pareti bianche e letti piccoli.
L'avrei condivisa con un americano di origine asiatica che frequentava economia, e con uno snob, figlio di un famoso giudice, che voleva diventare magistrato.
Non chiacchieravo molto con loro, in realtà non parlavo molto con nessuno.
Io ero lì per studiare. Dovevo essere il migliore e non potevo fallire.
Ero conscio che sarei stato l'orgoglio di mia madre.
Se avessi già saputo all'epoca il vero fine di mio padre, probabilmente non avrei studiato tanto.
Avrei, addirittura, cercato di farmi espellere.
Non provavo a compiacerlo, non ho mai voluto.
Rammento con dolcezza quegli ultimi momenti spensierati, seppur non abbia vissuto appieno la vera vita universitaria.
Io ero un estraneo lì.
Ero il figlio bastardo.
E tutti lo sapevano.
Come se avessi un marchio addosso. Come se il mio olezzo mi precedesse.
Sembrava quasi che nell'aria fosse scritta tale parola.
O che avessi un'etichetta stampata sulla fronte.
***
Recentemente ho visto un film, come detto mi sono fatto costruire una sala cinematografica: con tanto di proiettore e impianto dolby surround.
La sala è ornata di statue di Michelangelo, Donatello e del Bernini. Tutte acquistate al mercato nero. Quelle che contemplate nei luoghi originali sono solo delle perfette imitazioni.
Pensate un po': la gente va a Firenze convinta di ammirare il David di Donatello, e invece è a casa mia.
Immerso in quest'arte antica, mi gusto le opere contemporanee.
L'ultimo film che ho guardato è: “Il dittatore”.
Volevo vedere, capire cosa pensano gli altri di noi, di me.
Se appaio così ignorante, così buffo e crudele.
Se è vero che non cambierò mai, e nemmeno il mio popolo cambierà mai.
Vorrei fare di più per chi governo.
Bramo aiutarli, fare qualche riforma.
Dare loro qualche cura e invece niente.
Mi sento come nel film: intrappolato tra interessi e malvagità.
Purtroppo, siamo esseri fragili ed egoistici.
Finché stiamo bene noi, va tutto bene.
Perché, dopotutto, dovrei rischiare di morire.
E poi, in fin dei conti, il mio successore potrebbe essere persino peggiore di me.
Poterebbe mettersi in testa strane idee.
Di rivoluzionare, cambiare tutto, e magari creerà instabilità.
E le già fragili condizioni del popolo potrebbero vacillare, persino inasprirsi.
Non vi è mai limite al peggio.
Visione onirica
Ultimamente faccio uno strano sogno, che assomiglia più a un incubo.
Sono di nuovo nel mio paese d'infanzia. Sembra tutto normale.
Le case sono come me le ricordo.
Come se non fossi mai andato via, come se il mondo non fosse cambiato.
Sono cadenti come allora, ma almeno non vi è traccia di alcuna bomba.
La gente del paese sembra felice, quasi spensierata.
Possiede poco ma è comunque sorridente.
Essere vivi è più che sufficiente.
Il bar è ancora al suo posto. Con le bibite ghiacciate e la televisione scolorita.
I miei compagni di giochi sono ancora là, nello stesso spiazzo a inseguire un pallone.
Sempre nella medesima partita, che appare infinita. Sognano di giocare e basta, per sempre.
Arrivo al campo. Chiedo se posso unirmi a loro.
Prometto che non entrerò in contrasto, che non scarterò.
Finalmente gioco, come una volta.
Mi sento contento dopo tanti anni.
Non ricordavo neppure più il sapore della felicità.
A un certo punto mi arriva il pallone. Mi guardo intorno. Nessuno dei miei compagni è libero.
E allora parto. Palla al piede. E comincio a scartare tutti i miei giovani avversari. Ignorando la mia promessa. Mi sento leggero. Mi sembra di avere ali al posto dei piedi.
Arrivo davanti al portiere. Faccio una finta. Invece di tirare a incrociare calcio sul primo palo. Ed è gol.
Mi sento appagato, una gioia indescrivibile.
Solo se l'hai provata almeno una volta, puoi capirla.
Mi giro, con le mani alzate, i pugni chiusi al cielo.
Cerco i miei compagni, vorrei abbracciarli ma non c'è più nessuno.
Sono tutti proni sul campo da calcio.
Li guardò meglio: hanno visi esangui e occhi chiusi.
Non sento più nessuna voce, nessun rumore.
Mi avvicino al mio caro amico Miguel.
Lo stringo tra le braccia.
Provo a scuoterlo.
Non risponde.
Urlo.
Mi dispero.
Poi lo rimetto lì, delicatamente, su quel terreno polveroso.
Guardò le mie mani.
Sono rosse.
Comincio a piangere.
Mi prendo la faccia tra le mani.
Sono disperato.
Quando riapro gli occhi, vedo la pelle delle mie mani come scomporsi.
Come fossi ammalato.
Sembro un serpente. La mia pelle è tutta squame.
Non capisco.
Non è colpa mia, grido verso il cielo, verso Dio.
Poi mi sveglio, sempre a quel punto.
Tutto sudato.
Di nuovo nel mio letto dorato.
Tutto solo.
Come in una notte senza luna.
Pietro Castellini
Biblioteca
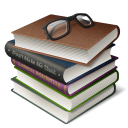
|
Acquista

|
Preferenze

|
Contatto

|
|
