|
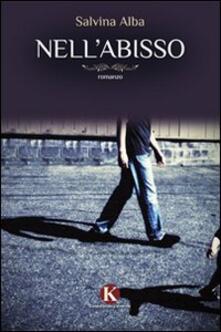  Apro gli occhi di scatto, smarrito. Ogni giorno mi sveglio smemorato. Per alcuni fortunati secondi non ricordo chi sono, cosa faccio, dove sono. La mia vita si riduce a quei pochi, fra-gili istanti.
Apro gli occhi di scatto, smarrito. Ogni giorno mi sveglio smemorato. Per alcuni fortunati secondi non ricordo chi sono, cosa faccio, dove sono. La mia vita si riduce a quei pochi, fra-gili istanti.
Mi giro verso sinistra e scorgo Giulia. E' sempre lì, ogni mattina e, come ogni mattina, mi chiedo come mai non si sia ancora stancata di me. Non sono certo il compagno ideale per lei, forse lei non è la compagna ideale per me. Abbiamo unito le nostre solitudini, tutto qui.
Ha avuto una storia difficile con un altro uomo. Quando i nostri destini hanno preso la stessa direzione due anni fa, era convinta che non ci sarebbe stata un'altra possibilità per lei, che comunque non avrebbe permesso a se stessa di averne. Poi si è specchiata nel mio sguardo e si è riconosciuta, ha ritrovato il suo dolore, un po' più grande. Non ha mai saputo perché.
Non dice di amarmi e io non dico di amarla. Oltre che una parola presente sul dizionario, cos'è davvero l'amore? Mi pia-cerebbe conoscere una persona che sia in grado di giurarmi di amare o di aver amato davvero. Non per pochi attimi o per po-chi giorni o nel migliore dei casi per pochi anni, come facciamo tutti, ma per sempre e con tutta se stessa, superando i propri egoismi. E' davvero possibile? Sono forse io l'unico essere umano incapace di amare e di essere amato?
Non so perché continui a respirare, quale forza interiore o sovrannaturale riesca a tenermi in vita, eppure sono qui nel mio letto, accanto a Giulia. Più tardi mi alzerò, lavorerò, mangerò, riderò, parlerò con gli altri, proprio come se non fosse mai ac-caduto nulla, come se io fossi una persona come tutte le altre. Ma forse sono una persona come le altre. Ho rinchiuso in un angolo recondito del mio cuore i misteri, le pene, le colpe e ho cercato di convincermi di averli dimenticati, di essermene libe-rato per sempre. Forse è necessario ingannarsi per poter prose-guire, per non affondare nelle sabbie mobili del passato, eppu-re in qualche punto imprecisato del mio io, so che non è così. Non ci si libera, non si dimentica.
Guardo la radiosveglia sul comodino e fisso i due puntini lampeggianti, non so perché. All'improvviso la mia mente si svuota, è libera finalmente. Vorrei che fosse sempre così. Ma Giulia si muove, si gira su un fianco e mi tocca un braccio.
“Che ore sono?” chiede con gli occhi ancora chiusi.
Io la osservo ma vedo un altro volto, gli stessi gesti, le stesse parole. Come allora, non riesco a rispondere.
“Lorenzo, dormi?” sussurra piano sfiorandomi appena.
“No, sono sveglio” bisbiglio continuando a fissarla.
Finalmente apre gli occhi. E' sorpresa o irritata, non so.
“Perché non mi rispondi allora? Ti ho chiesto che ore so-no.”
“Sono le otto e un quarto.”
Mi sollevo un po' e appoggio la schiena sulla testata del letto, lei si avvicina e cerca un rifugio nell'incavo dell'ascella, accostando la testa al mio petto. Non sono in vena di tenerez-ze. La allontano con un gesto brusco, mi alzo in fretta.
“Non ti va di restare ancora un po' a letto? E' presto” mi invita ammiccante.
“Ho da fare” le rispondo sbrigativo, ignorando il suo ri-chiamo.
Giulia sa che è meglio lasciar perdere e infatti non dice più nulla. Circonda il cuscino con le braccia e vi affonda il viso fingendo di tornare a dormire. Non mi chiede nemmeno cosa ho da fare.
Indosso solo le mutande, ho freddo. Cerco qualcosa con cui coprirmi, ma la poltroncina accanto al letto è vuota. Non riesco a ricordare dove ho lasciato i vestiti ieri sera, non lo ri-cordo mai. Infilo la prima maglietta che trovo nell'armadio e assurdamente il disordine che vi regna mi sorprende, come se lo vedessi per la prima volta. Certo, un tempo non era così. Tutti i miei indumenti stavano perfettamente ripiegati e alli-neati nei cassetti e negli armadi come soldatini ubbidienti, ma allora era mia moglie ad occuparsene, la donna per la quale avevo perso la testa al liceo e che ho creduto di amare per tan-to tempo, fino al tragico momento in cui ho compreso che il mio egoismo era l'unica cosa che ero in grado di elargire, spar-gendolo attorno a me come chicchi di grano che attecchiscono, senza fallo, ovunque si posano. Avevo avuto tutto il tempo di contagiare anche lei, ora lo so.
“Era destino, doveva andare così” mi dissero i più compas-sionevoli o i più ipocriti per impedirmi di sprofondare nel bara-tro.
“Che cosa hai fatto? Come hai potuto?” chiesero o pensa-rono tutti gli altri per spingermi più in fretta e senza scampo nell'abisso. Non attendevano risposta perché risposta non c'era.
Richiudo l'anta dell'armadio, infastidito. Cosa me ne im-porta se le maniche delle camicie sbucano fuori dai maglioni appallottolati e le magliette si contorcono su se stesse, quasi fossero preda di un tormento incomprensibile? E' uno scompi-glio che non mi riguarda. Nessuno in ufficio si azzarderà mai a farmi notare che i miei abiti sono sgualciti o male abbinati e sa-rà quindi come se fossi l'uomo più elegante della terra. Le pa-role non dette non hanno alcun valore, non mi fanno paura, non più almeno.
Mi accosto alla finestra chiusa ma non oso aprirla. Devono esserci due o tre gradi all'esterno, non di più. Fa sempre fred-do d'inverno in questa città. Perché l'ho scelta? Volevo di-menticare il caldo soffocante a tutti i costi? Ma no, ho chiesto il trasferimento a Milano perché era l'unica sede disponibile, non ho scelto un bel niente, in realtà.
Guardo fuori, la strada è deserta. Sono le otto e un quarto di un sabato mattina, chi dovrebbe esserci? Mi dispiace che l'azienda in cui lavoro chiuda i battenti il sabato. Se avessi la facoltà di decidere io, lavorerei probabilmente anche la dome-nica. Solo quando mi concentro sul lavoro perdo la nozione del tempo, dimentico ogni cosa. Per mesi l'ho odiato per que-sto, sono stato sul punto di presentare le mie dimissioni, sono stati sul punto di licenziarmi, poi invece ho chiesto e miracolo-samente ottenuto il trasferimento.
La strada è bagnata e il cielo è minaccioso. Ha piovuto tut-ta la notte e pioverà ancora. Non ho voglia di uscire, non ho voglia di fingere stamattina, neanche con Giulia. Mi vesto in fretta e mi rinchiudo nel mio studio per fuggire dal mondo e da me stesso. So che nessuno mi disturberà per un po'.
Il computer è acceso e il mio dito corre veloce sulla tastie-ra sfiorandola appena. Scrivo una relazione che dovrei conse-gnare lunedì. Sono laureato in fisica applicata e nell'azienda in cui lavoro mi occupo del coordinamento di progetti di diagno-stica medica, tesi ad integrare immagini che si ottengono con diversi approcci tecnici. Ai più sembra una roba piuttosto complicata, anche a Giulia.
E' appena entrata nel mio studio dove sono rimasto appar-tato per tutto il giorno. E' alle mie spalle e mi osserva in silen-zio.
“Ma perché non usi anche l'altra mano?” esclama infine, spazientita.
Il dito si blocca. Ormai ho perso la concentrazione.
“Cosa?” chiedo volgendomi verso di lei.
“Perché non usi anche l'altra mano? Finiresti più in fretta” ripete.
“Faccio più in fretta così. Perché non ti fai i fatti tuoi?” re-plico infastidito.
“Sono fatti miei. Sono le sei. Lo sai che ci stanno aspet-tando.”
“Devo assolutamente finire questa relazione. Perché non vai tu?”
“Sei sempre il solito orso e la relazione è solo una scusa per restartene rintanato in casa.”
Giulia non teme lo scontro quando vuole. Rimango immo-bile, lo sguardo fisso sul cursore che appare e scompare. Non scrivo più, non parlo più. Naturalmente ha ragione. Non lo ammetterei mai.
“Comunque non importa. Vado a telefonare per avvertirli che non andiamo” aggiunge strategicamente rassegnata. E' una tattica che funziona sempre.
“Ti piace rompere, vero?” esclamo stizzito mentre attivo la procedura per spegnere il computer: start, chiudi sessione, ar-resta il sistema...
“Vado a prepararmi, contenta?”
Sono arrabbiato. Mi rifugio in bagno e lascio scorrere l'acqua nella vasca mentre una schiera di ricordi si affaccia alla mia memoria. Cosa mi succede oggi? Riconosco fin dal mo-mento in cui sollevo le palpebre al mattino, le giornate che si trastulleranno tartassandomi l'anima. Oggi è una di queste. La telefonata che ho ricevuto ieri pomeriggio non è stata certo priva di conseguenze. Ecco perché mi sono rintanato nello studio come un animale ferito in cerca di sollievo e protezione, per questo mi sono immerso nel lavoro senza concedermi una pausa, una distrazione. Adesso però non ho più difese. Guardo la vasca vuota e vedo lui.
Immerso fino alla vita e circondato da pentolini, barattoli-ni, vaschette, cucchiaini e contenitori vuoti di bagnoschiuma che galleggiano ondeggiando, sguazza allegramente nell'acqua. Poi mi guarda, strizza il pupazzetto che ha appena riempito e mi spruzza addosso l'acqua insaponata proprio sul-la giacca del vestito nuovo. Ride felice con la sua bocca sden-tata, evidentemente trova la faccenda divertente e la mia ira evapora in un solo istante.
“Sei una piccola carogna, mi hai bagnato tutto” gli dico solleticandolo sul petto nudo e sotto le ascelle.
“Ci pensi tu, Lorenzo?”chiede ad alta voce mia moglie per farsi sentire dalla camera da letto.
“Come faccio? Mi ha già bagnato la giacca” le rispondo raggiungendola.
“Sei il solito egoista. Devo fare sempre tutto io” replica contrariata ed io penso che, dopotutto, è un'ingrata.
Ingrata! Apro il rubinetto e lascio scorrere l'acqua. Mi in-nervosisco ancora di più perché non riesco a trovare la tempe-ratura giusta. E' una cosa stupida, me ne rendo conto. Si dice che la sofferenza ci renda più maturi e consapevoli, soprattutto più equilibrati. Non sempre è così, purtroppo. In me si annida una rabbia profonda che mi rende suscettibile e irritabile. Chi mi sta attorno evita di provocarmi, sa che le mie reazioni pos-sono essere imprevedibili, sa che in talune circostanze è prefe-ribile lasciarmi stare.
La vasca è piena d'acqua tiepida. Non è la temperatura che prediligo, ma decido di infischiarmene e, senza esitare, mi immergo in essa rabbrividendo. Lascio che l'acqua mi ricopra interamente come se fossi morto e sepolto. E' una bella sensa-zione. Trattengo a lungo il respiro, poi sono costretto a tornare alla vita per procurarmi l'aria. Devo sbrigarmi, Giulia mi aspet-ta, i suoi amici ci aspettano. Ci hanno invitato a cena. E' saba-to sera e non si può restare soli in casa il sabato sera, non è for-se così?
Sto per suonare il campanello. Mi fermo un attimo prima e guardo l'orologio: le otto in punto. Spero fortemente che ci siano molti invitati per mimetizzarmi con più facilità. Non ho alcuna voglia di sostenere una conversazione, né di distribuire generosamente forzati sorrisi di circostanza. Non ho un solo amico in questa città fredda, non ne voglio. Ad un amico devi aprire il cuore, devi mostrare ciò che celi a chiunque altro, non voglio farlo.
Giulia nota la mia esitazione, mi pungola su un fianco con la mano.
“Dai, suona. Cosa aspetti?”
“Facciamo ancora in tempo ad andarcene via” suggerisco serio.
Giulia crede che si tratti di uno scherzo.
“Ma piantala” dice ridacchiando e spingendomi da una parte. E' lei a suonare. La porta si spalanca subito dopo come le bocche di Alice e di Giulia che si sorridono e si abbracciano calorosamente come se non avessero condiviso lo stesso uffi-cio fino al giorno prima, come se incontrarsi fosse la cosa più meravigliosa capitata loro da mesi. Li osservo con distacco come uno spettatore casuale. Credo ingenuamente di non po-tere essere coinvolto e invece Alice abbandona la sua amica e si volge verso di me. Mi accoglie con lo stesso falso (o vero?) entusiasmo. Mi sforzo di ricambiare.
Entriamo e siamo già in salotto. Fausto, il marito di Alice, è seduto sul divano e sta conversando con altre due coppie. A quanto pare, siamo gli ultimi ad arrivare. Si alzano tutti con-temporaneamente per accoglierci. Abbracci, baci e sorrisi si sprecano. Ho voglia di scappare.
Finalmente ritorna la calma. Alice si avvia verso la cucina seguita da Giulia e noi ci accomodiamo sui divani. Fausto ri-prende il suo racconto dal punto in cui è stato interrotto. Si ri-volge a me, educatamente mi fa una sorta di riassunto per permettermi di seguire il discorso. Faccio fatica a non dirgli che non me ne importa nulla.
“Stavo raccontando quello che mi è successo stamattina. Due clienti, madre e figlia, volevano comprare un tailleur ma non riuscivano a trovare un abito che fosse di loro gradimento. Ho dovuto tirar fuori tutti i completi che avevo in negozio e poi quando finalmente hanno scelto quello che preferivano...”
Evidentemente la storia era arrivata a questo punto perché Fausto continua adesso a raccontare, rivolgendosi agli altri ospiti. Smetto di ascoltarlo. Mi perdo nelle tenebre.
Si sta arrampicando sulle mie ginocchia tutto serio e con-centrato come se stesse scalando il K2. Resisto un po', poi lo afferro impietoso e lo rimetto a sedere provocando il suo pian-to. Riprendo a chiacchierare con i miei amici.
“Volete sapere cosa mi è successo, l'altro giorno? Non ci crederete ma mentre tornavo a piedi verso casa, ho visto una macchina che posteggiava accanto a due bidoni dell'immondizia. Allora ho pensato che quel tizio doveva esse-re stupido oppure doveva buttare dei sacchetti nella spazzatu-ra. Stavo dunque proseguendo per la mia strada quando ho sentito quel signore chiamarmi per nome. Sapete chi era? Vi ricordate Marcello, il nostro compagno di liceo che al quarto anno si è trasferito con tutta la famiglia negli Stati Uniti? Be', era proprio lui. Avreste dovuto vederlo...”
“Perché? Com'era? E' cambiato?”
“E cosa ti ha detto? Vive ancora in America?”
“Si ricordava anche di noi?” mi chiedono incuriositi i miei amici.
Io tento di rispondere mentre lotto con il mio bambino di due anni e mezzo che ha ripreso, imperterrito, la sua frenetica attività, deciso a portare a termine la sua impresa. Il suo obiet-tivo: strapparmi i capelli.
Mi rivolgo a mia moglie, esasperato.
“Luisa, prenditi questo bambino, per favore.”
“Ma non puoi badarci neanche cinque minuti? Sta solo giocando” replica risentita.
La voce di Paolo, socio in affari di Fausto, mi riporta alla realtà. Fissa alternativamente lo schermo del televisore e il te-lecomando con il quale sta tentando di alzare il volume.
“Ma non è la tua città, quella?” mi chiede incuriosito.
“...giovane versa in condizioni disperate nell'ospedale Cannizzaro di Catania mentre del misterioso pirata della strada si è persa ogni traccia. Ora passiamo...” dice con espressione grave una giornalista dai capelli ramati, tanto avvenente da sembrare un'attrice.
Io continuo a fissare lo schermo, anche quando le immagi-ni raffiguranti le familiari vie della mia città, sono scomparse.
“Non correre così, Lorenzo. La polizia potrebbe fermar-ci.”
“Chi se ne frega. Ho fretta di portarti in paradiso.”
“E se mia madre scopre che non siamo andati a scuola?”
“Smettila di preoccuparti, Luisa” le dico mentre scendia-mo dalla moto e ci togliamo il casco. Posteggio in un angolino appartato e di corsa entriamo nel giardino pubblico. Non deve vederci nessuno. Ci rifugiamo dietro un grosso olmo e ci ab-bracciamo, impazienti.
“Questo è il nostro paradiso. Nessuno ci farà tornare sulla terra, te lo prometto. Ti amo tantissimo. Ti amerò per sempre” le sussurro in un orecchio, mentre tento di baciarla con tra-sporto.
Già, per sempre. La favola dell'amore eterno.
“Dovrebbero rinchiuderli in una prigione e buttare via la chiave. Ecco cosa dovrebbero fare a quelli lì” sta intanto di-cendo Paolo.
“E' davvero pazzesco. Ma come si può investire qualcuno e non prestare soccorso...?”
“Ma che razza di persona può comportarsi così?”
“Chi vuoi che sia? Gentaglia, delinquenti, vagabondi. Pen-si forse che potrebbe capitare a una persona normale? Io non credo proprio.”
“E chi lo sa?” interviene Giulia “chi può dire come reagi-rebbe una persona qualunque in preda al panico? Forse sarebbe meglio evitare di giudicare.”
“Per me, chi sbaglia, deve pagare e basta. C'è troppo lassi-smo, troppo permissivismo, troppa comprensione nella nostra società. Continuando così, andrà a finire che non potremo più uscire di casa e magari dovremo anche chiedere scusa a chi ci fa del male” ribadisce Paolo, risoluto.
“E tu, Lorenzo, cosa ne pensi? Non dici niente? Sei più ta-citurno del solito, questa sera. Qualcosa non va?” mi chiede Fausto mentre Alice ci annuncia provvidenzialmente che la cena è pronta e possiamo trasferirci in sala da pranzo.
Mi sento traboccante di gratitudine verso Alice. Cosa avrei potuto rispondere? Che oggi è una delle mie giornate no? Che non sono davvero la persona più adatta per giudicare le azioni dei pirati della strada, né di chiunque altro? Che è già un'impresa badare alla mia claudicante vita e alla mia incasina-ta coscienza senza dovermi preoccupare anche di quella degli altri? Sento che il cuore mi si fa piccolo dentro al petto. L'angoscia mi afferra all'improvviso.
Nulla traspare, però. Mi siedo al posto indicatomi con non-chalance. Va tutto bene, a meraviglia. Giulia è accanto a me e mi sorride. Ricambio il suo sorriso. Benché percepisca i musco-li facciali come affetti da paralisi, decido di lasciare quel sorri-so stampato sul mio viso come se si trattasse di un ritratto e lo regalo subito all'altra mia vicina, Claudia, la moglie di Paolo.
Tutti hanno ripreso a conversare amabilmente, le loro voci mi rimbombano nel cervello, non seguo nessun discorso, non ci provo nemmeno, non mi interessa. Continuo a sorridere a tutti, è sufficiente per rassicurarli, nessuno bada più a me.
Poi, improvvisamente, il silenzio cala sulla tavola mentre assaggiamo i coni di bresaola al salmone che la padrona di casa ci ha appena servito. E in quel silenzio inatteso, Claudia for-mula una domanda che odono tutti e che mi pone irrimedia-bilmente al centro dell'attenzione e dell'interesse generale.
“Allora sei di Catania, Lorenzo?”
Vorrei scomparire come per incanto e invece mi costringo a risponderle senza abbandonare il sorriso.
“Già, proprio così” mi limito a dire.
“Però non hai l'accento siciliano” commenta Alice.
Il mio sorriso si accentua, mi difendo così da quella che io recepisco come un'aggressione virtuale.
“Hai ragione. I miei genitori erano toscani, di Lucca. Mio padre era maresciallo dei carabinieri. Sono cresciuto in giro per l'Italia e, quando avevo quattordici anni, ci siamo trasferiti a Catania. E' stata la mia città di adozione, ci ho vissuto per molti anni.”
“Hai detto che tuo padre era maresciallo. Perché? E'...”
Decido di togliere dall'imbarazzo Elsa che siede di fronte a me. Siamo separati da un bel vaso colmo di fiori freschi che però non ci impedisce di guardarci in faccia.
“Sì, è morto. Diversi anni fa. Mia madre non si è mai ripre-sa da quel colpo e, qualche anno dopo, l'ha seguito, purtrop-po.”
Le mie parole provocano un silenzio imbarazzato. Alice ne approfitta per servire il primo: fusilli alla crema di asparagi. Claudia mi porge il vassoio e io spero che la curiosità nei miei confronti si sia esaurita. Non è così, purtroppo. E' cresciuta nel tempo, è stata repressa troppo a lungo e adesso trova il suo sfogo. Non posso impedirlo. E' la prima volta che mi fanno così tante domande. Ma, si sa, la cosa più difficile è incomin-ciare.
“E come mai hai deciso di venire a Milano?” indaga anco-ra Fausto.
“Tre anni fa l'azienda in cui lavoro, ha operato dei tagli al personale. Mi hanno offerto di trasferirmi a Milano. Se non avessi accettato, mi avrebbero licenziato.”
Naturalmente è solo una pietosa bugia, ma mi accorgo in questo istante di quanto sia facile mentire. Il problema è tenere in piedi le proprie menzogne senza cadere in contraddizione. Mi riprometto di dire il meno possibile.
“Cosa c'è? Non hai fame stasera?” mi chiede Alice ritiran-do il piatto, vuoto solo a metà.
“Scusami Alice. E' tutto molto buono, ma lo sai che man-gio sempre poco e stasera non mi sento molto bene.”
Mi sorride comprensiva e continua il suo giro con efficien-te rapidità.
Per evitare nuove domande decido di formularne una anch'io. Mi difendo attaccando.
“Voi siete tutti milanesi purosangue, invece?”
“Ah, no davvero. I miei nonni paterni erano liguri” dice Fausto suscitando ironie e frecciatine. Tutti si lanciano nella discussione contemporaneamente. Con sollievo mi accorgo di essere riuscito a distogliere l'attenzione nei miei confronti. Torno a rilassarmi.
A forza di sorridere, mi sembra di sentirmi meglio. Assag-gio appena il coniglio ai würstel e il cavolfiore gratinato che gli altri divorano come se fossero reduci dal Biafra. Mi sorprende ogni volta la quantità di cibo che la gente riesce ad ingurgitare durante una cena in compagnia. Io, però, non ho fame. Sono anni che non ho fame. Grazie alla mia inappetenza, a trenta-cinque anni sono magro e in forma come un diciottenne.
Non ho fame ma ho sete, ho già bevuto due bicchieri di vino rosso e adesso sto trangugiando il terzo. Giulia mi scruta sorpresa.
“Non stai esagerando?” mi sussurra, perplessa.
Mi blocco come un ladro sorpreso in flagrante. Poso sulla tovaglia elegantemente ricamata il bicchiere di cristallo, pieno a metà. Annuisco evitando di ricambiare il suo sguardo. La te-sta mi gira un po', è vero, però mi sento meno infelice del soli-to. Forse l'alcool è una buona medicina per i miei mali. Mi so-no ubriacato per la prima volta a quindici anni, in una fredda sera d'inverno in cui, dopo aver ottenuto un riluttante consen-so paterno, sono andato in discoteca con amici e compagni di classe. Poi sono stato così male che ho promesso a mio padre e a me stesso che non lo avrei fatto mai più. Inutile dire che non ho mantenuto quella promessa. Mio padre, però, era già morto quando, a trent'anni, mi sono scolato un'intera bottiglia di whisky e, per fortuna, non lo saprà mai.
Sbircio l'orologio, sono le dieci e trenta, la cena volge al termine. Non vedo l'ora di tornare a casa come se ciò bastasse a risolvere i miei problemi, come se potessi abbandonare il mio tormento nel luogo che lascio e non fossi costretto invece a trascinarmelo dietro, come una lumaca fa con la sua casa. Co-nosco un solo modo per liberarmene davvero.
La padrona di casa si alza. Fausto ha già stappato lo spu-mante e lo ha distribuito a tutti. Alice solleva il suo calice, sembra che voglia fare un brindisi. Cosa festeggiamo?
“Io vorrei approfittare dell'occasione per dirvi una cosa che ci sta molto a cuore e che ci rende felici. Noi vorremmo condividere la nostra gioia con voi. Insomma... aspetto un bambino” dice Alice con un dolce sorriso imbarazzato. E' già rapita come tutte le donne che hanno appena scoperto di esse-re incinte. Fausto la stringe a sé. Sembrano davvero felici. Quanto durerà? Mi scopro comunque ad invidiarli. Vorrei po-ter tornare indietro. Anch'io sono stato felice un tempo, come loro. Annego nel rimpianto.
“Sono incinta” dice semplicemente Luisa. Io la fisso traso-gnato come se non riuscissi a crederle.
“Ma sei sicura? Ne sei proprio sicura?” le chiedo cercan-do di contenere la gioia. Ci proviamo da mesi, eppure adesso che è una cosa reale, mi sembra impossibile che siamo stati davvero capaci di concepire un figlio.
“Sicurissima” replica lei con la stessa aria estatica che ha lo sguardo dei santi sulle immaginette.
Incapaci di contenere oltre le emozioni, ci abbracciamo come se il mondo ci avesse spalancato tutte le sue porte e nes-suno potesse mai più richiudercele contro. La felicità eterna, l'amore eterno! Follia!
Eppure la felicità può fare paura, a volte. Non possiamo permetterle di essere così pura, così perfetta. Ci terrorizza il confronto con la gretta normalità e il timore di perderla rovina quell'attimo fuggente prima ancora che ce ne rendiamo conto.
Ci guardiamo in viso. Un'ombra ricopre i nostri volti e fa tremare i nostri cuori.
“Riusciremo ad essere dei buoni genitori?” ci chiediamo l'un l'altro senza parlare.
Esistono buoni genitori? Una volta ho letto un articolo su una rivista che sosteneva che nessuno al mondo riesce a farci del male quanto i nostri genitori, in un modo o nell'altro. Sarà vero? Non sono certo in grado di confutare una simile tesi, ma mi chiedo se non stia cercando stupidamente conforto nelle statistiche.
“Ehi, e tu, non ci fai gli auguri?” mi chiede Fausto strap-pandomi alle mie meditazioni. Tutti i presenti si sono congra-tulati, hanno abbracciato e baciato la futura mamma, hanno espresso il loro entusiasmo come se fossero davvero coinvolti nella faccenda, mentre io sono rimasto immobile, inconsapevo-le, lo sguardo funereo, ad inseguire i ricordi. Mi sforzo di ri-prendere a sorridere, grazie al vino che ho bevuto ci riesco con facilità. Mi sento su di giri, sono un po' brillo, mi scappa una battuta infelice.
“Ma certo che vi faccio gli auguri, sono contento che siate così felici. Vi auguro di esserlo ancora un paio di mesi dopo il lieto evento.”
Continuano a sorridere, ma mi accorgo che ci sono rimasti male. Giulia mi lancia un'occhiataccia.
“Che vuoi dire?” mi chiede Elsa nel silenzio che segue alle mie parole.
“Niente. Era solo una battuta. Scherzavo” biascico imba-razzato.
“Ma tu, cosa ne sai? Hai figli, tu?” replica ancora Elsa, in-capace di trattenere un pizzico di risentimento come se fosse lei la diretta interessata.
Non riesco a sostenere lo sguardo dei presenti. Ho smesso di sorridere. Preferirei sprofondare negli inferi piuttosto che rispondere a quella domanda. Invoco un provvidenziale mal di testa. Mi rivolgo a Giulia.
“Ti dispiace se andiamo a casa adesso?” le chiedo sapendo che la risposta non può essere che un sì.
“Ma certo” mi risponde cordiale, ma la conosco bene ormai e il suo sguardo non promette niente di buono.
“Ci dispiace che andiate via così presto” ci dicono i padro-ni di casa accompagnandoci alla porta. Scendiamo in silenzio le scale ma in strada, ancor prima di arrivare alla macchina, Giulia si scatena furibonda.
“Si può sapere che cavolo ti prende? Cosa ti è saltato in mente di uscirtene con una scemenza simile? E poi perché mi hai costretta ad andare via così presto? La serata era appena incominciata.”
“Sono le undici passate e non ti ho costretta. Ho solo detto che ho mal di testa e che volevo tornare a casa.”
“E cosa volevi fare per costringermi, trascinarmi con la forza? Cosa avrei potuto fare, secondo te? Dirti: vai pure caro, tornatene a casa. Ti raggiungerò quando avrò finito di fare i miei comodi!”
“Perché non la smetti di urlare? Siamo in mezzo alla strada e ho davvero mal di testa.”
“Certo che hai mal di testa. Non hai fatto altro che bere. Sei ubriaco. Ecco perché hai mal di testa.”
“Ho bevuto solo due bicchieri di vino. Non sono ubriaco.”
“Hai bevuto due bicchieri e mezzo di vino e uno di spu-mante. Sono più che sufficienti per farti ubriacare.”
“Ma cosa sei, mia madre? Mi controlli? Tieni la contabilità di quello che bevo? Lasciami in pace” esclamo ormai infuriato quanto lei. Sono così agitato che non mi accorgo nemmeno di quanto l'aria sia gelida. Una nebbia fittissima avvolge ogni co-sa e non riesco ad individuare la mia automobile. Ho perso di vista anche Giulia.
“La macchina è qui. Guido io, però” dice distintamente, a distanza di pochi passi.
La raggiungo mentre sta già aprendo lo sportello corri-spondente al posto di guida. Glielo strappo dalle mani.
“Ti ho già detto che non sono ubriaco. Piantala di rompe-re.”
E' ancora furiosa ma ubbidisce. Il ticchettio dei suoi tacchi alti sull'asfalto bagnato mi dà ai nervi. Una vena sulla fronte mi pulsa senza sosta. Mi siedo in macchina e metto in moto. Mi sforzo di calmarmi, non ci riesco. Per un attimo rimango immobile, incerto sul da farsi. Ha ripreso a piovere, non vedo nulla, cerco la leva del tergicristalli, il pulsante per accendere i fari antinebbia, quello per far funzionare il lunotto termico, tutto come se lo facessi per la prima volta. Sento che i miei ri-flessi sono appannati, forse dovrei davvero lasciare guidare Giulia. Sono sul punto di dirglielo quando, inopportunamente, lei riapre bocca riaccendendo la mia collera.
“Ti hanno mai detto che sei un bell'egoista? Ti diverti a rovinarmi tutte le serate. Ma poi non riesco proprio a capire, ma cosa ne sai tu di bambini, di neonati, di come ...”
Parto a razzo senza lasciarle il tempo di allacciare la cintura di sicurezza.
“Ehi, vuoi ammazzarmi? Datti una calmata, voglio arrivare a casa viva” protesta Giulia, gemendo.
Non parlo, non rispondo, non le do retta. Continuo a rin-correre il nulla che ci circonda, come se bastasse non vedere per sopprimere la realtà. Ciò che non si vede non esiste.
“Lorenzo, rallenta, ti prego...”
L'ansia che percepisco nella sua voce mi induce a ritornare in me, del resto non riconosco più le vie immerse nella nebbia, non so dove sto andando. Rallento e tento di trovare un indi-zio, un punto di riferimento che mi aiuti ad orientarmi giacché tutte le vie mi appaiono identiche.
Ed è proprio mentre sto tentando di leggere l'insegna di un bar che avviene l'impatto: un rumore secco e metallico che mi fa accapponare la pelle.
Freno bruscamente. L'auto si arresta qualche metro più avanti. Non so cosa sia successo, mi è sembrato di vedere un ciclomotore, ma non ne sono sicuro. Non so da dove sia sbuca-to fuori, così all'improvviso. Abbasso il finestrino e tento di scrutare nella nebbia. Non vedo assolutamente nulla. Il panico mi travolge quando Giulia apre la portiera. Non le permetto di scendere perché riparto sgommando. Non voglio vedere, non voglio sapere, non posso fermarmi.
La voce stridula e sconvolta di Giulia mi giunge da una di-stanza siderale. Non voglio sentire, non voglio capire, non pos-so fermarmi.
“Ma sei impazzito? Cosa stai facendo? Abbiamo investito qualcuno. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo prestargli soccorso. Potrebbe essere ferito. Forse sta morendo. Cazzo, vuoi fermarti?”
Sento le mani di Giulia che mi strattonano il braccio ma io continuo a guidare alla cieca, allontanandomi sempre di più, come impazzito. Anche volendo, adesso non saprei tornare in-dietro. D'un tratto freno e accosto la macchina al marciapiede. Appoggio le braccia al volante e la testa sulle braccia. Un forte tremito mi scuote tutto.
“Che cosa hai fatto? Come hai potuto?”
La voce di Giulia mi trafigge, confondendosi con altre vo-ci provenienti da un passato che avevo intensamente sperato di essermi lasciato alle spalle. Per sempre.
Come spiegare ciò che è accaduto pochi minuti fa? Come spiegare ciò che accadde quattro anni fa, come trovare scuse o giustificazioni a qualcosa che non può essere spiegato, né scu-sato, né giustificato, né ancor meno compreso?
Non si può.
E' per questo che mi sono chiuso in me stesso, è per questo che ho interrotto i contatti. Giulia è riuscita a riportarmi a casa non so come, ha lasciato che mi sdraiassi sul letto e poi, ancora sconvolta, ha cominciato ad aggredirmi verbalmente con le sue assillanti e, a tratti, isteriche domande a raffica alle quali non so o non voglio rispondere. Ha tentato persino di telefona-re per chiamare i soccorsi ma poi ha desistito poiché non sap-piamo dove è avvenuto l'incidente. Non sa cosa fare, ma non riesce a rassegnarsi a non fare niente.
Io sto immobile sul letto, non muovo un muscolo come quando, da bambino, giocavo a un due tre stella. Stavolta però non faccio nessuno sforzo per restare fermo. Tengo gli occhi chiusi, non vedo l'andirivieni agitato di Giulia, posso solo im-maginarlo come immagino il suo sguardo furente e allucinato. A lei appaio indifferente, non può certo immaginare il trava-glio che mi devasta l'anima.
“Ma che razza di uomo sei?” chiede con voce stridula. Poi odo la porta della camera da letto che sbatte e finalmente giunge il pietoso, carezzevole, confortante silenzio.
E nel silenzio lascio che le lacrime scorrano e mi bagnino il viso.
Piango per il presente e per il passato, credo anche per il futuro.
Già, che razza di uomo sono?
Il passato ritorna, ritorna sempre.
IERI
Mio padre se ne andò all'improvviso una calda mattina di agosto con lo stesso garbo con cui era vissuto. Avevo venti-cinque anni, mi ero appena laureato in fisica e, nonostante il dolore per la perdita di un uomo che mi era stato vicino in ogni momento della mia giovane esistenza, in quei tristi giorni non riuscivo a fare a meno di pensare che era stata una gran fortu-na per me che non fosse morto prima, consentendomi così di completare quegli studi a cui tenevo tanto e che invece sarei stato costretto ad interrompere nel caso contrario.
Oggi, a distanza di dieci anni, non sono più così sicuro che sia stata una fortuna. Ma col senno di poi, è facile giudicare.
Non avevamo parenti a Catania ed io ero figlio unico per cui furono soltanto gli amici a confortare mia madre e me. Gli amici e Luisa, la mia ragazza da sempre.
Uscivamo insieme da quasi sette anni, dall'ultimo anno del liceo. Seduto al tavolo del soggiorno, con la sua mano stretta fra le mie, ancora scosso per il recente lutto, pensai che era passata un'eternità dal giorno in cui ero riuscito a superare le sue resistenze, le sue incertezze e titubanze e l'avevo convinta che ero proprio io l'uomo della sua vita. Un'eternità che non mi aveva impedito di continuare ad amarla come il primo gior-no, anche se forse era subentrato da un po' un pizzico di as-suefazione e di monotonia.
Ero un tipo simpatico e sicuro di sé, viziato (anche se allora non lo sapevo ancora) da due genitori che mi avevano ricevuto come un dono del Signore in età avanzata e che perciò erano stati un po' incerti se comportarsi con me con la severità di ge-nitori o con la dolcezza di nonni. Alla fine la dolcezza era pre-valsa ed io ero cresciuto convinto di poter ottenere tutto ciò che desideravo.
Appassionato di fisica, mi ero dedicato agli studi, come poi mi sarei dedicato al lavoro che avrei trovato di lì a poco, con un fervore inusuale nei giovani della mia età, fervore che mi dava un piglio da leader, una capacità di concentrazione e di astrazione dalla realtà che, talvolta, faceva uscire fuori dai gangheri Luisa e anche i numerosi amici (molti dei quali com-pagni di liceo) che mi stavano attorno.
Nel silenzio mesto di quel soggiorno, guardai mia madre e mi chiesi come sarebbe riuscita a sopravvivere alla morte del suo compagno di una vita. Non che il loro rapporto fosse stato esente da imperfezioni, ma possedeva quella solidità che solo i matrimoni di una volta sembrano ormai avere, la convinzione che qualunque difficoltà sarebbe stata affrontata e superata in-sieme e che niente avrebbe potuto rimettere in discussione quella sacra promessa, fatta di fronte a Dio tanto tempo prima.
Mia madre era malata di cuore già da alcuni anni e nessuno di noi avrebbe mai immaginato che sarebbe stata lei a seppelli-re il marito e non il contrario. Io la guardavo e soffrivo per lei pur non sapendo allora che un giorno sarei stato proprio io a darle quel colpo di grazia che le avrebbe permesso di ricon-giungersi a mio padre. Ma chissà, forse il nostro cuore sa già fin dal principio quello che la nostra mente non sa ed è meglio che non sappia, soprattutto se il solo sapere non è sufficiente a cambiare il corso degli eventi.
Di certo, nessuno avrebbe potuto presumere che forse mio padre era stato il più fortunato fra noi, né avrebbe potuto comprendere quale assurdo dolore gli sarebbe stato risparmiato dalla sua inattesa e prematura scomparsa.
Nonostante il tasso di disoccupazione avesse raggiunto nell'isola livelli incredibilmente vicini a quelli dei paesi del ter-zo mondo, io trovai un buon lavoro pochi mesi dopo la morte di mio padre. Non sono in molti a laurearsi in fisica applicata e soprattutto non sono in molti ad essere bravi, seri, versatili e capaci di grande abnegazione come fui giudicato io dai miei datori di lavoro milanesi che avevano da poco aperto una nuo-va sede della loro azienda nella mia città. Fu quello il secondo colpo di fortuna che mi capitò in quel periodo, il secondo che, a posteriori, non mi sarebbe sembrato più tale. E' davvero sin-golare come cambiando prospettiva, tempo o luogo, tutto pos-sa apparire straordinariamente diverso, perfino antitetico.
Ne seguì quell'ovvia sequenza di azioni che compiono la maggior parte degli esseri umani. Sposarci dopo otto anni di fidanzamento fu un atto talmente logico e naturale che pren-dere una tale decisione non causò di certo a Luisa, né a me, notti insonni o repentini ripensamenti. Neanche per un momen-to si affacciò nella mia mente il sospetto che il passo che sta-vamo per compiere potesse rivelarsi un crudele, smisurato ab-baglio.
Io amavo Luisa, di questo ero certo. Il problema era che non capivo cosa volesse dire amare davvero. Credevo che fos-se sufficiente sentirmi eccitato ogni volta che intravedevo la sua figura, ogni volta che fissavo i suoi occhi luminosi, ogni volta che la sua voce calda e appassionata mi accarezzava l'anima. Credevo che bastasse pensare a lei quando la mia mente era sgombra da formule e ipotesi progettuali, sentire il bisogno di rivederla quando ne avevo abbastanza di scervel-larmi su problemi apparentemente insolubili, fantasticare in-sieme a lei sul nostro futuro ideale. Per il resto, davo per scon-tato che lei sapesse che l'amavo, che non avesse bisogno di sentirsi ripetere in continuazione quanto fossi pazzo di lei, che non fosse necessario dedicarle mille riguardi e continue premu-re, che fosse consapevole di doversi accontentare dei ritagli di tempo che ero in grado di offrirle.
Mi dedicavo infatti anima e corpo al mio lavoro che si rive-lò ben presto il suo più vero e temibile rivale. La fase di pro-gettazione soprattutto mi appassionava a tal punto che spesso mi attardavo al lavoro più del dovuto o rimanevo assorto e svagato per intere serate, dimenticando i miei doveri di marito come poi avrei dimenticato con mio figlio quelli di padre.
Inizialmente Luisa si sforzò di sopportare, ma la pazienza non era inclusa fra le sue maggiori qualità e quando esplosero le prime scenate, io ne fui sinceramente sorpreso, oltre che ad-dolorato. Mi rifiutavo di comprendere che amare significa prendersi cura della persona amata, avere verso di lei quelle piccole, a volte banali attenzioni che ti scaldano il cuore, che servono a dare un senso alla nostra scialba e, per molti aspetti, insignificante esistenza.
Quando Luisa smise di fare scenate, io ne fui talmente sol-levato che non mi posi domande, né mi accorsi che anche lei si era ritagliata, in qualche modo, un suo mondo che l'appagava e che mi escludeva, come lei era esclusa dal mio. Questo però sarebbe avvenuto diversi mesi dopo la nascita di Mauro quan-do il mio egoismo era già riuscito a contaminare anche lei.
Salvina Alba
|
