|
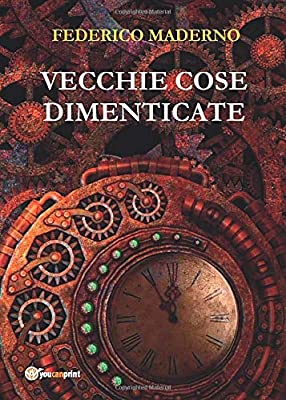  Il vento e il caruggio.
Il vento e il caruggio.
Lo incontrai, la prima volta, una sera di dicembre del 2009. C'era un tempo inclemente, per le vie di Genova. Il vento s'incanalava per le strade strette del centro storico e se lo prendevi da davanti, carico del gelo che tirava giù dalle colline dietro la città, t'impediva quasi di respirare.
In mezzo alle folate, quando si transitava sotto i lampioni dondolanti dell'illuminazione pubblica, s'indovinava un pulviscolo pallido, che era più ghiaccio che neve.
In quelle condizioni, al limite del sopportabile, non c'era, per le strade e i caruggi di Genova, un so-lo temerario che avesse avuto voglia di lasciare il caldo comodo degli appartamenti, e sebbene non fossero ancora le ore ventidue, c'era da credere che la gente fosse già andata a letto, tanto silenziosi erano gli appartamenti dei mezzanini, dai quali, in altre condizioni, sarebbe giunto il vociare di bambini e di televisioni.
Quando arrivai alla metà di vico Indoratori, vidi l'uomo svoltare da Via di Scurreria e venirmi incontro, tenendosi accostato alle facciate dei palazzi in cerca di riparo. Eravamo, probabilmente, le uniche due persone che si erano azzardate ad affrontare la serata invernale: io, per consegnare dei documenti, lui, non avrei ancora saputo dire per quale motivo.
Avanzava a testa bassa, sballottato dalle folate di vento. Con una mano si teneva, schiacciato sul capo, il cappello scuro di panno, con l'altra cercava di mantenere riunite, all'altezza del petto, le falde del cappotto che sembravano impazzite.
In quel momento, la corrente d'aria si era fatta tanto violenta che pareva voler strappare gli infissi delle finestre sbarrate. Vidi l'andito di un negozio. Le serrande, arretrate rispetto al ciglio del vicolo, formavano una rientranza di pochi metri quadrati, e lì mi infilai al riparo, per cercare di riprender fiato.
L'uomo arrivò all'altezza del mio rifugio dopo qualche secondo. Doveva aver adocchiato anche lui quell'incavo protetto e ci si gettò di colpo, ancora ingobbito e impacciato nei movimenti, tanto che non mi fu possibile scansarmi e mi urtò con il gomito.
Alzò immediatamente la testa e io intravidi, nella semioscurità, uno sguardo spaventato o sorpreso. Quando si rese conto che ero anch'io un reduce della burrasca, abbozzò un sorriso di scusa.
– Ah, abbia pazienza... Con questo tempaccio non si riesce quasi a camminare.
Indicai il vicolo spazzato dal maltempo:
– Con un tempo così, bisognerebbe non aver bisogno di allontanarsi da casa.
– Si fa un po' quello che si può. Io fino alle venti ero convinto di non dover uscire, ma le notizie quando arrivano, arrivano.
Dovevamo quasi gridare, per sostenere quel poco di conversazione e guardarci in viso, per aiutarci con la lettura del labiale.
S'intese, tra gli ululati arrabbiati della bufera, un colpo secco, come se il vento fosse riuscito a scardinare l'anta di una persiana o avesse strappato una delle insegne dei negozi del vicolo. Magari, l'infisso era sbattuto solo violentemente contro un muro, ma ugualmente ci venne d'istinto guardare in alto, lungo la fila di finestre dei piani bassi.
– C'è da prendersi qualcosa sulla testa – urlò il mio estemporaneo compagno d'avventura scrutando verso l'alto.
– E c'è il rischio che nessuno se ne accorga prima di domani mattina. Almeno si calmasse un po' questa tempesta...
Stavamo lì, stretti nei nostri cappotti pesanti eppure inadeguati, affacciati sul filo della facciata a ri-mirare cosa riusciva a fare la tramontana impegnandosi al massimo, e adesso che eravamo sistemati in quella nicchia di calma rara ed invidiabile, pareva irragionevole dover abbandonarla e ricacciarsi nel turbine della burrasca. Sarebbe stata necessaria molta forza di volontà, ma era troppo piacevole avere nuovamente la percezione della propria pelle, sul viso e sulle mani.
A pochi metri dalla nostra postazione, sul lato opposto della via, c'era un bar aperto. L'insegna era priva di illuminazione, ma dalla porta d'ingresso e dalla seconda vetrina che aveva le serrande alzate, filtrava una luce rosata che le intemperie sembrava-no voler portare via insieme alle cartacce di strada.
– Non sarebbe male prendere qualcosa di caldo... – gridai, accennando con una mano al caffè.
– Perché no? – acconsentì immediatamente l'uomo, e con un cenno d'intesa si avviò verso il locale, mantenendo un'andatura caracollante che poteva essere causata dalle raffiche sgarbate del vento.
Eppure, il mio compagno di avventura doveva avere una qualche difficoltà di deambulazione, per-ché anche quando fummo all'interno, lo vidi zoppi-care leggermente.
Il bar era assolutamente deserto. Il gestore se ne stava appoggiato ad un'estremità del bancone a guardare un televisore appeso, con una staffa, in al-to, sul muro. Teneva il volume regolato tanto basso che non si poteva capire come potesse ascoltare il commento della partita di calcio che stavano tra-smettendo.
Passare dallo scempio atmosferico del vicolo alla calma quasi innaturale del locale, ci diede l'impressione di entrare in un bunker, durante un bombardamento.
C'era un tavolo massiccio, a destra dell'entrata. Si rimaneva proprio a ridosso della vetrina e, in altra situazione, l'avrei considerato imbarazzante, ma quella sera la figura da manichino nella tormenta l'avrebbe fatta chi si fosse avventurato nel vicolo.
Gettammo i cappotti su una panca e ci sedemmo uno di fronte all'altro, un po' impacciati per il fatto che eravamo, in ogni caso, estranei.
Il barista parve stupito. Si staccò dalla sua postazione con una velata indolenza e si avvicinò al nostro tavolo.
– Sì? – disse semplicemente, esibendo, certo per abitudine, un piccolo notes bisunto.
Ci guardavamo la prima volta sotto una luce ab-bastanza forte da rivelare i connotati dei visi. Avevo giudicato quell'uomo più attempato di quanto fosse in realtà. Mi avevano ingannato l'abbigliamento sformato e la postura ingobbita per il disagio del maltempo. Senza gli abiti pesanti e tolto dalla testa il cappellaccio di panno, dimostrava non più di sessanta anni ed emanava un'energia controllata, che si concentrava negli occhi scurissimi e nello sguardo acuto, quasi imbarazzante.
– Mi chiamo Sòlmon – disse di getto. – Il nome mi permetta di ometterlo. Lo ha scelto mio padre, che era di origini romagnole, e dunque è di quelli che non si ama mettere in mostra.
Il timbro della voce era piacevolmente musicale e ricco di armoniche.
Ci stringemmo la mano attraverso il piano del tavolo. La sua era certamente più calda della mia e la stretta aveva qualcosa di molto virile, senza essere fastidiosa.
Il barista era rimasto in attesa, a rimirare i due estranei che erano venuti a fare le presentazioni nel suo locale, in una notte che avrebbe consigliato, alle persone per bene, di rimanersene chiuse in casa.
– Allora, i Signori hanno le idee chiare o vogliono pensarci su a loro comodo?
Forte cadenza dialettale, il tipico commerciante genovese che cerca di guadagnare ma non insegue i clienti.
Ci scambiammo un'occhiata di complicità.
– Credo che due caffè bollenti possano andare bene – disse il signor Solmon.
– Per me, lunghissimo – aggiunsi.
Il gestore si ritenne soddisfatto, girò sui tacchi e si allontanò, fischiettando debolmente.
A guardarlo da lì dentro, il mezzo tornado che schiaffeggiava Genova non faceva nemmeno più tanta impressione. Si sentivano ancora i sibili arrabbiati del vento che scrollava le serrande e faceva oscillare il cono di luce del lampione nel vicolo, qua-si sopra la porta di ingresso, ma le vetrine erano be-ne insonorizzate e dunque sembrava di osservare il mondo dallo schermo di un televisore.
Restammo in silenzio a lungo.
– È una serata strana – dichiarò Solmon sottovoce, quasi stesse ragionando con se stesso.
– Qualche volta la tramontana è feroce – ammisi.
Mi rivolse un sorriso di scusa:
– No. Mi riferivo, piuttosto, alle vicende che possono indurre ad uscire in queste condizioni.
– Spero non siano, per lei, questioni di salute.
– Ah, questo no, per fortuna. Ma anche lei ha optato per una serata senza pantofole.
Era stato un fascicolo di documenti a tirarmi fuori di casa. Dovevo consegnarlo ad un collega, avevo rimandato fino all'ultimo, confidando nella clemenza della stagione, e la stagione mi aveva tradito, ri-servandomi, per l'ultima serata utile, il peggio che era riuscita a confezionare.
– Io ho commesso un errore logistico – dissi. – E me la sono andata a cercare. Niente di tragico. Avessi chiuso per tempo il mio lavoro, adesso sarei davvero in pantofole.
– Tendiamo tutti a procrastinare. È l'anelito all'immortalità, forse.
– E lei invece? Quale forza sovrumana l'ha tirata fuori della sua tana?
Non avevo ancora ultimato la domanda e già mi ero pentito per la palese indiscrezione.
Solmon dovette accorgersene dall'inflessione delle mie ultime parole e mi fece un cenno di cortesia, con la mano.
– Ah, non si preoccupi. Non c'è niente di particolarmente riservato. Anzi, a dirla tutta, non c'è niente del tutto. Nel senso che mi hanno fatto correre a vuoto. Pazienza, non si può sempre avere successo.
Restammo ancora in silenzio, ad ascoltare il ciangottio delle tazzine sotto il beccuccio della macchina per l'espresso e poi dentro il vassoio, fino a quando il barista le posò sul nostro tavolo.
Il caffè era buono, e più piacevole era degustarlo di fronte all'inquadratura polare di Vico Indoratori.
– Lei ha mai fatto il caffè con una di quelle vecchie caffettiere da capovolgere? – mi chiese Solmon improvvisamente, mentre faceva ruotare la tazzina dove qualche traccia di bevanda si stava raccogliendo sul fondo di smalto concavo.
– Le napoletane?
– Bravo, proprio le napoletane.
– Ricordo di aver visto qualcosa di simile, in casa di mia nonna.
– Ah, certamente. Le generazioni che le usavano erano quelle. Ha idea di come venissero costruite le piccole napoletane?
– Nemmeno una vaga idea. Ma non si usano più, in ogni caso. Si occupa di caffettiere?
– Assolutamente no. Anzi, potrebbe anche capi-tare. In ogni caso, non per lavoro.
Lo guardai, socchiudendo leggermente gli occhi. Avevo la certezza di non trovarmi davanti ad un rappresentante di articoli per la casa.
– È sempre così criptico? – azzardai, con falso disinteresse.
– Non ho niente da nascondere, se è a questo che pensa. Il fatto è che quando parlo di occupazione, non mi riferisco ad un lavoro, ossia a qualcosa che mi consenta di guadagnare per vivere.
– Allora, si riferisce ad un passatempo?
– Oh, i passatempi poi! Stiamo su questa Terra così pochi anni e ci preoccupiamo di fare passare il tempo. Mai nessuno che cerchi un fermatempo, al limite un rallentatempo.
– Però, – obiettai – io devo ancora capire qual è il suo vero interesse.
– Ecco: il mio interesse, ha detto bene. Io mi oc-cupo di ciò che alla gente non interessa più.
Federico Maderno
|
