
 A dodici anni avevo tre brufoli e una certezza: mio padre sarebbe rimasto per sempre con me. A quattordici i brufoli erano spariti e mio padre con loro. A dodici anni avevo tre brufoli e una certezza: mio padre sarebbe rimasto per sempre con me. A quattordici i brufoli erano spariti e mio padre con loro.
Dicono che le giornate che cambiano la vita hanno un sapo-re particolare. Ti svegli e sai che quel giorno non lo di-menticherai mai, nel bene o nel male. Balle! Se c'è una cosa che ho imparato è che spesso, nella vita, la cornice non c'entra niente con il contesto. Quando la tua esisten-za sta per collassare, il mondo intorno a te non mostra nessun segnale, nessun avvertimento.
Quel 12 maggio il sole splendeva timido nel cielo. Ero sceso in cucina. Avevo preparato lo skate per andare a scuola, lo zaino era all'ingresso, nell'aria il profumo delle uova mi solleticava narici e stomaco. Mi sentivo fe-lice. Papà riposava sereno nel letto al piano di sopra. Nell'ultimo periodo le sue condizioni di salute erano mi-gliorate. I respiri si erano fatti più lenti e profondi, la voce meno roca e riusciva a stare alzato per due ore di fila. In quel lasso di tempo sedeva insieme a me sul diva-no e guardavamo le partite alla TV. Il gol della mia squa-dra del cuore era accompagnato da un abbraccio che mi sol-leticava la gola dall'emozione. Sembrava tutto così norma-le, forse troppo. Quando la paura si affacciava alla porta del mio stomaco, facevo un respiro profondo e contavo fino a dieci. Non lo dicevo a nessuno. Mamma era troppo impe-gnata a fare da infermiera a papà e poi era sempre così silenziosa, triste. Dal giorno in cui era iniziata la ma-lattia, lei era diventata un'anima spenta che percorreva le stanze della casa, cercando di fare meno rumore possi-bile, come se ogni piccolo suono avrebbe potuto provocare l'irreparabile. Perché l'irreparabile, il ″The End″ come lo chiamava la mia amica Melodie, noi lo avevamo toccato da vicino.
Papà era un famoso biologo che girava il mondo alla ricer-ca di virus e batteri sconosciuti. Da quando il riscalda-mento globale aveva alterato i naturali ritmi terrestri, il mondo invisibile dei germi aveva iniziato a prosperare indisturbato. Lui diceva sempre che per combattere il ne-mico devi conoscerlo. Nome, cognome e modi di fare. I nuo-vi virus erano più letali perché non sapevamo nulla di lo-ro. Arrivavano all'improvviso e facevano ammalare tutti, uomini, donne, bambini. Con il suo lavoro mio padre cerca-va di alleviare le sofferenze delle persone. Collaborava con un'equipe medica e spesso stava via per mesi interi. In quell'ultimo anno era stato molte volte nella foresta amazzonica. Una malattia sconosciuta stava mietendo vitti-me su vittime. Non si sapeva nulla, non si riusciva a ca-pire da dove provenisse il contagio. Sentivo i colleghi di papà parlare di pipistrelli, boa constrictor, falde acqui-fere e laboratori sospetti. Io non ci capivo molto ma am-miravo il suo lavoro e volevo diventare come lui, un bravo scienziato.
Dall'ultimo viaggio era tornato pallido e dimagrito. La febbre tormentava le sue notti, i colpi di tosse lo la-sciavano senza fiato. Non mangiava e dormiva raramente. In quel periodo io e mia madre abbiamo fatto la spola mille volte dall'ospedale, su e giù per quei tristi corridoi al-la ricerca di un appiglio, un aiuto. I medici non avevano dato nessuna speranza. La malattia era sconosciuta e non esisteva la cura. Bisognava soltanto alleviare i suoi do-lori con la morfina e attendere il giorno X.
La nostra disperazione durò fino al giorno in cui un gio-vane medico con il camice storto e gli occhiali calati sul naso fece la sua comparsa in reparto. Richard mi colpì su-bito per l'aria stralunata ma intelligente. Parlava ore e ore con mia madre, scriveva appunti su qualsiasi pezzo di foglio, misurava la febbre a papà, controllava le analisi. Dopo una decina di giorni disse a mia mamma che si poteva tentare una cura sperimentale, con un nuovo tipo di anti-biotico. La sostanza contenuta era il sintetrax, una mole-cola che ancora non era stata testata sull'uomo ma che aveva dato ottimi risultati in laboratorio. I suoi colle-ghi erano scettici ma mamma si fidò di quel medico e diede il suo consenso. Papà iniziò lentamente a migliorare. Dopo qualche tempo lo portammo a casa perché non aveva più bi-sogno delle cure ospedaliere. Richard era diventato il mio eroe, dopo mio padre si intende. La vita sembrava prendere di nuovo la direzione giusta. Avevo tutto sotto controllo, o quasi.
Quel 12 maggio non lo dimenticherò mai. Il rumore che de-cretò la fine della vita che conoscevo e amavo così tanto fu un tonfo sordo. Mia madre alzò gli occhi come per guar-dare il lampadario e poi corse via, mangiando le scale a due a due. Dopo ho soltanto un ricordo confuso. Il suo ur-lo, Richard che arriva di corsa, la sirena dell'ambulanza e poi il nulla, il silenzio più totale. Nessuno parlava con me, mi passavano tutti accanto come se avessero da fa-re chissà cosa. In realtà, l'ho capito soltanto più tardi, avevano semplicemente paura. Come fai a dire a un bambino che il suo eroe, il mito della sua vita se ne è andato via per sempre, senza nemmeno salutarlo?
L'unica che mi sfiorò la guancia fu Melodie, la ragazzina che abitava accanto alla mia villetta. Io mi ero innamora-to delle sue trecce rosse e delle lentiggini che le colo-ravano il naso come minuscoli granelli di sabbia. Quella carezza che chiuso nel mio dolore feci finta di ignorare, in realtà rimase per sempre nel mio cuore. Con lei non avevo bisogno di fare molti discorsi, ci capivamo al volo. La mattina percorrevamo la strada che ci separava da scuo-la raccontandoci i sogni della notte e progettando un fu-turo in cui lei avrebbe fatto l'astronauta e avrebbe cura-to il mondo dall'eccessivo caldo e io invece sognavo di costruire dighe. Amavo l'acqua, papà mi aveva insegnato a nuotare nel fiume vicino casa, un posto perfetto per tro-vare ristoro dal caldo estivo e per dare il primo bacio. A dodici anni avevo baciato Melodie sulle labbra, nascosti nell'ombra degli alberi che percorrevano il greto del fiu-me. L'acqua che scorreva, le cicale, tutto mi sembrava perfetto per coronare il nostro sogno d'amore. In realtà non c'era piaciuto poi tanto. Eravamo scoppiati a ridere, promettendo che ci avremmo riprovato verso i quindici an-ni, come Bob McPherson e Stella che ormai facevano coppia fissa. Quella sera ero tornato a casa fischiettando. Papà capì subito, mi schiacciò l'occhio e disse semplicemente:
- Il mio ragazzo sta crescendo. -
Non ricordo un rimprovero senza motivazione o un muso lun-go. Ogni marachella era seguita da un lungo e sereno con-fronto. In casa si parlava tantissimo perché papà diceva che sono le parole e le risate a far muovere il mondo.
E adesso? Dove erano finite quelle risate, la voglia di stare fuori a guardare le stelle, masticando un filo d'erba e sognando un mondo in cui tutti erano felici. Mio padre aveva un sogno: regalare all'umanità la speranza. Per lui sperare era il sinonimo di vivere perché era l'unico sentimento a farti alzare la testa anche nei pe-riodi più bui per guardare cosa c'era dietro l'angolo. Per me, dietro quell'angolo, non esisteva più nulla. Era tutto sparito così all'improvviso. Mia madre non la vidi per tre giorni. Chiusa in camera sua, piangeva e sospirava, con Richard che stavolta cercava di alleviare i suoi mali e non più quelli di papà.
Quei giorni mi cambiarono letteralmente la vita ma anche i pensieri. Come un serpente muta pelle, io uscii di corsa dall'ingenuità della mia infanzia e abbandonai lo skate e i sorrisi a favore di un tarlo che mi rodeva l'anima e al quale non sapevo dare un nome. C'è stato un momento in cui ho incolpato tutti della morte di papà, soprattutto Ri-chard e mia madre. Quella cura sconosciuta nella mia testa aveva accelerato la fine, lo aveva strappato dalle mie braccia. Non volevo vedere le lacrime di mia madre, igno-ravo il suo dolore. Lei era sempre stata il sottofondo della mia vita, la cornice di un contesto in cui papà era l'unico protagonista. Lui mi aveva insegnato ad andare in bicicletta, a rialzarmi fiero dopo una caduta, a giocare a calcio, a rimanere in equilibrio su un piede. A lui aveva confidato le prime cotte, con lui avevo trascorso i fine settimana in campeggio per provare alla mamma che eravamo veri uomini.
Il giorno del funerale passai in garage e vidi la sua can-na da pesca. Giaceva abbandonata su uno scaffale, sembrava senza anima, quasi sofferente. La spezzai in due, con la rabbia dei miei quattordici anni. Fu in quel momento che decisi che io mio padre me lo sarei ripreso, sfidando il tempo, lo spazio e la morte stessa.
Giuseppe Spampinato
Biblioteca
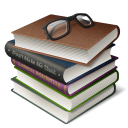
|
Acquista

|
Preferenze

|
Contatto

|
|
